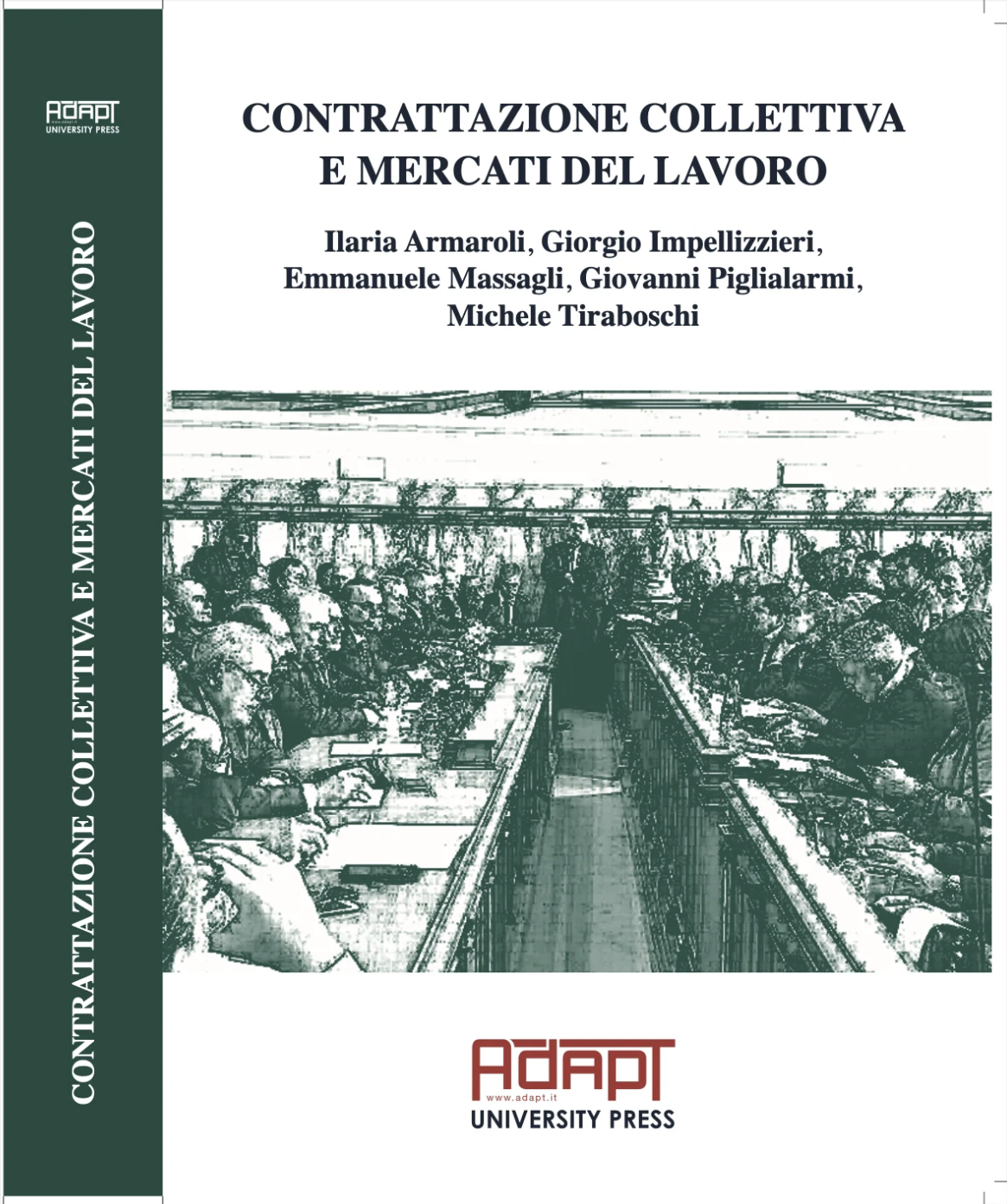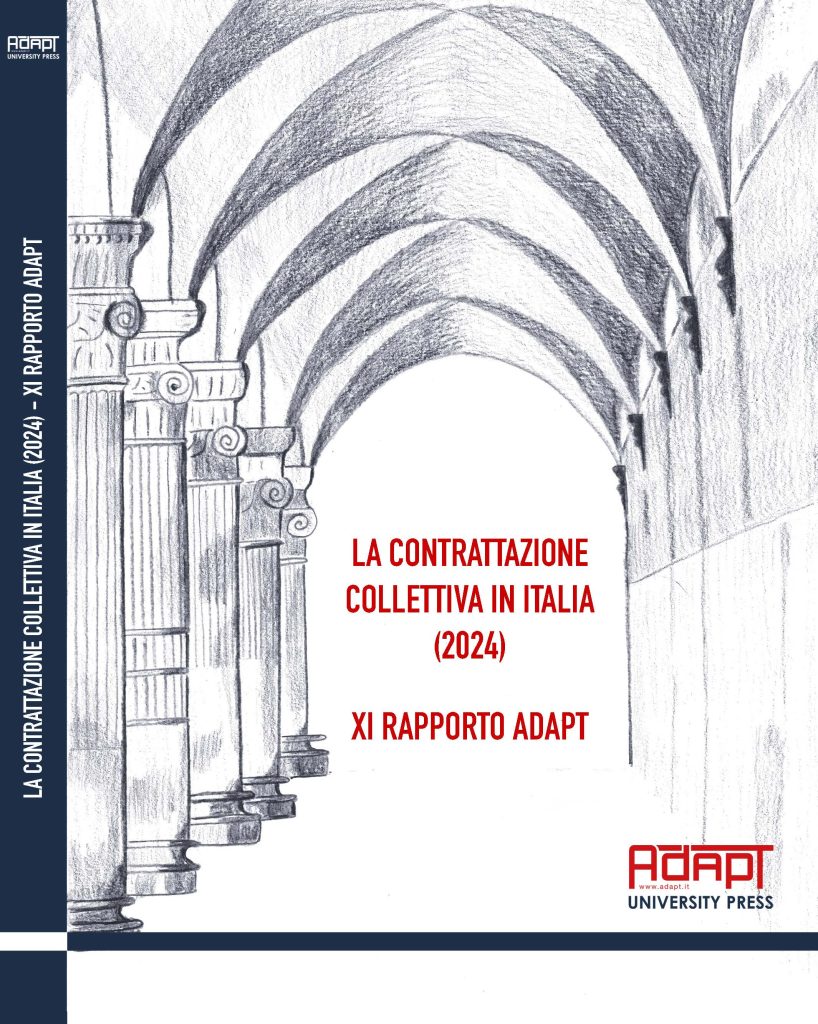Bollettino ADAPT 1 settembre 2025, n. 29
La contrattazione collettiva riveste un ruolo cruciale nell’attuazione del pilastro sociale europeo, garantendo standard minimi di protezione e condizioni lavorative uniformi all’interno dei diversi settori produttivi. Tuttavia, le crescenti pressioni competitive e le trasformazioni economiche degli ultimi anni hanno messo sotto pressione questo sistema, spingendo molte imprese a ricercare forme di maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro. In particolare, la necessità di contenere i costi del lavoro e di adattare rapidamente le condizioni contrattuali alle specifiche esigenze aziendali ha portato all’emergere di strategie sempre più sofisticate per modificare o eludere i vincoli previsti dai contratti collettivi nazionali.
Questo fenomeno si è manifestato con particolare intensità in Italia, dove il sistema di relazioni industriali si è storicamente caratterizzato per una copertura pressoché universale dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e per la presenza di minimi salariali spesso rigidi e uniformi su tutto il territorio nazionale. La tensione tra le esigenze di flessibilità delle imprese e i vincoli del sistema di contrattazione tradizionale ha dato origine a strategie di adattamento e opt-out, attraverso le quali le imprese cercano di riconfigurare o eludere le regole del modello contrattuale centralizzato per ottenere condizioni più “vantaggiose”. Un nuovo studio di Dustmann e coautori offre una prospettiva empirica su questo fenomeno, analizzando due importanti episodi di trasformazione del sistema contrattuale tradizionale verificatisi in Italia e i loro effetti sui lavoratori e sulle imprese coinvolte.
Il contesto istituzionale italiano
L’Italia rappresenta un laboratorio ideale per studiare gli effetti dell’opt-out dal sistema di contrattazione collettiva tradizionale. Il modello italiano si caratterizza per una copertura universale dei CCNL, che stabiliscono minimi retributivi vincolanti per ogni settore e categoria professionale. Questi accordi, tipicamente della durata di tre anni, sono negoziati dalle principali confederazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) e le associazioni datoriali di settore. La rigidità del sistema è oggetto di crescenti critiche, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, dove i minimi salariali nazionali spesso superano i livelli di produttività locale, contribuendo – secondo alcuni osservatori – alle persistenti difficoltà occupazionali dell’area.
Lo studio si focalizza su due fenomeni distinti di opt-out, espressione delle strategie adottate da alcune imprese italiane per eludere le rigidità della contrattazione collettiva tradizionale. Il primo riguarda l’uscita coordinata di 56 grandi aziende del settore della grande distribuzione dall’associazione datoriale Confcommercio. Queste imprese, raggruppate in Federdistribuzione (che comprende nomi noti come Ikea, Zara e Carrefour), nel 2011 hanno deciso di abbandonare il contratto collettivo del commercio per negoziare un accordo separato che, pur mantenendo il coinvolgimento delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, garantisse maggiore flessibilità negli orari di apertura e condizioni lavorative più adattabili alle esigenze della grande distribuzione.
Il secondo fenomeno analizzato è l’adozione dei cosiddetti “contratti pirata”, una forma più radicale di uscita dalla contrattazione centralizzata in cui singole imprese abbandonano i CCNL sottoscritti dalle federazioni sindacali afferenti alle confederazioni maggiormente rappresentative (CGIL, CISL e UIL) per applicare accordi stipulati da sindacati minori che offrono condizioni salariali e di lavoro al ribasso. Questi contratti sfruttano un vuoto normativo nell’ordinamento italiano: poiché la legge non definisce esplicitamente cosa costituisca un contratto “rappresentativo”, le imprese possono eludere i CCNL principali applicando accordi meno tutelanti. Come mostrano i dati presentati nello studio, il fenomeno è cresciuto rapidamente dopo la Grande Recessione, raggiungendo nel 2019 circa mezzo milione di lavoratori, pari al 3% dell’occupazione nel settore privato.
Metodologia e dati
La ricerca si basa su una fonte di dati eccezionalmente ricca: gli archivi amministrativi dell’INPS, che coprono l’universo dei rapporti di lavoro del settore privato italiano dal 2005 al 2019. Una caratteristica unica di questi dati è la possibilità di identificare, per ogni rapporto di lavoro, lo specifico contratto collettivo applicato, permettendo così di tracciare con precisione i cambiamenti contrattuali a livello di singola impresa e lavoratore.
La sfida metodologica principale consiste nell’isolare l’effetto causale dell’opt-out dai molti altri fattori che possono influenzare simultaneamente salari e occupazione. Le imprese che decidono di abbandonare i CCNL più rappresentativi potrebbero infatti differire sistematicamente da quelle che vi rimangono fedeli, rendendo difficile attribuire le differenze osservate negli outcomedei lavoratori al solo cambiamento contrattuale. Per superare questo problema, gli autori utilizzano un disegno di ricerca “difference-in-differences”, che confronta l’evoluzione nel tempo degli outcome dei lavoratori interessati dall’opt-out con quella di un gruppo di controllo di lavoratori simili rimasti sotto i contratti “tradizionali”. Questo approccio permette di controllare sia per le differenze fisse tra i due gruppi sia per i trend temporali comuni, isolando così l’effetto specifico del cambiamento contrattuale. Per garantire la comparabilità tra gruppo di trattamento e gruppo di controllo, viene utilizzato un algoritmo di matching basato su propensity score che considera caratteristiche individuali come età, anzianità, genere, tipo di contratto e salari precedenti, oltre a caratteristiche dell’impresa e della regione di lavoro.
I risultati principali su salari e occupazione
I risultati dello studio confermano l’esistenza di una relazione inversa tra salari e occupazione. In entrambi gli episodi analizzati, nonostante le diverse modalità di implementazione, l’uscita dal sistema contrattuale tradizionale porta a una riduzione delle retribuzioni e allo stesso tempo a un aumento generale dell’occupazione.
Nel caso della grande distribuzione, i lavoratori delle imprese che hanno abbandonato il contratto Confcommercio sperimentano una contrazione dei salari rispetto al gruppo di controllo che nel lungo periodo risulta pari al 3-4%. È importante precisare che questa differenza non nasce da tagli diretti: nei primi anni dopo l’opt-out del 2011 non emergono infatti differenze salariali significative; il gap si manifesta a partire dal 2015, quando i lavoratori delle imprese rimaste nel sistema tradizionale (CCNL Confcommercio) beneficiano di aumenti retributivi a seguito del rinnovo contrattuale, che dunque non vengono applicati ai lavoratori delle imprese Federdistribuzione. Nel 2019, quando le imprese Federdistribuzione adeguano i livelli retributivi a quelli previsti dal contratto Confcommercio, si osserva un parziale recupero. Allo stesso tempo, per i lavoratori delle imprese Federdistribuzione, si registra un incremento della probabilità di rimanere occupati di circa 4 punti percentuali. Questo effetto, secondo quanto mostrato dalle evidenze dello studio, si manifesta principalmente attraverso una riduzione dei licenziamenti.
Nel caso dei contratti pirata, i lavoratori coinvolti subiscono una riduzione salariale media del 2,5%, questa volta più immediata e riconducibile all’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da sindacati minoritari, caratterizzati da livelli retributivi inferiori rispetto ai CCNL principali. A differenza del caso Federdistribuzione, dove il divario retributivo rispetto al gruppo di controllo si è generato nel tempo per effetto degli aumenti contrattuali applicati solo alle imprese rimaste nel CCNL Confcommercio, nei contratti pirata il “vantaggio economico” per le imprese è immediato, derivando da un differenziale salariale esplicito e strutturale già presente al momento della stipula dell’accordo alternativo. Anche in questo caso, si registra un aumento della probabilità di occupazione di circa 3 punti percentuali, principalmente dovuto a una minore incidenza dei licenziamenti, segno che le imprese utilizzano l’opt-out come strumento per trattenere la forza lavoro a costi più contenuti.
Dal punto di vista delle imprese, l’analisi mostra che l’adozione di contratti pirata porta a una riduzione dei costi del lavoro del 3% e a un aumento della probabilità di sopravvivenza dell’impresa di circa 4 punti percentuali nei primi due anni successivi all’opt-out.
La dimensione geografica
Uno degli aspetti più rilevanti emersi dallo studio è la marcata eterogeneità geografica degli effetti dell’opt-out. In particolare, nelle regioni del Sud Italia, dove peraltro viene rilevata una maggiore concentrazione di contratti pirata rispetto alle altre aree territoriali, le conseguenze per i lavoratori sono particolarmente negative, mentre nel Centro-Nord risultano più attenuate.
Nel Nord Italia, i lavoratori coinvolti nell’opt-out sperimentano riduzioni salariali relativamente contenute (-1,6% per i contratti pirata), insieme a un effetto positivo sull’occupazione (attribuibile al calo dei licenziamenti). Nelle regioni del Sud, invece, la contrazione dei salari è molto più marcata (-5,1% per i contratti pirata) e non si registrano effetti positivi sul fronte occupazionale.
Questa eterogeneità geografica è particolarmente evidente nell’analisi delle cause di cessazione dei rapporti di lavoro. Nel Nord Italia, l’uscita dal modello contrattuale tradizionale porta a una significativa riduzione dei licenziamenti, mentre i tassi di dimissioni volontarie rimangono stabili. Nel Sud, al contrario, non si osserva una riduzione dei licenziamenti e si registra invece un aumento delle dimissioni volontarie, probabilmente in risposta alle maggiori riduzioni salariali.
Interpretazione teorica: il modello di monopsonio
Gli autori interpretano questi risultati attraverso un modello teorico di monopsonio che evidenzia come gli effetti dell’opt-out dipendano dal grado di concorrenza nei mercati del lavoro locali. La differenza fondamentale tra Nord e Sud Italia risiede proprio in questa dimensione: le imprese settentrionali operano in mercati del lavoro relativamente competitivi, mentre quelle meridionali si trovano in contesti caratterizzati da scarsa concorrenza che conferisce ai datori di lavoro significativo potere di monopsonio.
Nel Nord, dove i mercati del lavoro sono maggiormente competitivi, l’opt-out contrattuale si traduce in una moderata riduzione dei salari e in una tenuta dei livelli occupazionali, secondo una dinamica coerente con i modelli teorici che descrivono gli effetti della rimozione di un vincolo salariale in contesti concorrenziali. In questo caso, le imprese tendono a trattenere il personale approfittando della maggiore convenienza del lavoro a salari ridotti, senza tuttavia che ciò implichi un reale miglioramento delle condizioni occupazionali. Al contrario, nelle regioni del Sud, dove le imprese detengono potere di mercato per via della scarsa concorrenza tra datori di lavoro, l’elusione dei vincoli contrattuali consente di abbassare i salari, il che scoraggia l’offerta di lavoro, portando quindi a una riduzione dell’occupazione.
Osservazioni conclusive
Lo studio analizza due fenomeni di trasformazione del sistema di contrattazione collettiva in Italia: l’accordo separato di Federdistribuzione e i cosiddetti contratti pirata. Sebbene entrambi rappresentino strategie per ottenere maggiore flessibilità contrattuale, essi si differenziano significativamente nelle loro modalità di attuazione: l’accordo Federdistribuzione mantiene il coinvolgimento delle confederazioni sindacali rappresentative caratterizzandosi più come una riconfigurazione interna al sistema centralizzato; i contratti pirata, invece, costituiscono una vera e propria uscita dal perimetro della contrattazione rappresentativa. L’analisi empirica, basata su dati INPS e su una solida metodologia di identificazione causale, mostra che queste strategie comportano effetti negativi per i lavoratori, soprattutto sul piano retributivo e in particolare per i lavoratori residenti nelle regioni del Sud Italia.
Oltre a produrre effetti dannosi per i lavoratori e a contribuire all’erosione delle tutele di questi ultimi, i fenomeni di opt-out, e nello specifico la contrattazione pirata, rischiano di compromettere la stabilità e la tenuta del sistema di contrattazione nel suo complesso. L’uscita dal modello contrattuale centralizzato mina infatti la capacità del sistema stesso di garantire condizioni lavorative adeguate a tutti i lavoratori e di esercitare una funzione ordinatrice nei rapporti di lavoro. In assenza di criteri chiari sulla rappresentatività dei soggetti stipulanti, il ricorso a contratti alternativi può incentivare pratiche opportunistiche da parte delle imprese e alimentare una dinamica di concorrenza al ribasso, con effetti distorsivi sia sul piano retributivo che su quello della qualità del lavoro. In questo scenario, la contrattazione collettiva rischia di perdere progressivamente il proprio ruolo di strumento centrale di regolazione e tutela, a favore di un assetto sempre più frammentato, instabile e diseguale.
ADAPT Research Fellow

 @_jacoposala
@_jacoposala