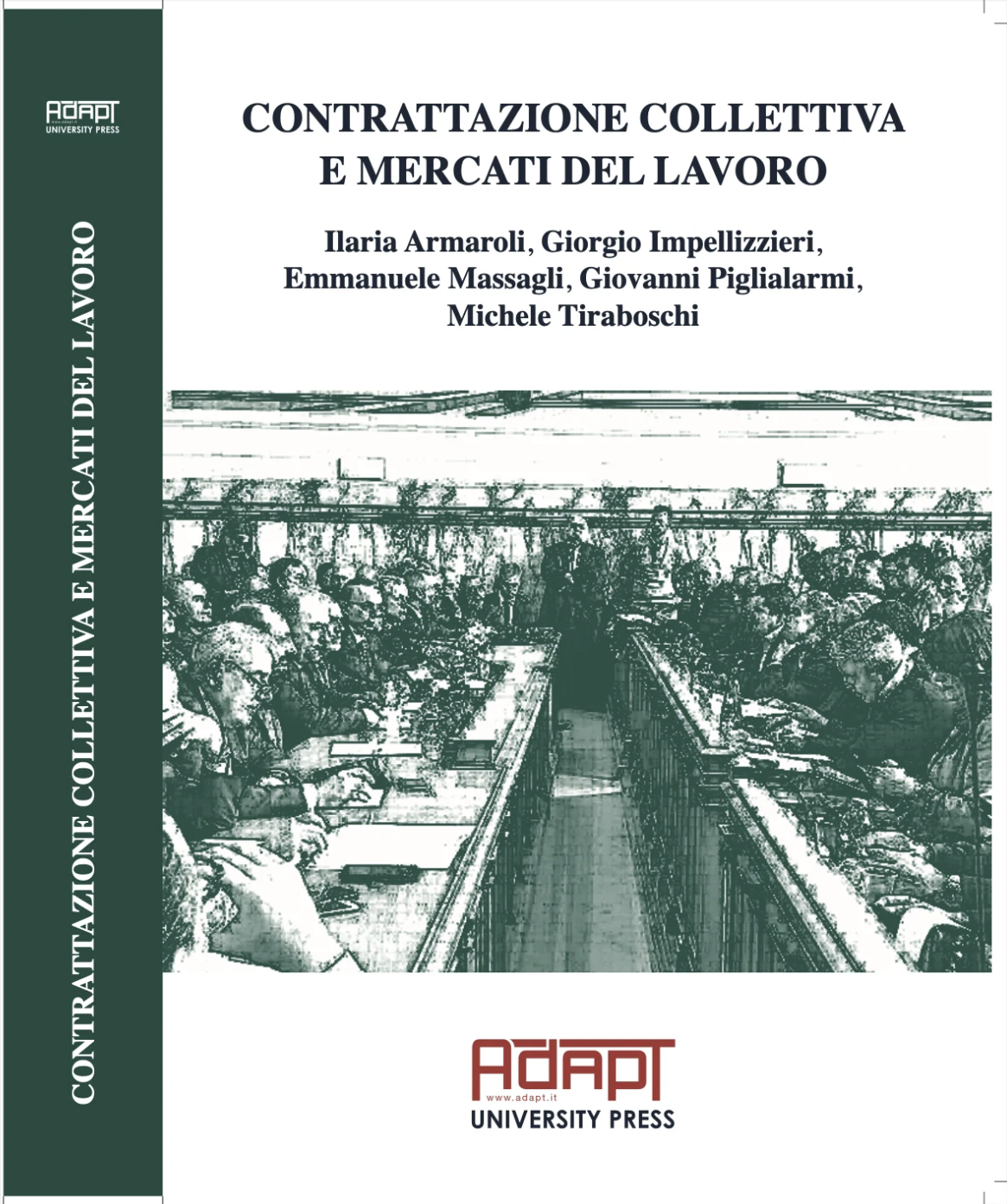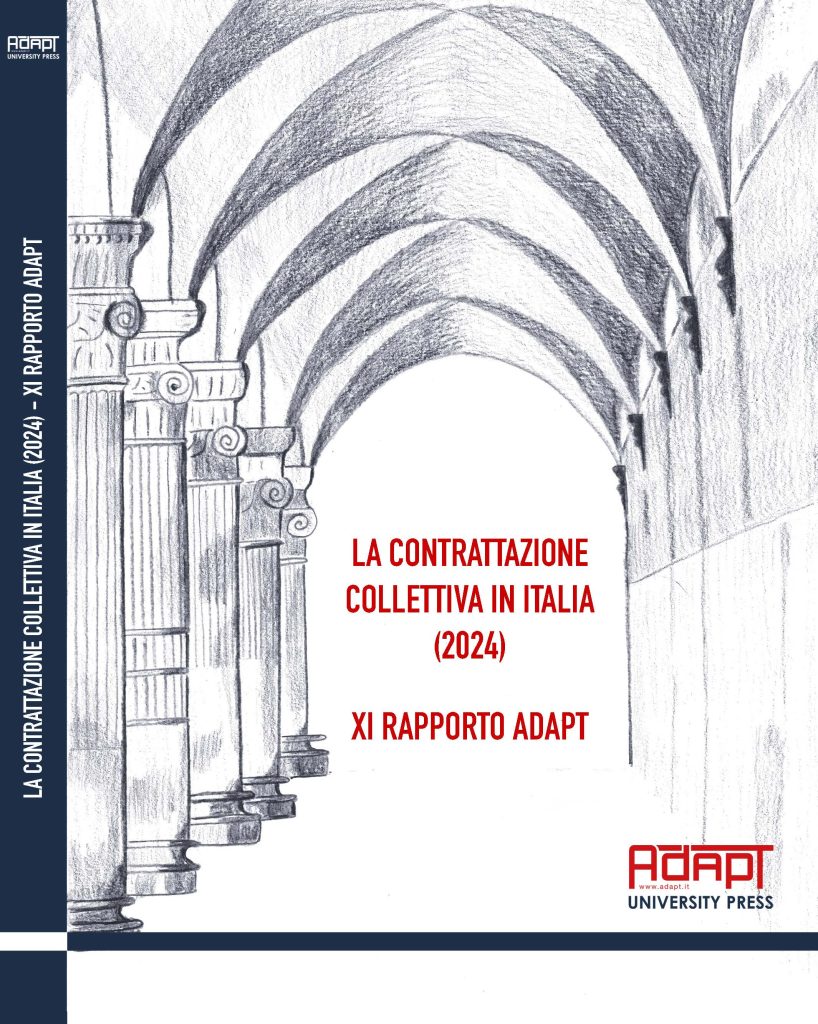Bollettino ADAPT 2 settembre 2024 n. 30
A differenza del panorama italiano, in cui la contrattazione c.d. “multi-datoriale” di settore è fortemente sviluppata, nel Regno Unito, sin dagli anni ’80 si è assistito ad un decentramento della contrattazione collettiva. Si è giunti, dunque, ad una situazione in cui la contrattazione di settore è tendenzialmente scomparsa e si è creato un mercato del lavoro altamente individualizzato con uno scarso ruolo dei sindacati.
All’interno del contributo Introducing sectoral bargaining in the UK: why it makes sense and how it might be done, Keith Sisson, professore emerito di Relazioni industriali presso l’Università di Warwick si dedica all’analisi di un potenziale reinserimento della contrattazione settoriale nel Regno Unito e ai benefici che questa comporterebbe sia per i sindacati che per le associazioni dei datori di lavoro. Nella seconda parte del suo contributo, si affrontano invece le questioni che sarebbe necessario risolvere nel caso in cui il Regno Unito riuscisse ad introdurre la contrattazione settoriale.
I benefici dell’introduzione di una contrattazione di settore
Il contributo prende le mosse dalla circostanza che i lavoratori inglesi avrebbero perso molto a causa del declino della contrattazione settoriale e della regolamentazione congiunta: un esempio sono gli aumenti salariali inferiori all’inflazione e la maggiore insicurezza dei rapporti di lavoro. È però interessante osservare come anche i datori di lavoro risultino impoveriti dallo scarno ruolo della contrattazione di settore, avendo ottenuto non tanto la flessibilità contrattuale sperata, quanto piuttosto una maggiore rigidità giuridica. In mancanza di accordi settoriali, infatti, è stato necessario introdurre una serie di tutele legali per la gestione dei rischi, ma non sempre soluzioni uniformi nel panorama nazionale risultano efficaci in contesti lavorativi fortemente differenziati.
È essenziale tenere a mente che quando si parla di contrattazione collettiva, non ci si riferisce al solo salario, ma a una regolamentazione congiunta di diverse questioni, come il coinvolgimento dei dipendenti, la formazione e lo sviluppo del personale, la disciplina del licenziamento e tanto altro. Sisson si dedica all’approfondimento dei benefici dello sviluppo della contrattazione di settore. Secondo l’autore, ci sono due ragioni principali per cui gli accordi settoriali devono essere preferiti alla regolamentazione legale: la prima è il maggiore coinvolgimento dei lavoratori e la seconda è la capacità della contrattazione collettiva di adeguarsi alle peculiarità dei singoli ambiti e settori.
La contrattazione di settore andrebbe preferita alla regolazione unilaterale aziendale, inoltre, perché per i datori di lavoro vi è un notevole risparmio sui costi di gestione delle relazioni di lavoro.
Sulla base dell’analisi dell’autore, un approccio di settore permetterebbe di uniformare le condizioni di lavoro delle aziende di un determinato ambito e di evitare che si crei una ricchezza fondata su salari bassi e cattive condizioni per i lavoratori. Questo approccio va a vantaggio sia dei sindacati che delle organizzazioni datoriali. Queste ultime, infatti, acquisirebbero un ruolo di intermediario, consentendo a tutte le aziende rappresentate e non solo alle grandi realtà, di partecipare ai processi di definizione delle politiche sul lavoro a livello nazionale.
Peraltro, i benefici del coinvolgimento dei rappresentanti sindacali e datoriali sono stati riconosciuti anche nel rapporto dell’OCSE, Global Deal report, Social Dialogue, Skills and Covid-19 (2020), in cui si afferma che il dialogo sociale è stato fondamentale per affrontare i danni causati dalla pandemia. La contrattazione settoriale migliora, infatti, la qualità delle decisioni rendendole più coerenti con la specifica problematica. Un confronto costante con le organizzazioni rappresentative migliora la comprensione dei problemi e permette, all’insorgere di una crisi, di trovare un maggiore consenso e una maggiore apertura ad una soluzione condivisa.
All’interno del suo elaborato, Sisson elenca anche quelli che potrebbero essere i vantaggi degli accordi di settore a livello macroeconomico, ovvero:
1. un migliore bilanciamento fra salari, inflazione, livelli di disoccupazione e tassi di crescita economica. Sempre secondo l’OCSE (in Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work del 2019): “(…) il coordinamento aiuta le parti sociali a tenere conto della situazione del ciclo economico e degli effetti macroeconomici degli accordi salariali sulla competitività. Il livello effettivo di centralizzazione è un’altra dimensione cruciale: i sistemi in cui il decentramento è organizzato e coordinato dal centro (cioè sistemi in cui gli accordi a livello settoriale stabiliscono ampi quadri normativi ma lasciano le disposizioni di dettaglio alle negoziazioni di livello aziendale e dove il coordinamento è piuttosto forte) tendono a produrre buone performance occupazionali e una maggiore produttività”;
2. minori disuguaglianze. L’OCSE prende come riferimento tre misure per i confronti internazionali sulle disuguaglianze: la dispersione dei redditi (in base alla quale per salario basso si intende un salario inferiore di due terzi rispetto al salario orario mediano e per salario alto si considera quello che supera di 1,5 volte il salario orario mediano); il coefficiente di Gini (che condensa la distribuzione del reddito disponibile fra le famiglie in un numero compreso fra zero e uno; più alto il numero, maggiore la disuguaglianza); il c.d. “gender wage gap” misurato come differenza tra i guadagni mediani di uomini e donne rispetto ai guadagni mediani degli uomini. Con riferimento a tutte e tre le misure, la disuguaglianza risulta maggiore nel Regno Unito e negli Stati Uniti rispetto agli altri paesi OCSE, e ciò probabilmente è legato ad un maggiore decentramento (disorganizzato) della contrattazione collettiva. È emerso, infatti, che maggiori densità sindacale e centralizzazione/coordinamento della contrattazione salariale sono direttamente proporzionali ad una minore disuguaglianza salariale complessiva.
Contrattazione settoriale nel Regno Unito – Come introdurla
Sisson parte da un punto di attualità nel Regno Unito, ossia l’impegno da parte del Labour Party di introdurre un accordo nel settore socio-sanitario, ad oggi incapace di assolvere ai suoi compiti essenziali a causa di numerose questioni, tra cui l’assetto composto sia dal settore pubblico (NHS) che da servizi privati, problemi nell’assunzione e nel mantenimento della forza lavoro.
Nonostante il Labour Party mostri cautela verso il sostegno alla contrattazione di settore per l’intera economia del Regno Unito, questa è ritenuta particolarmente necessaria nella cosiddetta “foundational economy”, ovvero quella parte di economia composta da settori non competitivi e al di fuori della concorrenza internazionale (es.: assistenza all’infanzia, servizi di pulizie, logistica). Di particolare importanza è la struttura di questi settori, costituiti principalmente da piccole e medie imprese (PMI) costrette a contrattare individualmente, che quindi beneficerebbero grandemente dall’introduzione di un accordo di settore capace di abbattere i costi di transazione. Tuttavia, la debolezza delle parti datoriali nel settore è fonte di preoccupazione, rispetto alla quale accordi tripartiti (con il coinvolgimento del governo) potrebbero essere risolutivi.
Istituzioni principali
La proposta ha come punto di partenza i Wages Council e i contratti già consolidati, e la responsabilità statutaria di avviare le procedure spetterebbe al Segretario di Stato. Dopo la consultazione delle parti, egli dovrebbe quindi istituire un National Joint Council (NCJ) qualora “non esistesse una contrattazione collettiva efficace a livello settoriale; o la contrattazione collettiva presente nel settore non sia sufficiente a stabilire termini e condizioni minimi per l’intero settore in relazione alle materie obbligatorie”. Tale consiglio sarebbe composto da un pari numero di rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro e in cui il Segretario di Stato potrebbe decidere se inserire dei membri indipendenti con diritto di voto con il compito di conciliatori in caso di stallo delle negoziazioni. L’importanza degli accordi tripartiti rimarrebbe la stessa.
Gli accordi settoriali come codici anziché contratti
Sisson ricostruisce la storia del quadro giuridico riguardante le relazioni industriali, affermando che il declino della contrattazione collettiva in Regno Unito si riconduce spesso alla mancanza di contratti giuridicamente vincolanti, obbligari solo a livello d’onore e non come codici statutari in un contesto di common law. Tuttavia, di fatto non c’era nessun ostacolo per le parti sociali nel rendere i contratti negoziati legalmente vincolanti, quanto piuttosto una mancanza di volontà delle stesse parti e un’incompatibilità di linguaggio (a questo proposito la Royal Commission on Trade Union and Employers’ Associations argomentava che per essere codificati, essi avrebbero dovuto essere stati riscritti con l’ausilio di un avvocato professionista). Invero, la maggioranza della Commissione ha respinto le proposte di rendere giuridicamente vincolanti i contratti collettivi non tanto per motivi di principio, quanto piuttosto adducendo come causa la concretezza della contrattazione collettiva nel Regno Unito.
Dunque, oggi, per quanto riguarda la legislazione necessaria per introdurre la contrattazione settoriale, il suggerimento è di rendere gli accordi di settore dei contratti giuridicamente vincolanti, in forma di “Good Work sector Agreements”, e attuati, ad esempio, dagli stessi organismi governativi che vigilano sulle normative nazionali, come avviene in Irlanda e in Nuova Zelanda. A sostegno di tale proposta, si suggerisce l’introduzione di un nuovo sistema di Tribunale del Lavoro, articolato in più livelli, con giurisdizione esclusiva per trattare tutte le questioni relative al lavoro. Le criticità emerse per questa ipotesi riguardano i numerosi problemi di adattamento del quadro legislativo: difatti, la stessa Royal Commission afferma che il modello di common law britannico richiederebbe il lavoro congiunto di esperti di relazioni sindacali e di avvocati.
Per questi motivi, sono esplorate nel testo altre ipotesi, fra cui la possibilità di rendere l’accordo di settore un ‘Order’, il mancato rispetto del quale costituirebbe un reato, legittimando così i lavoratori a presentare una richiesta civile in caso di mancato pagamento delle tariffe appropriate; ovvero, consentire al Segretario di Stato di proporre alle parti sociali di trasformare il proprio accordo di settore in un Codice di Condotta dell’Acas, ente pubblico che fornisce servizi di consulenza, conciliazione e mediazione fra le parti sociali. È indubbio, d’altronde, che questo approccio richiederebbe minori aggiustamenti al quadro legislativo, avendo inoltre il vantaggio di far esprimere i contratti di settore nel linguaggio delle relazioni sindacali e di non richiedere il supporto di un avvocato, oltre a promuovere e condividere le relazioni industriali stesse, nonché le best practices con ruolo educativo fondamentale nell’aiutare le imprese a rimanere aggiornate sulle sfide di settore.
Se, da un lato, chiarisce Sisson, è chiaro che la scelta di un percorso rispetto a un altro dipenderà da come il governo vorrà promuovere gli accordi settoriali in termini di obiettivi e finalità, dall’altro è evidente che, qualunque sia il percorso scelto, vi sia la necessità di istituire un’autorità pubblica che controlli la legittimità degli accordi settoriali.
Il principio di equità
All’interno del documento, il principio di equità (fairness) assume un ruolo centrale, soprattutto riguardo alla priorità da attribuire al “lavoro equo” rispetto alla “paga equa”. Questo principio si articola in due dimensioni: l’equilibrio tra sforzi e benefici e l’equità nelle decisioni che vengono prese. Il pericolo di concentrarsi sulla sola questione del salario è che, infatti, questioni come queste così come il dialogo sociale, vengono marginalizzate perché poco si prestano alla “negoziazione distributiva”. In aggiunta, ciò deteriorerebbe anche la situazione delle PMI in quanto si aumenterebbe in maniera significativa il costo del lavoro, portando a tagli del personale e un aumento del carico di lavoro sui dipendenti rimanenti.
Il contenuto degli accordi
Due sono quindi le tipologie di contenuti degli accordi descritti da Sisson se venisse inserita la contrattazione settoriale, considerando poi che argomenti specifici varierebbero da settore a settore:
– il lavoro equo, ripreso anche da Fair Work Tales, e in particolare le questioni relative a: giusta ricompensa; rappresentanza collettiva; sicurezza e flessibilità; possibilità di accesso; crescita e progresso; ambiente lavorativo sano e inclusivo; diritti sostanziali;
– la disciplina di questioni sostanziali come retribuzione, straordinari, pensioni e ferie, come riaffermato anche da una proposta del Trade Union Congress (TUC); aspetti procedurali e diritti dei lavoratori, come quello di informazione e consultazione.
È indubbio, però, afferma Sisson, che le proposte finali dovranno tenere in considerazione il rapporto fra i diversi livelli di contrattazione. Le preoccupazioni dell’autore riguardano principalmente il fenomeno della “decentralizzazione disorganizzata” che può verificarsi quando la contrattazione si sposta dal livello settoriale a quello aziendale senza alcun coordinamento tra i due livelli. Questo comporta infatti il rischio che l’autorità dell’accordo settoriale venga indebolita, soprattutto a discapito dei lavoratori nelle PMI, a causa delle deroghe, delle riforme e delle eccezioni previste a livello aziendale. Difatti, solo se avviene in maniera adeguata e dunque con un “decentramento organizzato”, caratterizzato da coordinamento fra i livelli, questa transizione può portare ad una situazione ideale in cui vengono affermate le condizioni minime a livello settoriale, senza il rischio che vengano messe in discussione nelle negoziazioni a livello aziendale.
A tal fine, il documento suggerisce la necessità che le stesse parti sociali sostengano lo sviluppo del dialogo sociale, in particolare attraverso una dichiarazione dell’obiettivo complessivo dell’accordo settoriale, dunque facendo esplicito riferimento alle questioni che l’accordo si propone di affrontare; ovvero l’organizzazione di incontri trimestrali del consiglio tripartito, con gruppi di lavoro congiunti che si occupino di ricercare e monitorare le principali criticità del settore, anche con l’ausilio di esperti e terze parti.
Per quanto riguarda invece il ruolo del governo nazionale guidato dai Labour, l’autore si rifà alle linee guida della Commissione Europea. Si richiama, in particolare, la necessità di:
– assicurare la consultazione delle parti sociali nella progettazione di politiche economiche e sociali;
– incoraggiare le parti sociali a prendere in considerazione nuove forme di lavoro;
– consentire alle organizzazioni datoriali e dei lavoratori di crescere, facendo in modo che abbiano le informazioni rilevanti e assicurando loro il supporto da parte del governo nazionale.
Promuovere la produttività
Afferma Sisson che, tuttavia, nelle discussioni sull’introduzione della contrattazione settoriale si è prestata poca o nessuna attenzione a come verranno finanziati i miglioramenti previsti in termini di salario e condizioni di lavoro, che ovviamente dipenderanno a seconda del settore. Ad esempio, nel settore socio-sanitario è probabile che i fondi possano arrivare direttamente dal governo nazionale nella forma di investimenti sulla forza lavoro. Diversamente, in altri settori, non essendo previsto alcun finanziamento a causa delle pressioni attese sulla spesa pubblica, si prevede che i finanziamenti potranno derivare dagli stessi profitti delle aziende. Tuttavia, anche in questo caso alcune aziende registreranno alcune criticità poiché ancora intrappolate nello schema di “bassa retribuzione, bassa qualificazione, bassa produttività”. Considerando, dunque, la limitata capacità di redistribuzione dai lavoratori più pagati a quelli meno pagati all’interno del settore, queste aziende avranno bisogno di aiuto per migliorare la loro produttività e performance, agendo non solo sull’eliminazione del basso salario ma incentivando tutta una serie di politiche coordinate e di sotto investimento e crescita.
In generale, si raccomanda al governo nazionale di modificare il suo modello di sviluppo economico investendo nell’innovazione e nella produttività della foundational economy, oltre a eliminare fattori che minano standard lavorativi dignitosi.
Conclusioni
Auspicando l’introduzione della contrattazione settoriale nel Regno Unito, Sisson analizza nel suo paper come questo possa concretamente attuarsi nel contesto politico-legislativo attuale britannico. È evidente, infatti, che questa transizione possa avvenire in un sistema di common law, in cui gli accordi sono di difficile codificazione, solo attraverso concrete misure a sostegno. Sisson raccomanda, inoltre, una visione più ampia del concetto di contrattazione settoriale, non basata esclusivamente sull’aumento dei salari ma piuttosto sul ‘fair work’, ossia l’insieme delle garanzie di cui deve godere il lavoratore (es.: formazione, sicurezza).
Nel contesto delineato, è quindi chiaro come la proposta dell’attuale Governo di introdurre la contrattazione settoriale nell’ambito socio-sanitario possa essere un trampolino di lancio per mettere in pratica le proposte illustrate dall’autore per migliorare non solo la contrattazione collettiva, ma anche, attraverso essa, le condizioni di quei settori appartenenti alla ‘foundational economy’.
Francesca Coluccia
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti
 francescaC3097
francescaC3097
Emanuele Ligas
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti
 @LigasEmanuele
@LigasEmanuele


 @BenincasaGiada
@BenincasaGiada