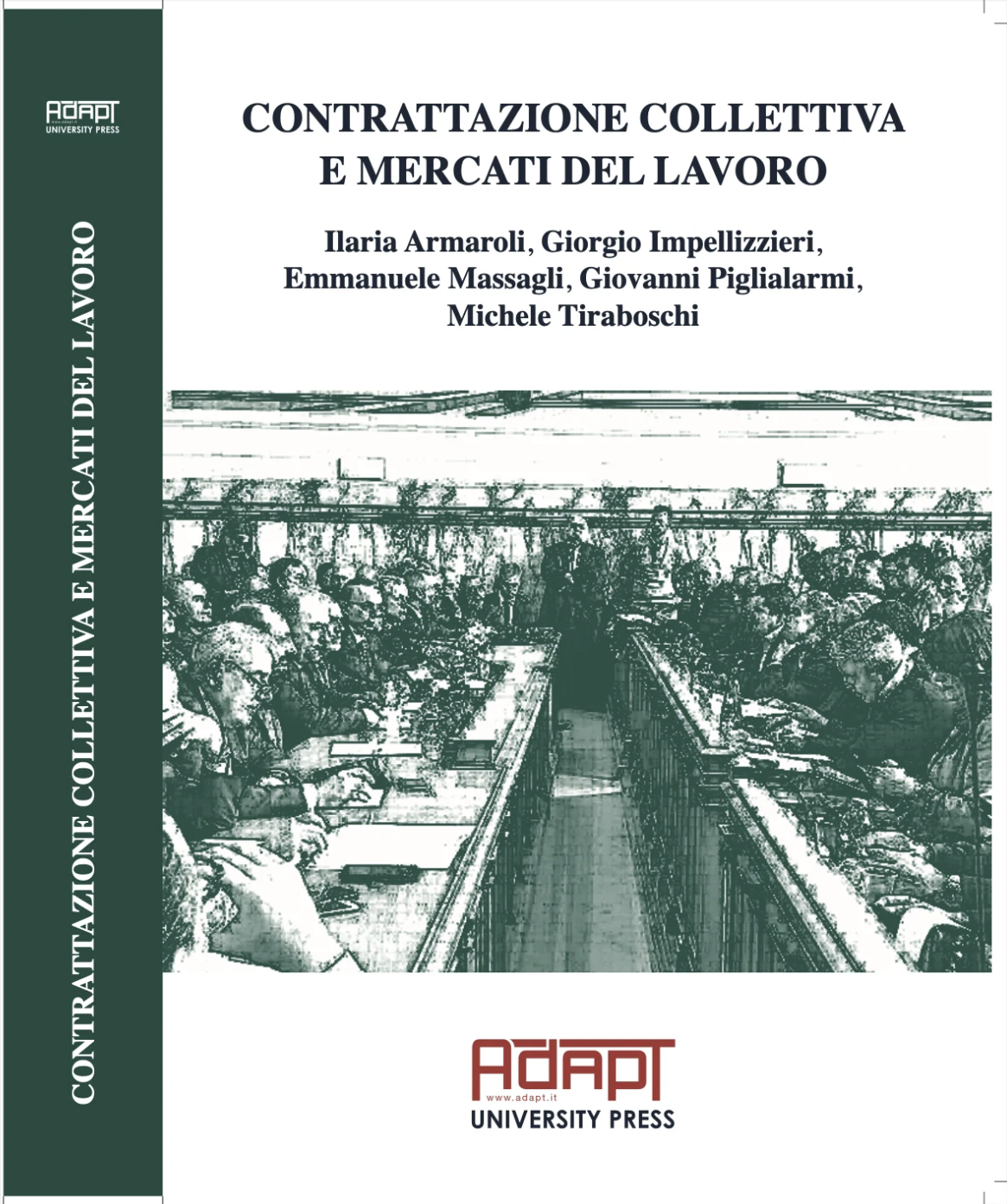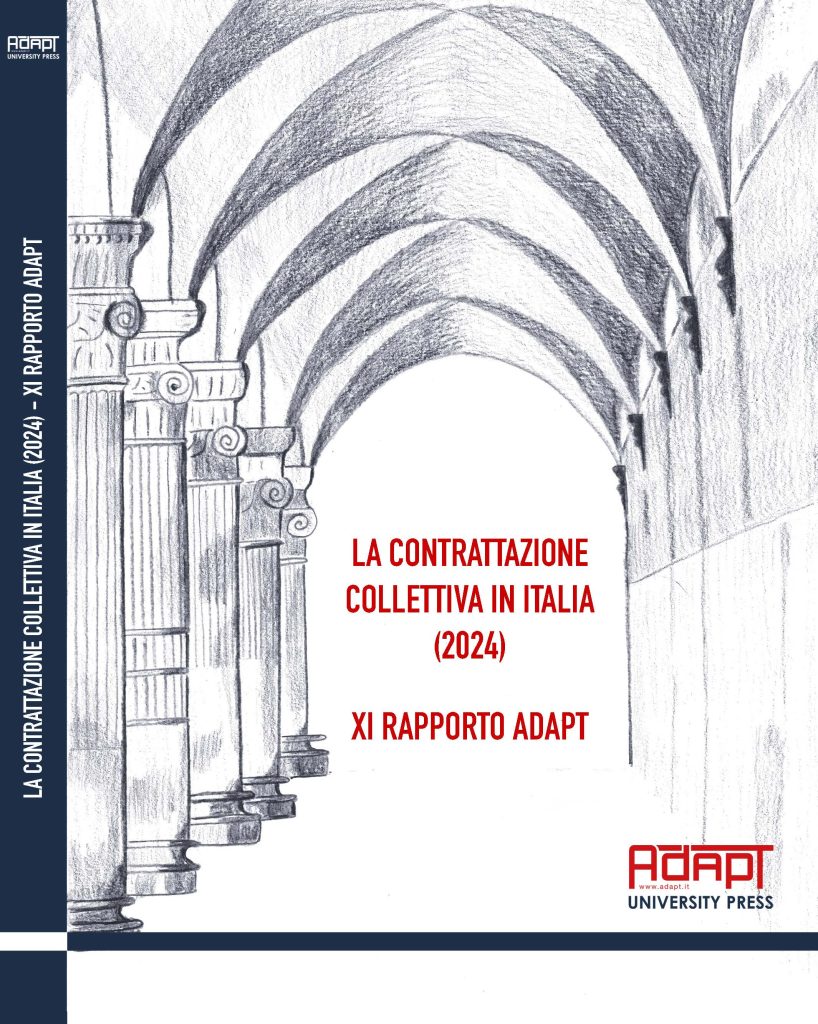Intersind e Asap: un’esperienza (forse) dimenticata troppo in fretta

Bollettino ADAPT 5 maggio 2025, n. 17
L’approvazione in prima lettura della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL in materia di partecipazione dei lavoratori ha il merito, tra gli altri, di riaprire la discussione sul ruolo dei corpi sociali intermedi come possibili agenti di modernizzazione non solo del rapporto Lavoro-Capitale ma dell’intera Costituzione economica del Paese. Non casualmente l’articolo 1 della proposta fa riferimento “all’allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese” e alla necessità di “rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, preservare e incrementare i livelli occupazionali e valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale”.
A fronte di tali ambiziosi obiettivi pare legittima la domanda se un processo di tale portata possa essere agito, se si come, dalle attuali organizzazioni di rappresentanza visto che si tratta di “attuare determinati obiettivi di sviluppo economico e di avanzamento sociale, […] agevolare il formarsi di un clima di positiva collaborazione in seno alle aziende […], creare le condizioni più opportune affinché la vita sindacale, pur nella dialettica ad essa propria, sia sensibile adeguatamente ai rapporti tra gli interessi particolari e di categoria, da una parte, e gli interessi generali, dall’altro canto”.
Corsi e ricorsi. Quelli sopra richiamati sono solo alcuni dei passaggi della lettera indirizzata l’8 giugno del 1962 (riportata integralmente in calce a questo scritto) dal democristianissimo Ministro delle Partecipazioni statali di allora, Carlo Bo, alle Aziende pubbliche. La missiva fu la logica conseguenza di una precisa scelta del Legislatore che, in una fase di profondo cambiamento della società e dell’economia del Paese, dispose, nell’ambito dell’istituzione del Ministero delle Partecipazioni Statali, il c.d. “sganciamento” (art. 3 legge n. 1589/1956) delle aziende a prevalente partecipazione dello Stato dalle organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro: nascevano in questo modo l’Intersind (Associazione sindacale datoriale delle Aziende del Gruppo Iri ed Efim) e l’Asap (Gruppo Eni).
In una fase di profondi mutamenti economici e sociali la politica scelse di avviare e poi sostenere il processo di riforma, correttamente percepito a quel tempo come ineludibile, agendo sulla rappresentanza delle Aziende pubbliche. In sorprendente analogia metodologica con la proposta Cisl (chiaramente improntata ad una logica promozionale ed incentivante “dal basso”) con la creazione delle rappresentanze datoriali pubbliche non si agì sul piano ordinamentale mediante interventi diretti sulla disciplina del mercato del lavoro ma si crearono i presupposti affinché il dialogo sociale potesse esprimersi, come si diceva allora, alla ricerca di “equilibri più avanzati”. Solo in un secondo momento il Legislatore avrebbe seguito a ruota, in diverse occasioni, con la c.d. “legislazione di sostegno”.
I frutti di quella stagione, che si esaurì agli inizi degli anni novanta, furono oggettivamente rilevanti.
Con il Protocollo del 5 luglio 1962 venne introdotta l’articolazione dei differenti livelli contrattuali (settoriali o aziendali) finalizzata all’attuazione concreta dei principi affermati ai livelli superiori e nacquero le c.d. clausole di tregua (nucleo della legge di regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici che interverrà quasi 30 anni dopo).
Con il primo rinnovo della metalmeccanica pubblica (1962) vennero disciplinati i “nuovi” diritti sindacali (affissione di comunicazioni, trattenuta dei contributi sindacali a mezzo di deleghe esplicite dei lavoratori, concessione di permessi orari retribuiti ai lavoratori membri di organi direttivi dei sindacati) gettando anche qui le basi di quello che diventerà poi lo Statuto dei lavoratori del 1970.
Nell’ambito di quel sistema maturò progressivamente il passaggio dai “diritti sindacali” alle tematiche ben più complesse delle “relazioni sindacali”: nel rinnovo della metalmeccanica pubblica del 1966 furono introdotte la comunicazione dell’azienda nei casi in cui l’attuazione di innovazioni tecnologiche comportasse conseguenze rilevanti per l’occupazione o per l’orario di lavoro e la possibilità di dare luogo a studi ed esami congiunti dei sistemi di classificazione del personale al fine della loro definizione e del loro perfezionamento nella naturale sede del rinnovo contrattuale.
Anche il tema della gestione del conflitto trovò una sintesi – dopo la lunga stagione della conflittualità permanente – con l’accordo del 22 gennaio 1983 che stabilì che «al fine di contribuire ad una rimozione delle cause di microconflittualità, le categorie potranno prevedere procedure aziendali di definizione di vertenze sulla applicazione dei contratti ed eventualmente di arbitrati collegati anche a pause di raffreddamento».
A ben vedere il sistema contrattuale di informazione, consultazione e regolamentazione del conflitto che nasce in quegli anni in seno al sistema di rappresentanza delle aziende “pubbliche” tende non solo alla mera determinazione di “regole del gioco” ma getta le basi per affrontare il tema del più complesso meccanismo di partecipazione concernente non la singola impresa ma lo stesso modello di impresa considerata nel più ampio quadro economico-istituzionale.
Quella lunga traiettoria culminò nel 1998 con l’unica vera, e probabilmente prematura visti gli esiti infelici, esperienza di azionariato dei dipendenti realizzata su larga scala mediante l’accordo quadro sulla partecipazione azionaria dei lavoratori delle società del gruppo Alitalia (Alitalia, Alitalia Team, Alitalia Express e Atitech). Attuata sulla base di due intese sindacali sottoscritte nel 1996 e nel 1998 venne concordata la sottoscrizione di azioni ordinarie al valore nominale per un ammontare complessivo di 520 miliardi finalizzata ad una partecipazione non inferiore al 20 per cento delle azioni ordinarie, la non trasferibilità delle azioni prima di tre anni dal momento dell’attribuzione e la gestione delle stesse da parte di un organismo ad hoc.
La stagione delle privatizzazioni degli anni novanta e la soppressione del (per molti) famigerato Ministero delle Partecipazioni statali che aveva generato (anche, ma non solo) inefficienti commistioni tra politica e gestione delle società pubbliche determinò la sottovalutazione del valore generato da quel sistema sul piano della costruzione di una moderna democrazia economica del Paese. Capita quando si getta via il bambino con l’acqua sporca.
Ma come sempre accade quando si esauriscono gli effetti di approcci giacobini, di qualsiasi natura essi siano, dopo la stagione della (giusta) stigmatizzazione ma anche della (strumentale) criminalizzazione di un intero sistema ne è seguita un’altra. L’insieme delle c.c. “partecipazioni statali” – modificato, smagrito e alleggerito dei famosi “panettoni di Stato della Sme” – è sopravvissuto con un modello alternativo di governo delle aziende strategiche partecipate dallo Stato basato su un corpus normativo articolato e complesso che, nei fatti, ne ha preservato in buona sostanza l’autonomia e l’efficienza manageriale oggi resa tangibile, in alcuni casi, anche dalle performances di borsa.
L’interrogativo al quale oggi occorre dare una risposta è quale contributo questo “ecosistema” di aziende possa offrire al Paese, sulla falsariga di quanto avvenuto nel secondo dopoguerra ma senza riprodurne le storture, in un contesto come quello attuale che vede il rapido aumento delle componenti critiche della competizione economica, commerciale (dazi ma non solo), tecnologica, energetica e, purtroppo, militare.
Se da un lato è vero che la natura globale dei trends in atto vede come principali protagonisti soggetti che hanno una percezione di sé come “imperiali” (Cina, USA, India, Russia) o aggregazioni sovranazionali di singole Nazioni – stabili (EU) o tattiche che siano (Cina-Russia) – ciò non esenta i singoli Paesi dalla necessità di una profonda riflessione sulla “messa in sicurezza” dei rispettivi sistemi Paese. La magnitudo dello scontro geopolitico in atto richiede infatti risposte capaci di mobilitare integralmente, velocemente ed in coerenza con l’indirizzo politico le migliori articolazioni economiche e sociali a sostegno della crescita economica, della competitività delle imprese e della loro produttività salvaguardando i livelli salariali e difendendo la coesione sociale del Paese. Se questo è vero è del tutto evidente come la costruzione di un modello economico/sociale e di politica dei redditi capace quantomeno di limitare gli shock esterni derivanti da un contesto instabile e iper competitivo investa, oggi più di ieri, il sistema di relazioni industriali e il dialogo sociale.
La “sfida del lavoro” è oggi al centro del futuro delle nostre società come non lo è mai stata in passato.
Mitigazione degli effetti della glaciazione demografica, gestione dell’immigrazione legale e connessi processi di inclusione socio-economica, sostenibilità dei nostri sistemi di welfare, riduzione del disallineamento delle competenze rispetto alle richieste del mercato del lavoro, sostegno ai processi di riorganizzazioni delle imprese anche per far fronte all’evoluzione tecnologica ed agli impatti dell’AI, engagement e retention delle nuove generazioni portatrici di un quadro valoriale che ha radicalmente mutato i canoni del rapporto lavoro-vita di relazione, valorizzazione della contrattazione di tutti i livelli ivi compresa quella individuale e di prossimità per sostenere la crescita e le difesa dei salari anche legandoli alla produttività, sviluppo di forme partecipative e sostegno delle modalità di gestione delle transizioni (non solo politiche attive) sono solo alcune delle sfide da affrontare in un contesto di radicale scomposizione-ricomposizione dei processi di globalizzazione per come li abbiamo sinora conosciuti.
Vincere o perdere queste sfide farà la differenza per il nostro modello di democrazia economica, per le nostre aziende, per i lavoratori e i loro redditi e probabilmente per il sistema Paese chiamando inevitabilmente in causa le modalità di esercizio delle responsabilità associative.
Agostino Di Maio
ADAPT Professional Fellow
Allegato
Ministero delle Partecipazioni Statali Ispettorato Generale
Prot. n.23756
Roma, 8 giugno 1962
Aziende a partecipazione statale – Rapporti sindacali
– All’Istituto per la Ricostruzione Industriale – R.I.
– All’Ente Nazionale Idrocarburi-N.I.
– All’Ente Autonomo di Gestione per le Aziende Termali
– All’Ente Autonomo di Gestione per il Cinema
– All’Ente Autonomo di gestione delle partecipazioni del fondo per il I.M.
– A tutte le aziende ed enti a partecipazione statale diretta
Questo Ministero ha già in altre occasioni sottolineato l’esigenza di curare con particolare attenzione e sollecitudine i rapporti tra le aziende a partecipazione statale ed i lavoratori da esse dipendenti. Tale esigenza merita di essere presa in considerazione soprattutto nel momento presente, essendo evidente che la possibilità di attuare determinati obiettivi di sviluppo economico e di avanzamento sociale dipende in larga misura da una sempre maggiore estensione dei consensi nell’opinione pubblica e dall’atteggiamento delle masse lavoratrici.
In passato, allo scopo di agevolare il formarsi di un clima di positiva collaborazione in seno alle aziende, il Ministero delle Partecipa zioni statali non ha mancato di prendere alcune iniziative innovatrici rispetto alla politica del lavoro (come ad esempio, l’abolizione della clausola del nubilato, alla quale si riferiscono le direttive emanate con la circolare del 26 giugno 1961), né ha omesso di sollecitare le direzioni delle imprese a agevolare il formarsi di un clima di positiva collaborazione in seno alle aziende. Nel medesimo spirito è stato seguito costantemente lo svolgimento delle controversie di ordine sindacale, al fine di facilitarne la conclusione secondo un metro confo1me alla natura e al carattere delle aziende a partecipazione statale.
Nel momento attuale le necessità ora richiamate devono essere tenute presenti in vista della politica di piano verso la quale intende orientarsi l’attività dell’attuale Governo. Anche in relazione a tale prospettiva va considerata l’importanza della creazione delle condizioni più opportune affinché la vita sindacale, pur nella dialettica ad essa propria, sia sensibile adeguatamente ai rapporti tra gli interessi particolari e di categoria, da una parte, e gli interessi generali, dall’altro canto.
Poste tali premesse, si ritiene opportuno di invitare gli enti e le aziende cui lo scrivente si rivolge a voler esaminare con la maggiore cura alcuni problemi concernenti i rapporti di lavoro fermando l’attenzione sopra i punti qui di seguito indicati, che possono costituire un primo orientamento suscettivo di ulteriori approfondimenti ed allarga menti, sulla base dei risultati delle esperienze, che in parte integre ranno analoghe iniziative già attuate in diverse aziende industriali.
a) Possibilità di consentire alle organizzazioni sindacali di usare di appositi locali nell’interno delle aziende, compatibilmente con la mate riale disponibilità di spazi adatti nei singoli stabilimenti.
b) Facoltà per le organizzazioni sindacali di affiggere nei locali del l’impresa appositi albi per le comunicazioni ai propri dipendenti.
c) Esonero dal lavoro, per alcune ore della settimana, di un diri gente di ciascun sindacato, al fine di consentirgli di assolvere i propri .
d) Riscossione per conto dei sindacati, mediante trattenute sul salario e sullo stipendio, delle quote di A tal fine, data la necessità di tutelare la libertà di decisione dei singoli lavoratori, riguardo all’attuazione delle trattenute che interessano ciascuno di essi, potrebbe ricorrersi al metodo delle deleghe individuali, da rimettersi alle direzioni aziendali da parte delle varie associazioni sindacali.
L’accoglimento di queste istanze e di altre analoghe che potranno essere indicate successivamente, mentre non dovrebbe influire sull’ordine e sulla regolarità della vita aziendale, potrebbe facilitare l’auspicato inizio di un dialogo costruttivo tra i sindacati e le direzioni delle aziende a partecipazione statale.
Si confida che quanto precede sarà preso in attenta considerazione e si resta in attesa di conoscere le determinazioni che verranno assunte di volta in volta e di ricevere comunicazioni di eventuali valutazioni o esperienze.
IL MINISTRO f.to: BO