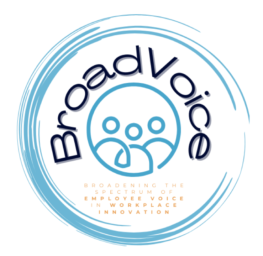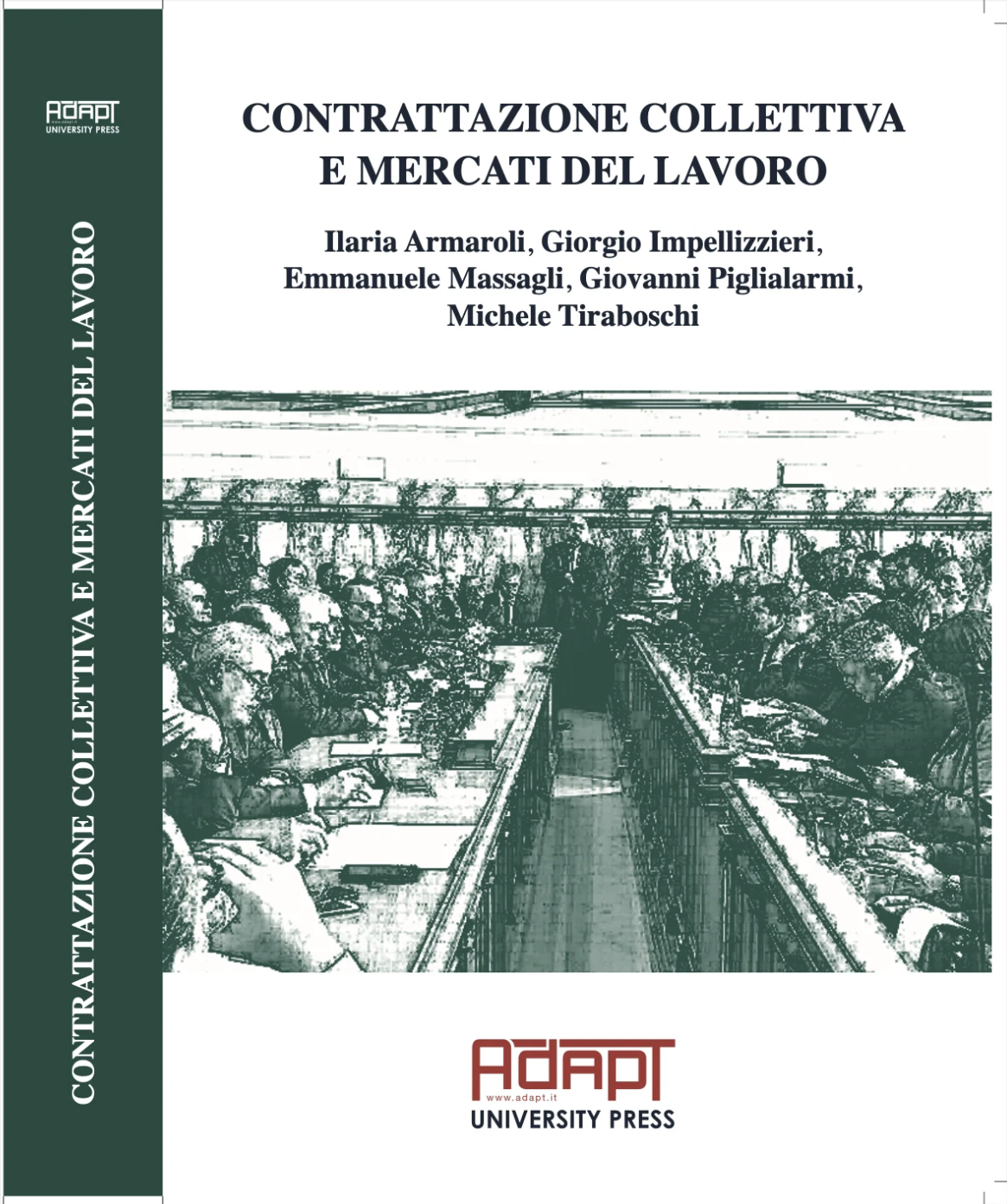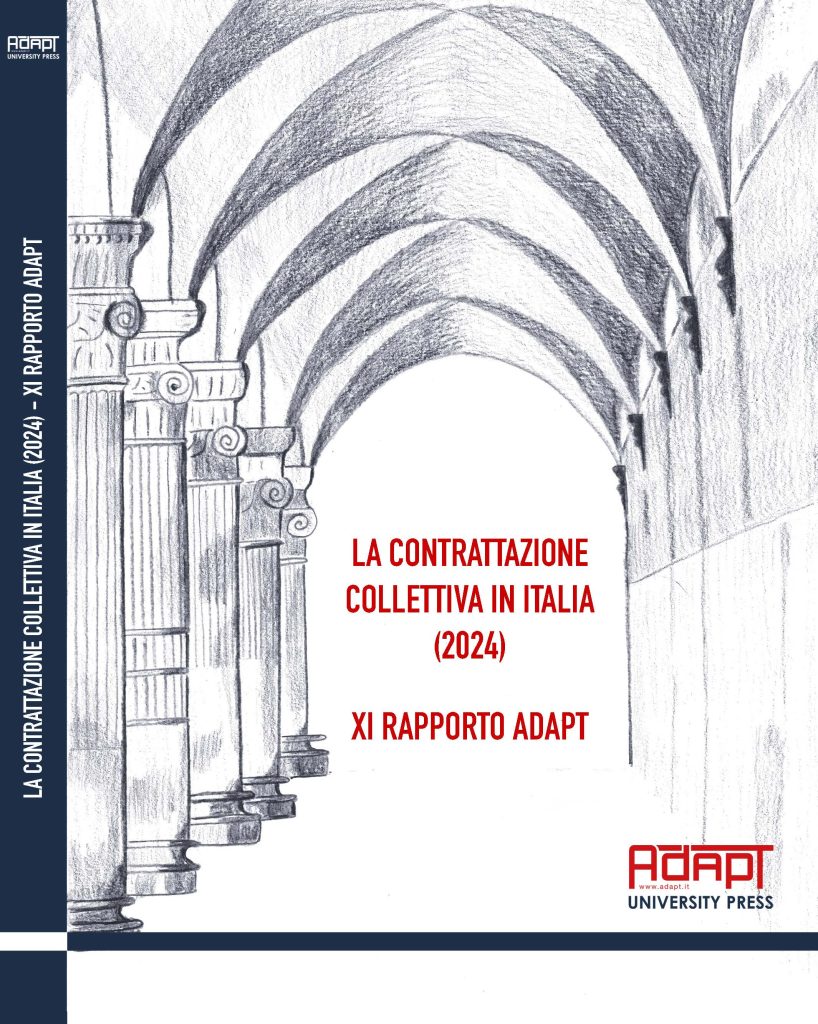Salute e sicurezza: un nuovo impegno condiviso con l’Accordo interconfederale del 2025 per il settore artigiano

Bollettino ADAPT 14 luglio 2025, n. 25
L’Accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 16 giugno 2025 rappresenta un nuovo passo in avanti verso il rafforzamento del ruolo delle parti sociali nel sistema di prevenzione, con particolare riferimento al settore artigiano. Sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e dalle principali organizzazioni datoriali – Confindustria, Confapi, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai – il testo riafferma il valore della contrattazione collettiva come strumento chiave per rendere effettiva e partecipata l’attuazione del D.lgs. 81/2008. L’accordo si colloca nel solco di una tradizione di bilateralismo e dialogo sociale, ma intende aggiornare e rilanciare la funzione della rete della pariteticità artigiana, valorizzandone il contributo nella promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire dalle trasformazioni in atto nel mondo produttivo. A oltre quindici anni dall’introduzione del Testo Unico, le parti firmatarie individuano la necessità di rafforzare strumenti, linguaggi e procedure, per garantire che la tutela della salute dei lavoratori non sia solo un principio enunciato, ma un obiettivo concreto e condiviso.
Il ruolo della contrattazione collettiva è individuato come leva strategica per rendere concreto il diritto alla salute nei luoghi di lavoro. L’accordo riconosce alla contrattazione una funzione essenziale nel tradurre in misure concrete i principi del D.lgs. 81/2008, con l’obiettivo di adattarli alle specificità dei settori e dei contesti produttivi. Tale ruolo non è concepito come sostitutivo della normativa, ma come elemento integrativo e propulsivo. Le parti si impegnano a promuovere modelli organizzativi orientati alla prevenzione, alla diffusione della cultura della sicurezza, alla gestione consapevole dei rischi e alla responsabilizzazione di tutti gli attori aziendali. Si sottolinea inoltre la necessità di un coinvolgimento attivo delle rappresentanze sindacali e datoriali, nella logica di una corresponsabilità che attraversa l’intera struttura organizzativa.
La partecipazione e il rafforzamento delle figure della rappresentanza dei lavoratori sono centrali per rendere effettiva la prevenzione. L’accordo valorizza in particolare il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) e di sito produttivo (RLSSP), riaffermando la necessità che siano messi nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo in modo efficace, attraverso un accesso tempestivo e completo alle informazioni, una formazione adeguata e un’interlocuzione strutturata con il datore di lavoro. Le parti riconoscono la funzione strategica di queste figure nella segnalazione dei rischi, nella diffusione della cultura della sicurezza e nella costruzione di rapporti fiduciari che facilitino la gestione preventiva dei problemi.
Il rafforzamento della dimensione territoriale si realizza attraverso una rete bilaterale articolata e integrata. L’accordo prevede che l’Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA) svolga una funzione di impulso, supporto e coordinamento rispetto all’azione degli Organismi Paritetici Regionali dell’Artigianato (OPRA), a loro volta titolari delle attività di programmazione e indirizzo nei confronti degli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato (OPTA). Questa struttura multilivello consente di adattare le politiche di prevenzione e promozione della salute alle esigenze delle imprese e dei lavoratori dei singoli territori, garantendo al contempo coerenza e unità di indirizzo. Il testo rafforza anche il ruolo della Commissione nazionale paritetica per la formazione alla sicurezza, che può operare sia in autonomia sia su impulso dell’OPNA, promuovendo attività comuni e migliorando l’efficacia dei percorsi formativi a livello territoriale.
L’accordo riconosce un ruolo strategico all’informazione e alla formazione per rafforzare la cultura della prevenzione nel settore artigiano. L’OPNA è incaricato di promuovere campagne di informazione e comunicazione, anche attraverso media e social, alle quali gli OPRA e gli OPTA potranno aderire, garantendone la diffusione capillare anche all’interno delle imprese. Sul piano formativo, le OO.SS., in collaborazione con gli organismi territoriali, organizzano la formazione di base e l’aggiornamento dei RLST, nel rispetto della normativa vigente e dell’Accordo Stato-Regioni. Gli OPRA favoriscono l’attività formativa, anche mediante convenzioni con l’INAIL o utilizzando risorse regionali, mentre l’OPNA potrà realizzare percorsi rivolti ai componenti degli organismi paritetici, per rafforzarne le competenze. La comunicazione preventiva del programma formativo agli organismi paritetici, prevista dal d.lgs. 81/2008, resta obbligatoria, con possibilità per il datore di lavoro di procedere autonomamente solo in caso di mancato riscontro entro quindici giorni.
L’Accordo prevede un quadro operativo integrato tra finanziamenti, intese territoriali e durata, per garantire continuità e efficacia. Le risorse economiche derivate dall’Accordo del 17 dicembre 2021 sono articolate in modo da destinare almeno l’80% al sostegno dei RLST, mentre fino al 20% finanzia il funzionamento degli OPRA/OPTA, la formazione e le attività di prevenzione secondo il D.lgs. 81/2008. Per rafforzare la coerenza territoriale, l’intesa invita le parti sociali regionali a rinnovare o adeguare gli accordi locali ai contenuti nazionali, attraverso incontri quadrimestrali per monitorare l’attuazione e favorire l’armonizzazione. L’accordo ha validità quadriennale e, anche dopo la scadenza, resterà in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo testo, prevedendo una revisione continua attraverso un meccanismo di monitoraggio condiviso.
Nel complesso, l’accordo interconfederale del 2025 rappresenta un rinnovato impegno delle parti sociali per la salute e sicurezza nel settore artigiano. L’intesa si caratterizza per un impianto collaborativo, che valorizza il ruolo della contrattazione collettiva, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e della rete della pariteticità artigiana. Senza introdurre nuovi obblighi normativi, il testo punta a rafforzare l’attuazione di quelli esistenti, promuovendo strumenti di confronto e cooperazione tra le parti. In questo senso, l’intesa si configura come un’espressione di responsabilità congiunta, che riflette una visione non punitiva ma proattiva della salute e sicurezza sul lavoro.
PhD Candidate – ADAPT Università di Siena