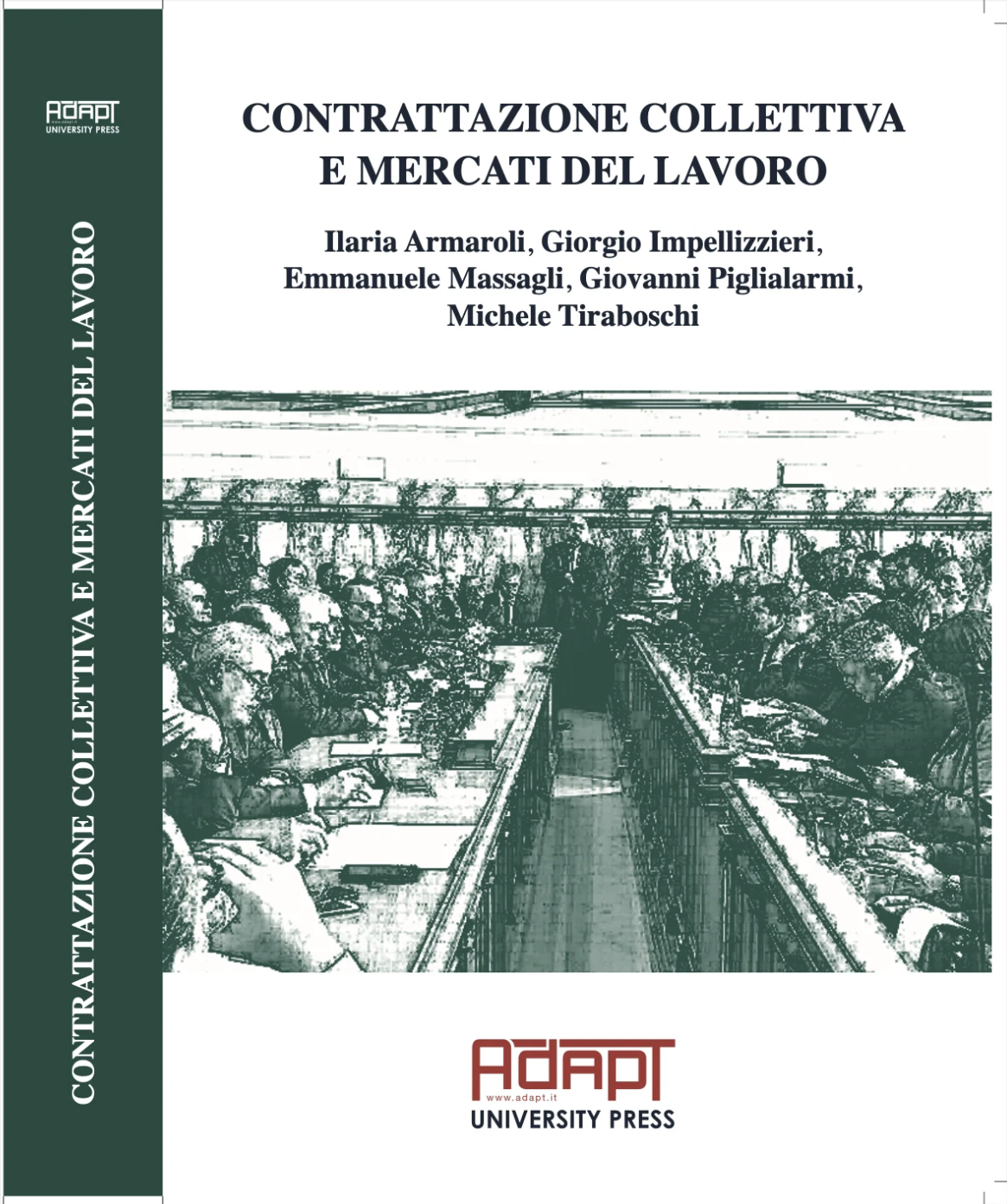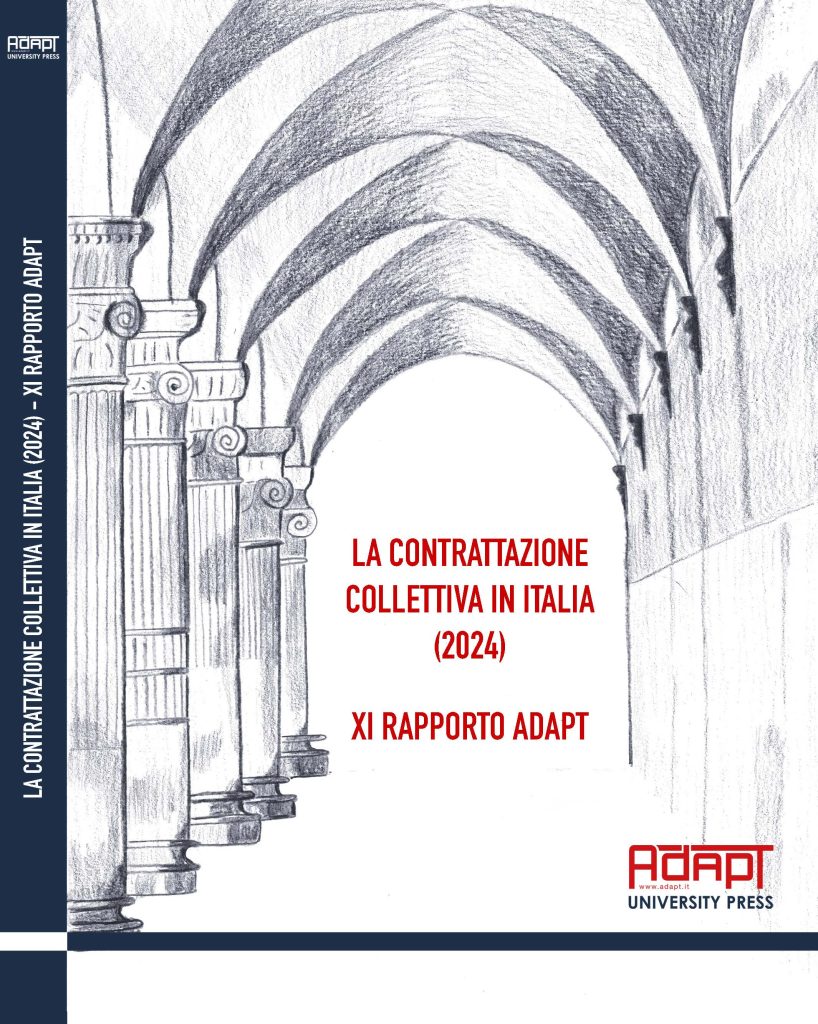Di cosa parliamo quando parliamo di contrattazione di produttività? (Parte II) – Un quadro ragionato della reportistica ufficiale

Bollettino ADAPT 30 giugno 2025, n. 25
Dal luglio 2016 il Ministero del Lavoro pubblica mensilmente un report di monitoraggio dei contratti collettivi di produttività. Questo strumento rappresenta, allo stato, l’unica fonte istituzionale di cui disponiamo per comprendere l’evoluzione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti collettivi aziendali o territoriali legano la corresponsione dei premi di risultato nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa. I report ministeriali si limitano tuttavia a una descrizione quantitativa del fenomeno, indubbiamente utile a tracciare alcune tendenze nel tempo del fenomeno ma non per entrare in profondità nei contenuti e tanto meno nella operatività degli accordi in questione.
Tali monitoraggi si basano sull’obbligo di deposito di detti contratti, da parte delle imprese, introdotto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015 come condizione per accedere agli incentivi previsti dalla legge n. 208/2015, articolo 1, commi 182-189 (sul tema si rinvia a G. Comi, M. Tiraboschi, Parte I – La normativa di incentivazione).
Nel tempo, il contenuto dei report si è ampliato. Oltre ai contratti legati alla misura di detassazione dei premi di risultato, dal 2018 vengono incluse anche intese che accedono ad altri tipi di agevolazioni, come la decontribuzione prevista dal Decreto Interministeriale 12 settembre 2017 per la conciliazione vita-lavoro e la contrattazione di prossimità disciplinata dal D.L. 138/2011. Nel presente contributo intendiamo concentrarci sulla prima sezione della reportistica ministeriale, relativa alla detassazione del premio di risultato, per offrire un quadro sintetico dell’andamento di questa forma di contrattazione di produttività in Italia tra il 2016 e il 2024.
Da una lettura longitudinale della reportistica, i dati mostrano una diffusione significativa del fenomeno nel periodo di vigenza della norma incentivante, per un totale di 108.546 contratti depositati al 15 maggio 2025, in netta crescita rispetto ai 17.318 depositati nel primo anno di attuazione della normativa (dicembre 2016). In origine, i report operavano una mera distinzione tra accordi aziendali e territoriali e si limitavano peraltro a registrare solo tre dei cinque obiettivi previsti dalla normativa per l’erogazione dei premi di risultato (produttività, redditività, qualità), escludendo efficienza e innovazione.
|
Contratti collettivi depositati (2016-2024) |
|||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Unità |
15.592 |
23.404 |
35.038 |
47.817 |
56.091 |
63.958 |
73.566 |
84.226 |
97.502 |
A partire dal giugno 2017, si assiste ad una svolta nei monitoraggi, perché si cominciano a evidenziare i contratti ancora “attivi” al momento della pubblicazione del report.
Questo dato ci restituisce l’immagine di un fenomeno dalla portata più contenuta, che all’inizio delle rilevazioni si attestava in media su 12.794 contratti attivi per l’anno 2018, mentre secondo l’ultimo monitoraggio si ferma a 13.042 unità (15 maggio 2025). Si consideri peraltro che negli anni di monitoraggio non si è mai superata la quota di 14 mila contratti attivi in media per ciascun anno (picco di 17.937 contratti attivi alla data del dicembre 2019). Pertanto, questo cambiamento nella reportistica ha sì migliorato la precisione dell’analisi, ma ha reso più difficile confrontare i dati con quelli precedenti. I report più datati, inoltre, risentono del “periodo transitorio” di avvio del sistema (contratti firmati nel 2015 depositati nel 2016), con un impatto negativo sulla loro affidabilità statistica.
|
Contratti collettivi attivi (2018-2024) |
|||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Unità |
12.794 |
14.133 |
12.148 |
10.700 |
9.654 |
10.972 |
13.761 |
Se si pone l’attenzione sugli obiettivi cui viene legata l’erogazione dei premi di risultato, notiamo come, nell’evoluzione temporale dei monitoraggi, la produttività sia rimasta l’obiettivo più frequentemente indicato sul totale dei contratti attivi (79% nel dicembre 2018 e 81% nel dicembre 2024). Eppure, questo dato, preso singolarmente, non è sufficiente a restituire la complessità delle dinamiche aziendali, a maggior ragione se si considera che tutt’oggi si continua a monitorare soltanto l’andamento di tre obiettivi (produttività, redditività e qualità). Efficienza ed innovazione vengono invece ancora tralasciate senza giustificazione alcuna, mentre crediamo che in un’ottica di controllo della crescita e sostenibilità aziendale a lungo termine sia fondamentale verificare se e quante imprese investono in questi fattori.
|
Obiettivi predeterminati per l’erogazione del premio di risultato (2018-2024) |
|||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Produttività |
10.088 |
11.031 |
9.485 |
8.482 |
7.622 |
8.630 |
11.020 |
|
Redditività |
7.530 |
8.177 |
7.191 |
6.517 |
5.844 |
6.621 |
8.599 |
|
Qualità |
6.222 |
6.693 |
5.589 |
5.051 |
4.901 |
5.583 |
6.905 |
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale del fenomeno, dal marzo 2018 i dati dei report vengono disaggregati per macro-area geografica (Nord, Centro, Sud), consentendoci di evidenziare una netta concentrazione territoriale dei contratti nel Nord Italia (oltre il 70%). Tuttavia, si segnala una criticità metodologica, poiché la localizzazione fa riferimento alla sede legale (coincidente con la Direzione Territoriale del Lavoro presso cui si deposita il contratto) e non alla sede operativa, che sarebbe invece un parametro più utile per misurare l’impatto effettivo di produttività e premi (come osservato in J. Sala, M. Tiraboschi, Contrattazione aziendale: il problema della “localizzazione” degli accordi). Possiamo comunque accertare la tendenza costante a stipulare contratti di produttività nell’area settentrionale del Paese, indubbiamente condizionata anche dalla presenza di un maggior numero di imprese registrate in quelle regioni (il 28,7% nel Nord-ovest e il 22,7% nel Nord-est, dati ISTAT 2023).
|
Distribuzione territoriale (2018-2024) |
|||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Nord |
75% |
77% |
79% |
76% |
72% |
72% |
74% |
|
Centro |
17% |
15% |
15% |
16% |
19% |
18% |
16% |
|
Sud |
8% |
7% |
7% |
8% |
10% |
10% |
10% |
Un altro aspetto interessante che è rimasto abbastanza stabile nel tempo riguarda la diffusione del fenomeno per dimensione delle imprese: la maggior parte dei contratti è sottoscritta da aziende con meno di 50 dipendenti (51% nel 2018 e 47% nel 2024, per una media del 49% negli anni). È questo un dato che sfata la diffusa percezione secondo cui solo le grandi imprese praticherebbero la contrattazione di secondo livello: le imprese sopra i 100 dipendenti coprono in realtà il 36% in media dei contratti. Ad ogni modo, se paragoniamo questo dato con quello della composizione del tessuto imprenditoriale italiano ci appare chiaro come le piccole-medie imprese siano sotto-rappresentate, costituendo la quasi totalità delle aziende registrate in Italia (99,6% secondo dati ISTAT, 2021).
|
Distribuzione per dimensione aziendale (2018-2024) |
|||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
< 50 |
51% |
51% |
54% |
53% |
46% |
43% |
47% |
|
>=100 |
34% |
34% |
32% |
33% |
38% |
41% |
38% |
|
50-99 |
15% |
15% |
14% |
14% |
16% |
16% |
15% |
Quanto al settore economico, i report rivelano che sussiste una prevalenza continua dei contratti stipulati nei Servizi (59% nel 2018 e 60% nel 2024), un dato in linea con il peso di questo comparto nell’economia italiana (69,6% secondo dati ISTAT, 2021) nonché con la rilevanza data al dialogo sociale nel settore. Seguono l’Industria (39%) e l’Agricoltura (1%).
|
Distribuzione settoriale (2018-2024) |
|||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Servizi |
59% |
56% |
54% |
56% |
59% |
60% |
60% |
|
Industria |
40% |
43% |
45% |
43% |
40% |
40% |
39% |
|
Agricoltura |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
In aggiunta, i report pubblicati dal 2019 in poi riportano anche il numero stimato dei lavoratori coinvolti. Se nel 2020 la quota si attestava sotto i 3 milioni, nel 2024 raggiunge i 4 milioni nel 2024, su un totale di 15 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato. Ciò significa che oggigiorno il 26,4% dei dipendenti potenzialmente coinvolti può beneficiare di un premio di risultato legato alla produttività aziendale.
|
Lavoratori beneficiari (2020-2024) |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Unità |
2.735.146 |
2.681.477 |
2.923.605 |
3.402.450 |
4.052.172 |
Inoltre, adottando il punto di vista dell’impatto del fenomeno sul lavoratore, appare importante la rilevazione del valore medio annuo del premio di risultato, il quale passa da un valore iniziale di 1.296,58 euro alla quota di 1.494,12 euro nel 2024. Il riferimento a questo dato è inedito e ci consente di cogliere come il fenomeno possa migliorare la condizione retributiva dei lavoratori. Tuttavia, va ricordato che questi dati si basano su autodichiarazioni aziendali (contenute nei modelli di deposito), senza controlli qualitativi sui testi dei contratti, e vanno quindi letti con cautela.
|
Stima del valore annuo del premio (2020-2024) |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Valore in euro |
1.296,58 |
1.328,98 |
1.505,94 |
1.529,63 |
1.494,12 |
Infine, si segnala che il 2021 segna un forte calo nel numero dei contratti attivi e dei beneficiari, che influisce su ciascuno dei parametri di lettura individuati finora. Verosimilmente la decrescita si lega agli effetti della pandemia – come già rilevato in un Rapporto INAPP del 2022(AP. Paliotta, M. Resce, Il premio di risultato nella contrattazione collettiva) – ed invero si è dovuto attendere il periodo tra il 2022 e 2024 per assistere a una graduale ripresa, anche se su certi fronti non ancora sufficiente ad un ritorno pieno dei livelli del 2019.
Il quadro finale che emerge da questa lettura trasversale dei report ministeriali restituisce un’immagine poco nitida del fenomeno, viziata dall’assenza di dati importanti, quali la rilevazione di tutti e cinque gli obiettivi a cui la legge collega l’erogazione del premio di risultato e il difetto di precisione nella localizzazione delle aziende sottoscriventi gli accordi. D’altro canto, i report non ci consentono di conoscere a quanto ammonta l’effettivo importo del premio guadagnato dai lavoratori a consuntivo delle verifiche sui risultati aziendali.
Nell’operazione di monitoraggio in generale pesa anche l’assenza di una valutazione approfondita della efficacia o meno delle misure pubbliche a sostegno della contrattazione di produttività.
In conclusione, la reportistica ministeriale offre uno strumento prezioso per osservare le dinamiche della contrattazione di produttività, ma dalla sua analisi emerge la necessità di un monitoraggio più accurato e di un’attenzione maggiore ai contenuti effettivi degli accordi aziendali, oltre che una maggior capacità di cogliere l’effettiva incidenza delle misure. I dati analizzati mostrano infatti una carenza di sistematicità nell’elaborazione dei monitoraggi – come già segnalato dal CNEL nei suoi Rapporti sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva. Per orientare meglio le politiche di incentivazione, occorre investire in una rilevazione più sistematica e qualitativa, capace di restituire un quadro più fedele delle trasformazioni in atto nei luoghi di lavoro, soprattutto in un contesto economico in cui la produttività del lavoro, la partecipazione finanziaria e la qualità della contrattazione aziendale sono tornate al centro del dibattito politico e istituzionale (si veda la recentissima Legge n. 76/2025 sulla partecipazione dei lavoratori).
PhD Candidate – ADAPT Università di Siena
* Le tabelle presenti nel testo sono realizzate attraverso la rielaborazione personale dei dati contenuti nei Report deposito contratti ex art. 14 del d.lgs. 151/2015, sezione prima, pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicati nel periodo intercorrente fra 2016 e 2024.