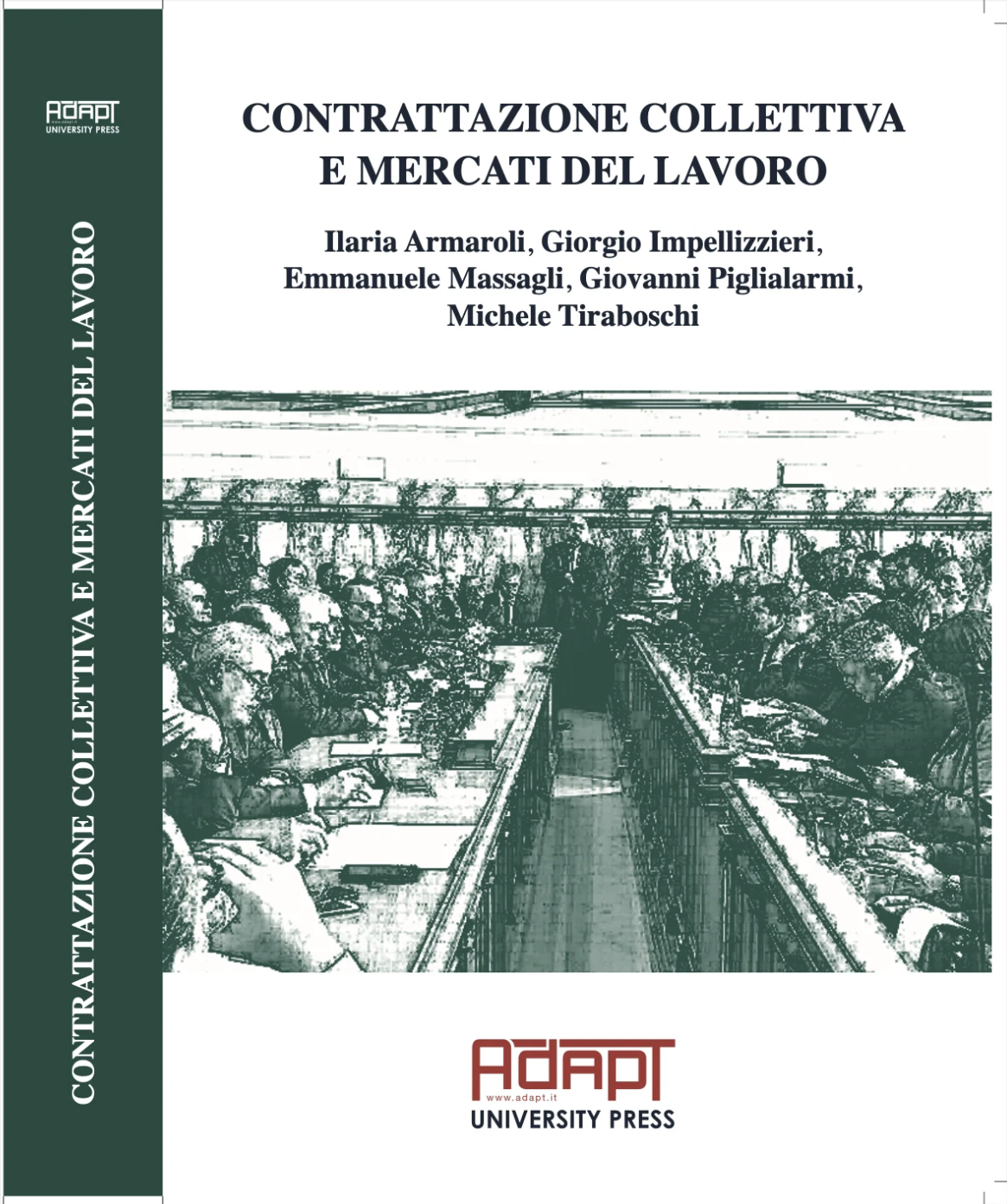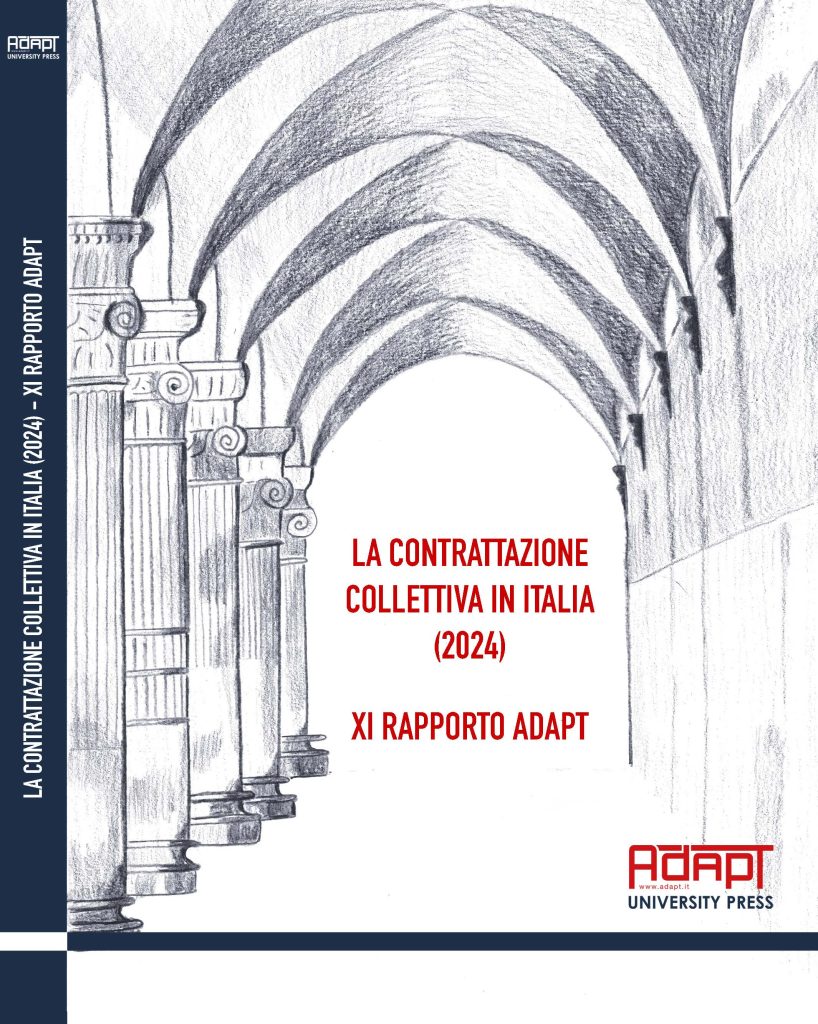Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/286 – Il rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato
Sciopero o manifestazione? Il dilemma del sindacato tra Gaza e la rappresentanza

Il costo e il danno del dumping contrattuale: perché si insiste sul terziario di mercato?

La sfida della contrattazione decentrata tra mera riduzione del costo del lavoro ed effettivo aumento di salari e produttività

Le posizioni delle parti sociali sulla legge delega approvata dal Parlamento in materia di salari e contrattazione collettiva

Cronaca sindacale (16-29 settembre 2025)

Cronaca sindacale (2-15 settembre 2025)
Incentivi pubblici e contrattazione di produttività. Cosa emerge dai report del Ministero del lavoro (2016-2024)?

Max Mara, quando il confronto è meglio del risentimento

Bollettino ADAPT 14 luglio 2025, n. 27
La casa di moda italiana Max Mara ha ritirato la proposta per il Polo della Moda a Reggio Emilia, denunciando una “campagna di disinformazione, sensazionalismo e superficialità”. La decisione è arrivata dopo le accuse, inoltrate da alcune lavoratrici con il supporto di un sindacato e poi circolate sulla stampa, relative a presunte condizioni di lavoro critiche in uno degli stabilimenti del gruppo, sempre nel territorio reggiano. È stata una mossa utile a difendere la reputazione dell’azienda?
Probabilmente no. Anzi. Ma per capire perché, bisogna ricapitolare i passaggi della vicenda.
Il Polo della Moda a Reggio Emilia era un progetto che prevedeva anche la riqualificazione dell’ex area fieristica situata nella zona nord della città. Nei giorni scorsi Luigi Maramotti, presidente di Max Mara Fashion Group, ha annunciato il ritiro della proposta di realizzare dopo che il sindaco Marco Massari aveva ricevuto alcune lavoratrici di Manifatture San Maurizio – azienda controllata dal gruppo – che avevano denunciato condizioni di lavoro deteriori e la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale del settore tessile, sostituito, secondo la Filctem, da un regolamento aziendale.
Le proteste delle lavoratrici avevano trovato ampio spazio su diverse testate, tra cui il Fatto Quotidiano, l’Unità e, pur con toni più critici, il Giornale. In risposta, il sindaco aveva auspicato che il confronto in corso potesse tradursi in un effettivo miglioramento delle condizioni lavorative, pur riconoscendo i limiti entro cui può muoversi un’amministrazione comunale.
Nei giorni successivi, per dimostrare imparzialità, Massari aveva incontrato anche un secondo gruppo di 68 lavoratrici che, attraverso una nota congiunta, avevano espresso una posizione diametralmente opposta. Le firmatarie avevano contestato quella che ritenevano una rappresentazione deformata del contesto aziendale, diffusa da certa stampa e da alcuni attori politici, e non corrispondente alla realtà vissuta dalla maggioranza delle dipendenti.
Che la mossa dell’azienda non possa apparire lineare lo ha già osservato un attento conoscitore delle relazioni industriali, specie di quelle emiliane, come Giuliano Cazzola. Come può infatti l’opinione pubblica capire le ragioni della revoca di un investimento industriale se questo viene ritirato non perché ostacolato da condizioni organizzative o dal rifiuto di proposte per l’efficientamento, ma in risposta a una minaccia reputazionale? Perché revocare insomma un investimento che si crede fruttuoso di fronte a ragioni che economiche e finanziarie non sono?
Certo, si potrebbe ipotizzare che l’azienda abbia valutato che il danno reputazionale si sarebbe tradotto in un danno finanziario, come spesso accade. E che, non potendolo dire per ragioni di opportunità (i danni finanziari da danni reputazionali vanno al più mitigati, non dichiarati) l’azienda abbia agito conseguentemente. Ma si tratta di un ragionamento contorto e che non può essere desunto dalla lettera.
È vero che, come ha osservato Dario Di Vico, il progetto di Cittadella della Moda non è stato improvvisato in poche settimane, ma è frutto di un lavoro di progettazione annuale. E dunque certamente la decisione assunta dall’azienda è stata sofferta e ponderata. Ed è anche probabile che sia stato valutato che la notizia avrebbe avuto un impatto a livello nazionale, ma che verrà accomodata diversamente a livello locale, tra i reggiani. Dunque potrebbe trattarsi di una mossa strategica.
Anche la Cisl ha sottolineato la concretezza del progetto, evitando, per voce della leader di Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo, di accusare sia il sindaco Massari “di essere stato inesperto o ingenuo”, sia la famiglia Maramotti di “essere dei padroni da primi del novecento”. Per entrambi parlerebbero i numeri: da un lato sarebbe stata l’amministrazione stessa a costruire e votare “in 13 mesi il via libera al Polo della Moda”, dall’altro Max Mara ha assunto 300 nuovi lavoratori “descritti molto bene a pagina 4 della delibera del consiglio comunale e nelle centinaia di pagine delle relazioni allegate”.
Sta di fatto che i più al momento sono stati legittimati a concludere che quel progetto fosse esso stesso una mossa reputazionale, se è scomparso dagli orizzonti strategici del gruppo per via di una offesa all’immagine dell’azienda, per lo più perpetrata con ragioni non inequivocabili.
Ma c’è di più. La scelta dell’azienda appare non solo illogica, ma rischia di essere anche controproducente a un’analisi più attenta.
Il caso presenta infatti alcuni elementi in comune con il ben più noto episodio di Pomigliano, che lo stesso Giuliano Cazzola ha citato. Anche se Max Mara non ha fornito motivazioni di tipo organizzativo per giustificare il dietrofront, l’azienda – come fece Marchionne – ha legato il proprio investimento a un principio di responsabilità sociale d’impresa: un gesto di attenzione verso il territorio, come alternativa alla delocalizzazione.
Nel 2009, Marchionne diceva a sindacati e governo: «occorre conciliare i costi industriali con la responsabilità sociale». Un tono non distante da quello assunto da Luigi Maramotti nella sua lettera al sindaco Massari, dove si legge che «l’intervento era considerato strategico per la città».
Il rischio che tali dichiarazioni siano percepite come espressione di un atteggiamento paternalista è sempre presente, soprattutto quando un’azienda è soggetta allo scrutinio pubblico. In questi casi, una reazione come quella di Max Mara può risultare doppiamente controproducente. Si può infatti essere portati a pensare che il legame con il territorio – presentato come valore – sia in realtà subordinato all’assenza di critiche e alla mancanza di vigilanza da parte degli stakeholder istituzionali e dei lavoratori.
L’azienda potrà certo sostenere che le relazioni di fiducia con l’amministrazione comunale sono venute meno, ma questo rischierebbe di sottintendere che un piano industriale debba essere accolto dalla comunità come una sorta di atto di generosità (a caval donato…), anziché essere sottoposto a un processo di confronto tra interessi legittimi. Mentre è proprio il viatico di una negoziazione a garantire l’investitura pubblica di una responsabilità sociale genuina.
Tanto più che esistevano le condizioni per un percorso diverso: la contro-manifestazione delle lavoratrici, la posizione del sindaco corretta in chiave di equidistanza, l’atteggiamento non conflittuale di parte del sindacato erano tutte condizioni che dimostravano l’esistenza di una pluralità di voci e un margine di dialogo. Sarebbe stato preferibile, allora, dichiararsi disponibili al confronto e dimostrare sul campo le proprie ragioni, piuttosto che assumere un atteggiamento che, a prescindere dalle reali motivazioni, pare volto a difendere una sorta di gratuità e di inviolabilità delle proprie intenzioni.
Francesco Nespoli
Ricercatore Università di Roma LUMSA
ADAPT Senior Fellow

 @Franznespoli
@Franznespoli