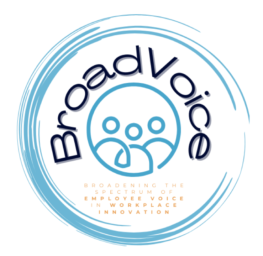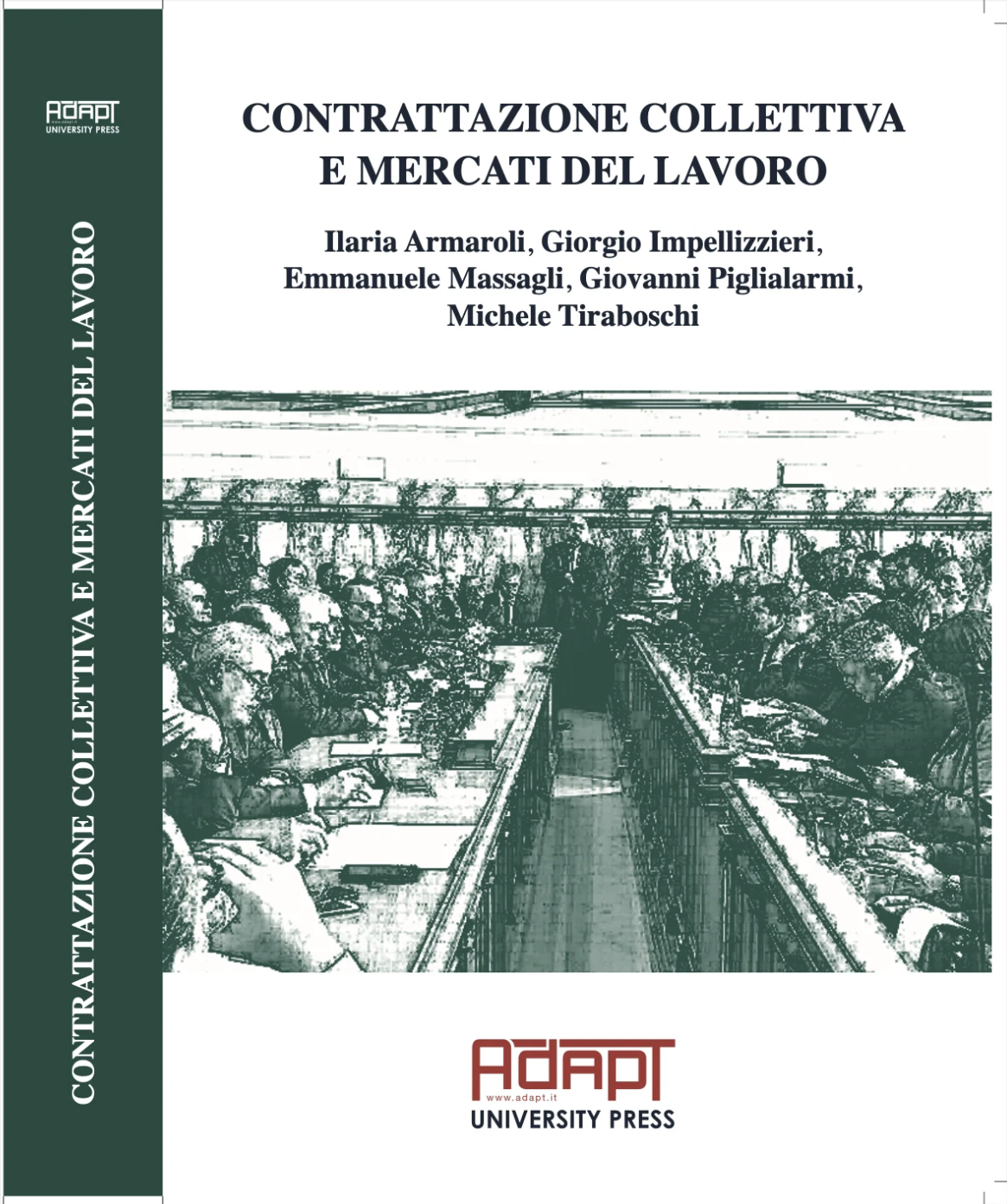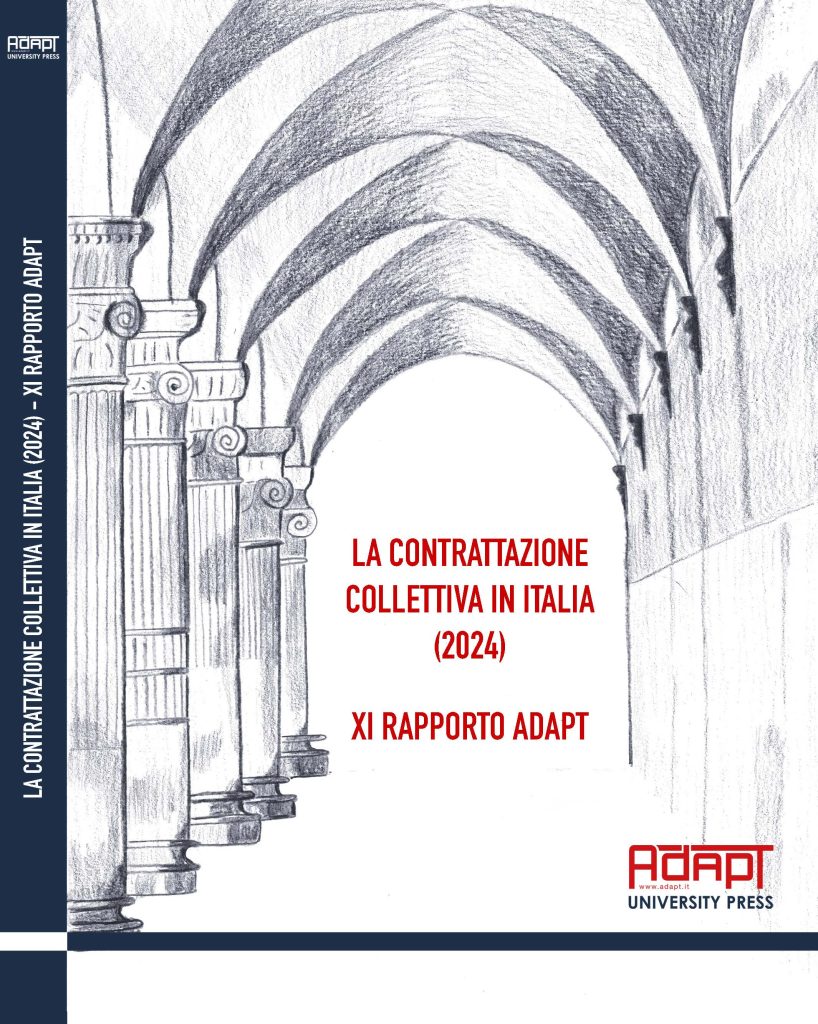Bollettino ADAPT 23 giugno 2025, n. 24
Motivazioni e obiettivi del progetto
Promuovere la “voce” dei lavoratori attraverso la partecipazione diretta è sempre più ritenuto un importante strumento non solo per migliorare le prestazioni organizzative, ma anche per la salute e il benessere dei lavoratori stessi. Negli ultimi decenni la crescita di pratiche partecipative sul posto di lavoro, come il lavoro di squadra auto-organizzato e l’innovazione guidata dai dipendenti, ha avuto un impatto positivo sulle imprese e sulla vita lavorativa.
Il concetto chiave in questo ambito è quello di innovazione del luogo di lavoro o workplace innovation, adottato dalla Commissione europea nel 2012. Esso descrive un processo partecipativo di trasformazione organizzativa che porta a una maggiore autonomia dei lavoratori, a un maggiore apprendimento e sviluppo e a un elevato coinvolgimento del personale nei percorsi di miglioramento e innovazione. È dimostrato che la cosiddetta workplace innovation porta a miglioramenti significativi e sostenibili sia delle prestazioni organizzative che del coinvolgimento e del benessere dei dipendenti.
Più di recente, la Commissione europea, insieme a molti esperti, ha sottolineato la necessità che i luoghi di lavoro “incentrati sulla persona” svolgano un ruolo di primo piano nella “doppia transizione” verso la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale – una trasformazione concettualizzata col termine “Industria 5.0”. In breve, è improbabile che queste transizioni siano efficaci senza sfruttare e sviluppare le competenze, le conoscenze tacite e la creatività innata dei dipendenti. Ma, come ci ricordano recenti indagini, solo una minoranza di imprese europee sta adottando sistematicamente queste pratiche di empowerment e partecipazione e sono ancora molte le aziende e gli enti del settore pubblico bloccati nelle tradizionali logiche organizzative di “comando e controllo”, con conseguenze economiche, sociali, sanitarie e ambientali negative.
Cosa significa tutto ciò per il ruolo dei sindacalisti e dei rappresentanti dei lavoratori? La partecipazione rappresentativa sotto forma di contrattazione collettiva, codeterminazione e procedure di informazione e consultazione è ora in competizione con la promozione della partecipazione diretta e della workplace innovation? Oppure questi fenomeni aprono nuove arene per l’impegno e l’influenza dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori a livello aziendale?
Continua a mancare un’analisi approfondita dell’interazione tra le forme di partecipazione diretta dei lavoratori per l’innovazione dei luoghi di lavoro e il quadro tradizionale delle relazioni industriali costituito da sindacati, organi di rappresentanza dei lavoratori e contrattazione collettiva.
Riunendo, a livello europeo, istituti di ricerca con esperienza nelle relazioni industriali e nell’organizzazione del lavoro di 6 Paesi dell’UE e 14 parti sociali nazionali e comunitarie, BroadVoice sta studiando – e contribuendo a promuovere – il ruolo dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori nell’innovazione dei luoghi di lavoro, anche attraverso la ricca esperienza e le intuizioni dei lavoratori. BroadVoice sta quindi esplorando i modi in cui la contrattazione collettiva e le strutture di rappresentanza dei lavoratori possono diventare i motori e i “guardiani” dell’innovazione aziendale che si avvale della partecipazione diretta.
Il quadro analitico
Nel quadro analitico elaborato nell’ambito del progetto[1] vengono delineati quattro modelli di interazione tra relazioni industriali sul luogo di lavoro e partecipazione diretta dei lavoratori:
i) il modello bipartito (o conflittuale), in cui la partecipazione dei lavoratori è largamente rappresentativa, mentre i canali diretti tendono ad essere meno sviluppati e/o modellati esclusivamente dalla direzione aziendale;
ii) il modello HRM, in cui la partecipazione diretta è la forma dominante di voce dei lavoratori, promossa e plasmata dal management a fini prevalentemente economici, mentre la rappresentanza dei lavoratori è piuttosto debole;
iii) il modello ibrido (o cooperativo), in cui coesistono e si sviluppano quasi in egual misura sia le forme rappresentative che quelle dirette di partecipazione dei lavoratori;
iv) il modello democratico (o partecipativo), in cui i canali diretti e rappresentativi di partecipazione dei lavoratori non solo coesistono ma sono anche interconnessi e costituiscono l’architettura organizzativa dei piani di innovazione aziendale.
Questi modelli non possono essere considerati statici, ma devono essere visti come repertori di possibili combinazioni tra partecipazione diretta e relazioni industriali in un determinato contesto lavorativo.
Inoltre, il quadro analitico elaborato esplora le dimensioni chiave della partecipazione diretta dei lavoratori, tra cui:
1. gli obiettivi della partecipazione (che possono essere di tipo economico, sociale, democratico e umanistico, benché in letteratura siano stati individuati anche obiettivi manageriali di controllo sui lavoratori e e i relativi flussi informativi);
2. l’intensità della partecipazione (che va dall’informazione e consultazione o esame congiunto, fino alla decisione congiunta e all’autonomia dei lavoratori);
3. la forma della partecipazione (che può essere individuale o di gruppo, comportare procedure verbali o scritte, ecc.);
4. l’ambito della partecipazione (che può riguardare decisioni di livello culturale, esecutivo od operativo, organizzativo o strategico).
Il quadro analitico valuta anche gli impatti della partecipazione diretta sui lavoratori, sulle organizzazioni e sui processi di trasformazione, evidenziando i positivi risultati sociali ed economici. Questi effetti sono tuttavia mediati da alcuni fattori esterni (riguardanti, ad esempio, il contesto aziendale, le caratteristiche dei lavoratori, l’assetto istituzionale).
L’obiettivo del progetto Broadvoice è quello di aiutare il legislatore, le parti sociali e la stessa comunità scientifica a delineare e definire la partecipazione diretta e le sue possibili relazioni con la rappresentanza dei lavoratori, anche nel contesto di progetti di innovazione organizzativa e tecnologica. In questo modo, lo studio mira a contribuire allo sviluppo di valutazioni, orientamenti e raccomandazioni più precisi e coerenti sul tema.
La ricerca sul campo italiana
Rispetto alla ricerca italiana[2], per raggiungere tali obiettivi, è stata condotta un’estesa rassegna della letteratura nazionale e un’analisi dettagliata del quadro istituzionale che regola le forme di partecipazione dei lavoratori, seguita dall’esame di alcuni casi studio.
In particolare, sono stati condotti due studi di settore (rispettivamente sul settore manifatturiero e sul terziario avanzato), che hanno coinvolto due aziende ciascuno.
Ogni caso studio aziendale è stato basato su un’analisi documentale di fonti primarie e secondarie e almeno tre interviste semi-strutturate con dirigenti aziendali e con rappresentanti dei lavoratori (per un totale di 18 intervistati). Inoltre, i risultati preliminari della ricerca sono stati discussi e convalidati in un workshop nazionale che ha avuto luogo il 23 gennaio 2025 con la partecipazione di 25 persone tra i rappresentanti (lato datoriale e lato sindacale) delle aziende intervistate, esponenti delle associazioni sindacali e datoriali di livello territoriale e nazionale dei settori interessati e altri stakeholder (come ricercatori o consulenti).
La nostra analisi conferma che l’area di interazione tra la partecipazione diretta e le relazioni industriali nelle imprese italiane è un tema di difficile individuazione. A pesare su questo è l’assenza di una consapevolezza comune sia da parte delle imprese che da parte dei rappresentanti dei lavoratori di cosa sia la partecipazione diretta e di come questa possa essere sviluppata sui luoghi di lavoro. Inoltre, anche il carattere spesso informale della partecipazione diretta e la sua implementazione ancora piuttosto moderata nelle aziende italiane, ne ostacolano l’identificazione (Inapp 2023)[3].
Eppure, la legislazione fiscale dal 2016 ha cercato, attraverso la leva degli sgravi fiscali applicati ai premi di risultato, di favorire l’emersione di pratiche di partecipazione diretta, formalizzandole all’interno di specifici “Piani di innovazione” da definire secondo le indicazioni fornite nei contratti collettivi di secondo livello. Tuttavia, questo intervento legislativo promozionale non ha ancora ottenuto risultati significativi: le pratiche di partecipazione diretta si riscontrano in media, in poco più del 10% del totale degli accordi depositati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attivi secondo le rilevazioni periodiche.
Sebbene l’interesse per la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali organizzativi sia cresciuto tra le parti sociali a livello nazionale (si veda l’interesse espresso nel cosiddetto Patto della fabbrica del 9 marzo 2018, o le previsioni contenute nei CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’industria tessile), manca ancora un quadro concettuale chiaro e unificato. Ciò ostacola la capacità dei sindacati e dei datori di lavoro di guidare efficacemente gli attori a livello aziendale nella gestione della partecipazione diretta.
Tuttavia, i nostri risultati empirici mostrano che la partecipazione diretta e quella rappresentativa dei lavoratori spesso coesistono nei luoghi di lavoro. Inoltre, sebbene operino tipicamente in ambiti distinti (la rappresentanza su questioni strategiche e la partecipazione diretta su aspetti più operativi), possono verificarsi sovrapposizioni in aree quali la formazione, il welfare e l’orario di lavoro. Queste forme di partecipazione, però, non si escludono a vicenda; e anzi, se efficacemente integrate, possono integrarsi a vicenda e migliorare i risultati sia per i lavoratori che per le imprese.
Esempi positivi di questa interazione emergono in due aree: (i) l’autonomia e la flessibilità dell’orario di lavoro, soprattutto con riferimento a discipline contrattuali che forniscono il quadro di riferimento entro il quale i singoli lavoratori, previo confronto con i propri responsabili aziendali, possono beneficiare di maggiore autonomia e flessibilità nella gestione dei tempi e dei luoghi di lavoro (ad esempio, attraverso il lavoro da remoto); e (ii) l’innovazione organizzativa, soprattutto con riferimento a contratti collettivi che aprono la strada alla definizione congiunta di Piani di innovazione che si sviluppano anche attraverso pratiche di partecipazione diretta, sotto il coordinamento e monitoraggio di commissioni paritetiche aziendali.
In tutti questi casi, la voce dei lavoratori risulta sia più “ampia” che più “profonda”, grazie alla combinazione funzionale tra procedure di partecipazione rappresentativa e diretta, con le prime che intervengono nel plasmare, attuare e supervisionare le seconde. Nonostante alcune difficoltà, riscontrabili, ad esempio, nel coinvolgimento di un numero sempre maggiore di lavoratori e nel rendere sostenibili nel tempo le sperimentazioni partecipative, l’impatto complessivo è ampiamente positivo.
La nostra ricerca non esclude che lo sviluppo della partecipazione diretta possa presentare rischi per i rappresentanti dei lavoratori, come la minaccia di una loro progressiva marginalizzazione, o la possibilità di essere ridotti a meri partner operativi del management nei progetti di innovazione aziendale. Tuttavia, l’analisi condotta offre alla rappresentanza una prospettiva per uscire dall’impasse e mantenere un ruolo attivo in contesti aziendali sempre più partecipativi. In questo senso, ai rappresentanti dei lavoratori è suggerito di non ignorare la partecipazione diretta, ma di impegnarsi (purché criticamente) in questo ambito, senza fare della partecipazione diretta un fine ultimo e anzi avendo ben chiari gli obiettivi più ampi delle relazioni industriali (efficiency, equity e voice). Inquadrando il coinvolgimento diretto nella prospettiva più ambiziosa di perseguire un bilanciamento tra i risultati di efficienza, equità e partecipazione, i rappresentanti dei lavoratori possono allora operare affinché l’autonomia e l’empowerment individuale dei lavoratori si traducano in miglioramenti effettivi per il benessere delle singole persone e per l’intera comunità aziendale.
Ilaria Armaroli
Ricercatrice ADAPT Senior Fellow
 @ilaria_armaroli
@ilaria_armaroli
Francesco Lauria
Responsabile della formazione e progettazione europea della Cisl
 @lauria_franc
@lauria_franc
Per scaricare tutti i materiali, i rapporti nazionali e i casi di studio del progetto: https://workplaceinnovation.eu/broadvoice
Per partecipare alla community sull’innovazione nei luoghi di lavoro:
https://freshthinkinglabs.com/broadvoice/
[1] Il quadro analitico è disponibile qui: https://workplaceinnovation.eu/wp-content/uploads/2024/07/BroadVoice-deliverable-2-2_analytical-framework.pdf
[2] Il rapporto nazionale completo è disponibile qui: https://workplaceinnovation.eu/wp-content/uploads/2025/03/Italia.pdf
[3] Per scaricare il Rapporto Inapp 2023: https://oa.inapp.gov.it/server/api/core/bitstreams/899a1e21-5e6d-4952-adad-858c1b068a2b/content


 @MicheTiraboschi
@MicheTiraboschi