A proposito dell’efficacia giuridica delle ipotesi di accordo di rinnovo dei contratti collettivi





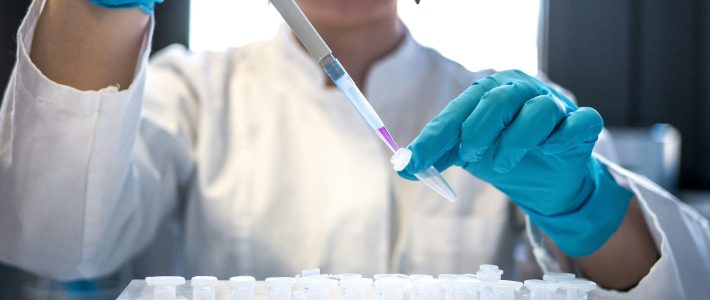

|
La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
Bollettino ADAPT 1 settembre 2025, n. 29
Parti firmatarie e contesto
Il 13 maggio 2025 si sono concluse le trattative, avviate ex art. 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Industria Chimica Farmaceutica (il “CCNL”) nel novembre 2024, che hanno portato al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (l’”Accordo”) del Gruppo Zambon (il “Gruppo”), multinazionale operante nel settore chimico-farmaceutico.
Il rinnovo dell’Accordo è stato firmato tra il Gruppo e le sigle sindacali FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL e UILTEC/UIL (le “Parti”).
L’Accordo si applica al personale di Zambon Company S.p.A., Zambon S.p.A., Zambon Italia S.r.l., Z Cube S.r.l. e Open Zone S.p.A. e ha durata triennale, con scadenza al 31 dicembre 2027.
Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità
L’Accordo approfondisce due elementi imprescindibili per la crescita aziendale: un sistema multilivello di relazioni industriali, improntate sui principi di trasparenza e partecipazione, e una forte spinta sulla formazione.
Sistema delle relazioni industriali a livello aziendale
Per rafforzare il confronto tra le Parti, nel nuovo Accordo il modello partecipativo del Gruppo si articola su tre livelli: un Coordinamento Nazionale, un Osservatorio Aziendale e un Osservatorio di Sito per ciascuna realtà produttiva.
Il Coordinamento Nazionale, convocato almeno due volte l’anno alla presenza delle Segreterie nazionali di FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL e UILTEC/UIL, si propone di monitorare l’andamento del Gruppo anche attraverso l’analisi del quadro economico aziendale rispetto al mercato di riferimento; ad esso si affianca, con cadenza quadrimestrale, l’Osservatorio Aziendale, sede deputata al confronto su argomenti legati alla situazione economica del Gruppo, ai possibili investimenti futuri e ai programmi di formazione e informazione. Sullo stesso filone si inserisce, infine, l’Osservatorio di Sito che si riunisce ogni due mesi per affrontare le specificità locali e trovare sul campo soluzioni condivise tra azienda e RSU, limitatamente alle materie demandate a livello aziendale dal CCNL.
Formazione e sviluppo professionale
Le Parti confermano l’importanza strategica della formazione quale strumento per la crescita professionale, affidando al Delegato alla Formazione (figura prevista dall’art. 63, comma 3, del CCNL – da identificarsi all’interno di ogni RSU del Gruppo) il compito di individuare i percorsi formativi più in linea con la strategia aziendale. Inoltre, le Parti si impegnano a proseguire il dialogo per definire l’inquadramento del personale nelle varie categorie aziendali, tenendo conto delle peculiarità produttive delle singole sedi. Infine, le Parti convengono di valorizzare la formazione congiunta tra rappresentanze sindacali e management aziendale e, su richiesta dei sindacati, di organizzare incontri formativi con rappresentanti di Fonchim e/o Faschim.
Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare
Il fulcro dell’Accordo è rappresentato sicuramente dal miglioramento del trattamento retributivo e delle misure di welfare, incentivi fondamentali per favorire la partecipazione attiva dei lavoratori alla realizzazione degli obiettivi di produttività aziendale. Punti focali sono, dunque, il premio di produttività, il welfare e la responsabilità sociale d’impresa.
Premio di partecipazione
L’Accordo disciplina in modo puntuale gli elementi chiave del premio di partecipazione (il “Premio”), subordinandone l’assegnazione al raggiungimento, in ciascun anno di riferimento, di almeno uno degli obiettivi-soglia prefissati (redditività del Business Pharma, fatturato di Gruppo Pharma e Global Market Share Fluimucil) (gli “Indicatori Cancello“).
Specifico accordo regolerà annualmente, entro il mese di marzo, i coefficienti (dati dal rapporto tra produttività/redditività) per la quantificazione del Premio per ogni sito produttivo, il cui ammontare sarà, quindi, variabile e:
– pari alla risultanza della somma di tali coefficienti – entro un ammontare massimo (Euro 2.600,00 per il 2025; Euro 2.650,00 per il 2026; Euro 2,750,00 per il 2027);
– proporzionato al numero di mesi di lavoro effettivamente prestati nell’anno di maturazione – consentendo di poter concorrere all’assegnazione del Premio anche a lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, nonché alla forza-lavoro non inserita stabilmente nell’organico aziendale (i.e. lavoratori a tempo determinato e somministrati), a condizione che abbia prestato servizio per almeno sei mesi nell’anno di riferimento, con erogazione per intero del Premio maturato anche in caso di periodi di assenza retribuita (per es. congedi di maternità/paternità, periodo di comporto);
– commisurato alla percentuale di lavoro svolto, rapportato al tempo pieno (“FTE”).
La corresponsione del Premio avverrà entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di maturazione ed i lavoratori eligible (i.e. aventi diritto) potranno optare di ricevere il Premio, in tutto o in parte, in denaro o sotto forma di credito welfare – con un’addizionale per incentivarne la conversione (sotto forma di credito extra pari ad una percentuale della quota, non inferiore al 15%, in caso di conversione di almeno la metà del Premio in welfare) – secondo le modalità previste dal regolamento aziendale sul tema.
Le Parti riconoscono, inoltre, la natura onnicomprensiva del Premio, che pertanto non inciderà su altri istituti di natura legale e/o contrattuale, né concorrerà alla formazione del TFR.
Infine, le Parti si riservano la facoltà di poter intervenire sulla disciplina del Premio prima della scadenza dell’Accordo, sia in caso di mutamento della normativa vigente in materia che di circostanze imprevedibili ed eccezionali che impediscano il raggiungimento degli Indicatori Cancello. In tale eventualità, per non vanificare il commitment dei lavoratori altrimenti eligible per l’assegnazione del Premio, è comunque prevista l’erogazione sotto forma di una tantum di un importo pari alla metà del Premio maturato (c.d. clausola di salvaguardia).
Welfare
In materia di welfare, l’Accordo prevede l’erogazione in favore di tutti i lavoratori del Gruppo – a prescindere da tipologia contrattuale e percentuale di FTE -, su base annuale, nel mese di settembre, di un credito welfare pari ad Euro 550,00 per il 2025 ed Euro 600,00 per il 2026 e 2027.
Tale credito sarà corrisposto in aggiunta all’eventuale Premio (e indipendentemente dal raggiungimento, da parte del Gruppo, degli Indicatori Cancello), secondo termini, modalità e condizioni stabilite dal regolamento aziendale dedicato.
Viene, infine, confermato che la quota di contribuzione al fondo Faschim a carico del lavoratore sarà interamente sostenuta dal Gruppo.
Responsabilità sociale e di impresa
Le Parti si impegnano, inoltre, in continuità con il CCNL, ad individuare delle strategie in tema di responsabilità sociale d’impresa, volte in particolare a garantire il c.d. work-life balance del personale del Gruppo attraverso un duplice binario: la promozione di una cultura aziendale inclusiva (attraverso, per esempio, specifica formazione su prevenzione e contrasto della violenza di genere) e il ricorso ad istituti ad hoc (come, inter alia, la banca ore e la banca ore solidale).
L’Accordo si conclude con la possibilità per i lavoratori di richiedere un anticipo della tredicesima mensilità, da corrispondersi in forma di acconto entro una data finestra temporale (tra luglio e ottobre di ogni anno) mediante richiesta formale all’ufficio HR.
Valutazione d’insieme
L’Accordo sottoscritto costituisce un avanzamento significativo nelle relazioni industriali del Gruppo, grazie ad un approccio multilivello che privilegia trasparenza e partecipazione tra le Parti. Il rafforzamento degli organismi di coordinamento e degli Osservatori – affiancato da un modello formativo condiviso e da un sistema di incentivazione variabile legato a indicatori oggettivi – delinea un quadro di governance in grado di coniugare obiettivi di crescita aziendale con il benessere del personale del Gruppo. Inoltre, l’introduzione di un contributo welfare e di meccanismi di conversione del Premio in servizi, insieme alla flessibilità nell’anticipo sulla tredicesima, costituiscono sicuramente misure di favor per i lavoratori. L’offerta di garanzie di stabilità e strumenti reattivi per far fronte a possibili mutamenti del contesto di mercato rendono, inoltre, l’Accordo un modello di riferimento per la contrattazione aziendale in ambito chimico-farmaceutico.
ADAPT Junior Fellow

Bollettino ADAPT 1 settembre 2025, n. 29
La contrattazione collettiva riveste un ruolo cruciale nell’attuazione del pilastro sociale europeo, garantendo standard minimi di protezione e condizioni lavorative uniformi all’interno dei diversi settori produttivi. Tuttavia, le crescenti pressioni competitive e le trasformazioni economiche degli ultimi anni hanno messo sotto pressione questo sistema, spingendo molte imprese a ricercare forme di maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro. In particolare, la necessità di contenere i costi del lavoro e di adattare rapidamente le condizioni contrattuali alle specifiche esigenze aziendali ha portato all’emergere di strategie sempre più sofisticate per modificare o eludere i vincoli previsti dai contratti collettivi nazionali.
Questo fenomeno si è manifestato con particolare intensità in Italia, dove il sistema di relazioni industriali si è storicamente caratterizzato per una copertura pressoché universale dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e per la presenza di minimi salariali spesso rigidi e uniformi su tutto il territorio nazionale. La tensione tra le esigenze di flessibilità delle imprese e i vincoli del sistema di contrattazione tradizionale ha dato origine a strategie di adattamento e opt-out, attraverso le quali le imprese cercano di riconfigurare o eludere le regole del modello contrattuale centralizzato per ottenere condizioni più “vantaggiose”. Un nuovo studio di Dustmann e coautori offre una prospettiva empirica su questo fenomeno, analizzando due importanti episodi di trasformazione del sistema contrattuale tradizionale verificatisi in Italia e i loro effetti sui lavoratori e sulle imprese coinvolte.
Il contesto istituzionale italiano
L’Italia rappresenta un laboratorio ideale per studiare gli effetti dell’opt-out dal sistema di contrattazione collettiva tradizionale. Il modello italiano si caratterizza per una copertura universale dei CCNL, che stabiliscono minimi retributivi vincolanti per ogni settore e categoria professionale. Questi accordi, tipicamente della durata di tre anni, sono negoziati dalle principali confederazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) e le associazioni datoriali di settore. La rigidità del sistema è oggetto di crescenti critiche, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, dove i minimi salariali nazionali spesso superano i livelli di produttività locale, contribuendo – secondo alcuni osservatori – alle persistenti difficoltà occupazionali dell’area.
Lo studio si focalizza su due fenomeni distinti di opt-out, espressione delle strategie adottate da alcune imprese italiane per eludere le rigidità della contrattazione collettiva tradizionale. Il primo riguarda l’uscita coordinata di 56 grandi aziende del settore della grande distribuzione dall’associazione datoriale Confcommercio. Queste imprese, raggruppate in Federdistribuzione (che comprende nomi noti come Ikea, Zara e Carrefour), nel 2011 hanno deciso di abbandonare il contratto collettivo del commercio per negoziare un accordo separato che, pur mantenendo il coinvolgimento delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, garantisse maggiore flessibilità negli orari di apertura e condizioni lavorative più adattabili alle esigenze della grande distribuzione.
Il secondo fenomeno analizzato è l’adozione dei cosiddetti “contratti pirata”, una forma più radicale di uscita dalla contrattazione centralizzata in cui singole imprese abbandonano i CCNL sottoscritti dalle federazioni sindacali afferenti alle confederazioni maggiormente rappresentative (CGIL, CISL e UIL) per applicare accordi stipulati da sindacati minori che offrono condizioni salariali e di lavoro al ribasso. Questi contratti sfruttano un vuoto normativo nell’ordinamento italiano: poiché la legge non definisce esplicitamente cosa costituisca un contratto “rappresentativo”, le imprese possono eludere i CCNL principali applicando accordi meno tutelanti. Come mostrano i dati presentati nello studio, il fenomeno è cresciuto rapidamente dopo la Grande Recessione, raggiungendo nel 2019 circa mezzo milione di lavoratori, pari al 3% dell’occupazione nel settore privato.
Metodologia e dati
La ricerca si basa su una fonte di dati eccezionalmente ricca: gli archivi amministrativi dell’INPS, che coprono l’universo dei rapporti di lavoro del settore privato italiano dal 2005 al 2019. Una caratteristica unica di questi dati è la possibilità di identificare, per ogni rapporto di lavoro, lo specifico contratto collettivo applicato, permettendo così di tracciare con precisione i cambiamenti contrattuali a livello di singola impresa e lavoratore.
La sfida metodologica principale consiste nell’isolare l’effetto causale dell’opt-out dai molti altri fattori che possono influenzare simultaneamente salari e occupazione. Le imprese che decidono di abbandonare i CCNL più rappresentativi potrebbero infatti differire sistematicamente da quelle che vi rimangono fedeli, rendendo difficile attribuire le differenze osservate negli outcomedei lavoratori al solo cambiamento contrattuale. Per superare questo problema, gli autori utilizzano un disegno di ricerca “difference-in-differences”, che confronta l’evoluzione nel tempo degli outcome dei lavoratori interessati dall’opt-out con quella di un gruppo di controllo di lavoratori simili rimasti sotto i contratti “tradizionali”. Questo approccio permette di controllare sia per le differenze fisse tra i due gruppi sia per i trend temporali comuni, isolando così l’effetto specifico del cambiamento contrattuale. Per garantire la comparabilità tra gruppo di trattamento e gruppo di controllo, viene utilizzato un algoritmo di matching basato su propensity score che considera caratteristiche individuali come età, anzianità, genere, tipo di contratto e salari precedenti, oltre a caratteristiche dell’impresa e della regione di lavoro.
I risultati principali su salari e occupazione
I risultati dello studio confermano l’esistenza di una relazione inversa tra salari e occupazione. In entrambi gli episodi analizzati, nonostante le diverse modalità di implementazione, l’uscita dal sistema contrattuale tradizionale porta a una riduzione delle retribuzioni e allo stesso tempo a un aumento generale dell’occupazione.
Nel caso della grande distribuzione, i lavoratori delle imprese che hanno abbandonato il contratto Confcommercio sperimentano una contrazione dei salari rispetto al gruppo di controllo che nel lungo periodo risulta pari al 3-4%. È importante precisare che questa differenza non nasce da tagli diretti: nei primi anni dopo l’opt-out del 2011 non emergono infatti differenze salariali significative; il gap si manifesta a partire dal 2015, quando i lavoratori delle imprese rimaste nel sistema tradizionale (CCNL Confcommercio) beneficiano di aumenti retributivi a seguito del rinnovo contrattuale, che dunque non vengono applicati ai lavoratori delle imprese Federdistribuzione. Nel 2019, quando le imprese Federdistribuzione adeguano i livelli retributivi a quelli previsti dal contratto Confcommercio, si osserva un parziale recupero. Allo stesso tempo, per i lavoratori delle imprese Federdistribuzione, si registra un incremento della probabilità di rimanere occupati di circa 4 punti percentuali. Questo effetto, secondo quanto mostrato dalle evidenze dello studio, si manifesta principalmente attraverso una riduzione dei licenziamenti.
Nel caso dei contratti pirata, i lavoratori coinvolti subiscono una riduzione salariale media del 2,5%, questa volta più immediata e riconducibile all’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da sindacati minoritari, caratterizzati da livelli retributivi inferiori rispetto ai CCNL principali. A differenza del caso Federdistribuzione, dove il divario retributivo rispetto al gruppo di controllo si è generato nel tempo per effetto degli aumenti contrattuali applicati solo alle imprese rimaste nel CCNL Confcommercio, nei contratti pirata il “vantaggio economico” per le imprese è immediato, derivando da un differenziale salariale esplicito e strutturale già presente al momento della stipula dell’accordo alternativo. Anche in questo caso, si registra un aumento della probabilità di occupazione di circa 3 punti percentuali, principalmente dovuto a una minore incidenza dei licenziamenti, segno che le imprese utilizzano l’opt-out come strumento per trattenere la forza lavoro a costi più contenuti.
Dal punto di vista delle imprese, l’analisi mostra che l’adozione di contratti pirata porta a una riduzione dei costi del lavoro del 3% e a un aumento della probabilità di sopravvivenza dell’impresa di circa 4 punti percentuali nei primi due anni successivi all’opt-out.
La dimensione geografica
Uno degli aspetti più rilevanti emersi dallo studio è la marcata eterogeneità geografica degli effetti dell’opt-out. In particolare, nelle regioni del Sud Italia, dove peraltro viene rilevata una maggiore concentrazione di contratti pirata rispetto alle altre aree territoriali, le conseguenze per i lavoratori sono particolarmente negative, mentre nel Centro-Nord risultano più attenuate.
Nel Nord Italia, i lavoratori coinvolti nell’opt-out sperimentano riduzioni salariali relativamente contenute (-1,6% per i contratti pirata), insieme a un effetto positivo sull’occupazione (attribuibile al calo dei licenziamenti). Nelle regioni del Sud, invece, la contrazione dei salari è molto più marcata (-5,1% per i contratti pirata) e non si registrano effetti positivi sul fronte occupazionale.
Questa eterogeneità geografica è particolarmente evidente nell’analisi delle cause di cessazione dei rapporti di lavoro. Nel Nord Italia, l’uscita dal modello contrattuale tradizionale porta a una significativa riduzione dei licenziamenti, mentre i tassi di dimissioni volontarie rimangono stabili. Nel Sud, al contrario, non si osserva una riduzione dei licenziamenti e si registra invece un aumento delle dimissioni volontarie, probabilmente in risposta alle maggiori riduzioni salariali.
Interpretazione teorica: il modello di monopsonio
Gli autori interpretano questi risultati attraverso un modello teorico di monopsonio che evidenzia come gli effetti dell’opt-out dipendano dal grado di concorrenza nei mercati del lavoro locali. La differenza fondamentale tra Nord e Sud Italia risiede proprio in questa dimensione: le imprese settentrionali operano in mercati del lavoro relativamente competitivi, mentre quelle meridionali si trovano in contesti caratterizzati da scarsa concorrenza che conferisce ai datori di lavoro significativo potere di monopsonio.
Nel Nord, dove i mercati del lavoro sono maggiormente competitivi, l’opt-out contrattuale si traduce in una moderata riduzione dei salari e in una tenuta dei livelli occupazionali, secondo una dinamica coerente con i modelli teorici che descrivono gli effetti della rimozione di un vincolo salariale in contesti concorrenziali. In questo caso, le imprese tendono a trattenere il personale approfittando della maggiore convenienza del lavoro a salari ridotti, senza tuttavia che ciò implichi un reale miglioramento delle condizioni occupazionali. Al contrario, nelle regioni del Sud, dove le imprese detengono potere di mercato per via della scarsa concorrenza tra datori di lavoro, l’elusione dei vincoli contrattuali consente di abbassare i salari, il che scoraggia l’offerta di lavoro, portando quindi a una riduzione dell’occupazione.
Osservazioni conclusive
Lo studio analizza due fenomeni di trasformazione del sistema di contrattazione collettiva in Italia: l’accordo separato di Federdistribuzione e i cosiddetti contratti pirata. Sebbene entrambi rappresentino strategie per ottenere maggiore flessibilità contrattuale, essi si differenziano significativamente nelle loro modalità di attuazione: l’accordo Federdistribuzione mantiene il coinvolgimento delle confederazioni sindacali rappresentative caratterizzandosi più come una riconfigurazione interna al sistema centralizzato; i contratti pirata, invece, costituiscono una vera e propria uscita dal perimetro della contrattazione rappresentativa. L’analisi empirica, basata su dati INPS e su una solida metodologia di identificazione causale, mostra che queste strategie comportano effetti negativi per i lavoratori, soprattutto sul piano retributivo e in particolare per i lavoratori residenti nelle regioni del Sud Italia.
Oltre a produrre effetti dannosi per i lavoratori e a contribuire all’erosione delle tutele di questi ultimi, i fenomeni di opt-out, e nello specifico la contrattazione pirata, rischiano di compromettere la stabilità e la tenuta del sistema di contrattazione nel suo complesso. L’uscita dal modello contrattuale centralizzato mina infatti la capacità del sistema stesso di garantire condizioni lavorative adeguate a tutti i lavoratori e di esercitare una funzione ordinatrice nei rapporti di lavoro. In assenza di criteri chiari sulla rappresentatività dei soggetti stipulanti, il ricorso a contratti alternativi può incentivare pratiche opportunistiche da parte delle imprese e alimentare una dinamica di concorrenza al ribasso, con effetti distorsivi sia sul piano retributivo che su quello della qualità del lavoro. In questo scenario, la contrattazione collettiva rischia di perdere progressivamente il proprio ruolo di strumento centrale di regolazione e tutela, a favore di un assetto sempre più frammentato, instabile e diseguale.
ADAPT Research Fellow

Bollettino ADAPT 14 luglio 2025, n. 27
La casa di moda italiana Max Mara ha ritirato la proposta per il Polo della Moda a Reggio Emilia, denunciando una “campagna di disinformazione, sensazionalismo e superficialità”. La decisione è arrivata dopo le accuse, inoltrate da alcune lavoratrici con il supporto di un sindacato e poi circolate sulla stampa, relative a presunte condizioni di lavoro critiche in uno degli stabilimenti del gruppo, sempre nel territorio reggiano. È stata una mossa utile a difendere la reputazione dell’azienda?
Probabilmente no. Anzi. Ma per capire perché, bisogna ricapitolare i passaggi della vicenda.
Il Polo della Moda a Reggio Emilia era un progetto che prevedeva anche la riqualificazione dell’ex area fieristica situata nella zona nord della città. Nei giorni scorsi Luigi Maramotti, presidente di Max Mara Fashion Group, ha annunciato il ritiro della proposta di realizzare dopo che il sindaco Marco Massari aveva ricevuto alcune lavoratrici di Manifatture San Maurizio – azienda controllata dal gruppo – che avevano denunciato condizioni di lavoro deteriori e la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale del settore tessile, sostituito, secondo la Filctem, da un regolamento aziendale.
Le proteste delle lavoratrici avevano trovato ampio spazio su diverse testate, tra cui il Fatto Quotidiano, l’Unità e, pur con toni più critici, il Giornale. In risposta, il sindaco aveva auspicato che il confronto in corso potesse tradursi in un effettivo miglioramento delle condizioni lavorative, pur riconoscendo i limiti entro cui può muoversi un’amministrazione comunale.
Nei giorni successivi, per dimostrare imparzialità, Massari aveva incontrato anche un secondo gruppo di 68 lavoratrici che, attraverso una nota congiunta, avevano espresso una posizione diametralmente opposta. Le firmatarie avevano contestato quella che ritenevano una rappresentazione deformata del contesto aziendale, diffusa da certa stampa e da alcuni attori politici, e non corrispondente alla realtà vissuta dalla maggioranza delle dipendenti.
Che la mossa dell’azienda non possa apparire lineare lo ha già osservato un attento conoscitore delle relazioni industriali, specie di quelle emiliane, come Giuliano Cazzola. Come può infatti l’opinione pubblica capire le ragioni della revoca di un investimento industriale se questo viene ritirato non perché ostacolato da condizioni organizzative o dal rifiuto di proposte per l’efficientamento, ma in risposta a una minaccia reputazionale? Perché revocare insomma un investimento che si crede fruttuoso di fronte a ragioni che economiche e finanziarie non sono?
Certo, si potrebbe ipotizzare che l’azienda abbia valutato che il danno reputazionale si sarebbe tradotto in un danno finanziario, come spesso accade. E che, non potendolo dire per ragioni di opportunità (i danni finanziari da danni reputazionali vanno al più mitigati, non dichiarati) l’azienda abbia agito conseguentemente. Ma si tratta di un ragionamento contorto e che non può essere desunto dalla lettera.
È vero che, come ha osservato Dario Di Vico, il progetto di Cittadella della Moda non è stato improvvisato in poche settimane, ma è frutto di un lavoro di progettazione annuale. E dunque certamente la decisione assunta dall’azienda è stata sofferta e ponderata. Ed è anche probabile che sia stato valutato che la notizia avrebbe avuto un impatto a livello nazionale, ma che verrà accomodata diversamente a livello locale, tra i reggiani. Dunque potrebbe trattarsi di una mossa strategica.
Anche la Cisl ha sottolineato la concretezza del progetto, evitando, per voce della leader di Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo, di accusare sia il sindaco Massari “di essere stato inesperto o ingenuo”, sia la famiglia Maramotti di “essere dei padroni da primi del novecento”. Per entrambi parlerebbero i numeri: da un lato sarebbe stata l’amministrazione stessa a costruire e votare “in 13 mesi il via libera al Polo della Moda”, dall’altro Max Mara ha assunto 300 nuovi lavoratori “descritti molto bene a pagina 4 della delibera del consiglio comunale e nelle centinaia di pagine delle relazioni allegate”.
Sta di fatto che i più al momento sono stati legittimati a concludere che quel progetto fosse esso stesso una mossa reputazionale, se è scomparso dagli orizzonti strategici del gruppo per via di una offesa all’immagine dell’azienda, per lo più perpetrata con ragioni non inequivocabili.
Ma c’è di più. La scelta dell’azienda appare non solo illogica, ma rischia di essere anche controproducente a un’analisi più attenta.
Il caso presenta infatti alcuni elementi in comune con il ben più noto episodio di Pomigliano, che lo stesso Giuliano Cazzola ha citato. Anche se Max Mara non ha fornito motivazioni di tipo organizzativo per giustificare il dietrofront, l’azienda – come fece Marchionne – ha legato il proprio investimento a un principio di responsabilità sociale d’impresa: un gesto di attenzione verso il territorio, come alternativa alla delocalizzazione.
Nel 2009, Marchionne diceva a sindacati e governo: «occorre conciliare i costi industriali con la responsabilità sociale». Un tono non distante da quello assunto da Luigi Maramotti nella sua lettera al sindaco Massari, dove si legge che «l’intervento era considerato strategico per la città».
Il rischio che tali dichiarazioni siano percepite come espressione di un atteggiamento paternalista è sempre presente, soprattutto quando un’azienda è soggetta allo scrutinio pubblico. In questi casi, una reazione come quella di Max Mara può risultare doppiamente controproducente. Si può infatti essere portati a pensare che il legame con il territorio – presentato come valore – sia in realtà subordinato all’assenza di critiche e alla mancanza di vigilanza da parte degli stakeholder istituzionali e dei lavoratori.
L’azienda potrà certo sostenere che le relazioni di fiducia con l’amministrazione comunale sono venute meno, ma questo rischierebbe di sottintendere che un piano industriale debba essere accolto dalla comunità come una sorta di atto di generosità (a caval donato…), anziché essere sottoposto a un processo di confronto tra interessi legittimi. Mentre è proprio il viatico di una negoziazione a garantire l’investitura pubblica di una responsabilità sociale genuina.
Tanto più che esistevano le condizioni per un percorso diverso: la contro-manifestazione delle lavoratrici, la posizione del sindaco corretta in chiave di equidistanza, l’atteggiamento non conflittuale di parte del sindacato erano tutte condizioni che dimostravano l’esistenza di una pluralità di voci e un margine di dialogo. Sarebbe stato preferibile, allora, dichiararsi disponibili al confronto e dimostrare sul campo le proprie ragioni, piuttosto che assumere un atteggiamento che, a prescindere dalle reali motivazioni, pare volto a difendere una sorta di gratuità e di inviolabilità delle proprie intenzioni.
Francesco Nespoli
Ricercatore Università di Roma LUMSA
ADAPT Senior Fellow


|
La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
Bollettino ADAPT 3 giugno 2025, n. 21
Contesto del rinnovo
I lavori di definizione del nuovo accordo contrattuale per il settore cinematografico e del cinema teatrale si sono conclusi il 23 gennaio 2025 con la stipula del rinnovo del CCNL tra l’A.N.E.C., associazione datoriale cui aderiscono le imprese che svolgono attività di esercizio cinematografico, e SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL, federazioni sindacali che rappresentano i lavoratori del cinema (codice CNEL G211). Il rinnovo ha vigore a partire dal primo gennaio 2023 e rimane valido fino al 31 dicembre 2026.
Il primo CCNL disciplinante questo settore è stato stipulato nel marzo del 1964, mentre nel 2016 era stato sottoscritto l’ultimo rinnovo, rimasto in vigore fino al 31.12.2019. Dal gennaio 2020, infatti, sono cominciati i lavori per la stipula del successivo accordo, che tuttavia si sono arrestati nel febbraio 2020 a causa della pandemia COVID-19, per riprendere solo tre anni dopo. Il 31 maggio 2023 le parti coinvolte hanno raggiunto un primo accordo straordinario atto a disciplinare il settore nel periodo 2020-2022, per poi arrivare alla sottoscrizione del nuovo CCNL solo all’inizio del 2025.
Guardando ai dati, il numero delle aziende impegnate nel settore cinematografico è diminuito progressivamente nel corso degli anni, da 733 attive nel 2018 a 641 nel 2023, ma il calo di maggiore portata si registra nell’arco dell’anno successivo: le aziende esercenti nel 2024 risultano essere solo 253. Quanto al numero dei dipendenti del settore cinematografico, si registra un calo tra il 2018 e il 2021 ed una ripresa, con un progressivo aumento, tra il 2022 e il 2023. Tra il 2023 e il 2024, invece, si è verificato un grosso calo: da 7037 dipendenti nel 2023 a 1205 dipendenti nel 2024.
Parte economica
Per ciò che concerne la disciplina contrattuale del trattamento economico dei lavoratori del settore cinematografico e del cinema teatrale, vi sono interessanti novità sul piano del Trattamento Economico Minimo.
Segnatamente, il contratto predispone per il 4° livello un aumento progressivo dei minimi tabellari, per un totale di 200 euro. L’erogazione dell’importo è prevista in quattro tranche: la prima è erogata nel mese di gennaio 2023, la seconda nel novembre 2024, la quarta nel mese di luglio 2025, con una novità inedita per la terza tranche, trattandosi di 50,00 euro destinati in parte al welfare, essendo una quota del totale finalizzata all’adeguamento del livello superiore della polizza sanitaria (assorbendo i 10,00 euro destinati al Fondo “Salute Sempre” e i 5,00 euro destinati al Fondo Byblos, previsti dal precedente contratto) e confluendo il restante in buoni carburante e spese personali del dipendente.
Per ciò che concerne le maggiorazioni retributive per il lavoro domenicale, necessario secondo le parti firmatarie vista la particolare connotazione strutturale dell’attività nelle sale cinematografiche, all’art.16 del rinnovo del CCNL le parti convengono nell’applicare una maggiorazione del 10%, calcolata sul minimo tabellare per ogni ora di lavoro prestata nella giornata di domenica.
Parte normativa
La parte normativa del rinnovo del CCNL presenta una serie di novità su cui è interessante soffermare l’attenzione: si tratta delle disposizioni dedicate al contratto a termine, all’orario di lavoro, al lavoro agile e intermittente.
In particolare, è modificato l’articolo 11, rubricato “Contratto a termine”, che viene integrato con una disciplina della durata del contratto a tempo determinato nel settore cinematografico rispettosa dei paletti posti dalla normativa legale di riferimento (articolo 19 del d.lgs. n. 81 del 2015). La disposizione contrattuale, infatti, sancisce che la durata del contratto a termine concluso col lavoratore può superare i 12 mesi, a condizione che vi sia allegata una delle causali giustificatrici (ad esempio in casi di incrementi temporanei di lavoro, indisponibilità temporanea dell’organico, esigenze relative alla gestione di ferie e di permessi) e precisa che la sua durata massima non può superare i 24 mesi. L’articolo 11, in coerenza con quanto disposto dall’art. 19, comma 2 d.lgs. 81/2015, individua tre casi in cui la durata del contratto a tempo determinato può superare il limite dei 24 mesi: in caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; nei casi previsti dalla contrattazione aziendale; nel caso di stipula del c.d. “contratto in deroga” presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 19, comma 3 d.lgs. 81/2015. L’articolo 11 del CCNL riconosce inoltre la possibilità di prorogare la durata del contratto a termine per un massimo di quattro volte, in coerenza con gli articoli 19 e 21 del d.lgs. n. 81 del 2015.
Sul contingentamento dei lavoratori a termine, l’art. 11 del CCNL in esame, sfruttando la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 23 d.lgs. n. 81/2015, consente l’assunzione a tempo determinato di un numero di lavoratori fino ad un massimo del 40% di quelli assunti a tempo determinato. Per le imprese con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato, è prevista l’assunzione di un numero di lavoratori a tempo determinato “fino al massimo del numero dei tempi indeterminati “Full-Time Equivalent” in forza”.
Il rinnovo del CCNL, inoltre, ha apportato integrazioni anche all’art. 53, rubricato “Orario di lavoro”, sia sul punto dell’orario normale che di quello straordinario. In conformità con la normativa di riferimento (art. 3 d.lgs. n. 66/2003), il contratto in esame prevede che la durata dell’orario normale di lavoro sia di 40 ore settimanali. In coerenza con l’articolo 16, lett. d del d.lgs. 66/2003 la disposizione contrattuale inserisce una deroga alla disciplina della durata settimanale dell’orario: precisa che per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali e le 10 ore giornaliere.
Per ciò che concerne l’orario di lavoro massimo, il contratto ne calcola la durata media riferendosi ad un periodo di quattro mesi, come disposto dall’articolo 4, comma 3 del d.lgs. n. 66 del 2003. Inoltre, in coerenza con quanto disposto dall’art. 4, comma 4 d.lgs. 66/2003 il CCNL in esame prevede che, in caso di particolari esigenze organizzative, il computo potrà avvenire su un periodo di riferimento elevato fino a 12 mesi.
In materia di riposo giornaliero dei lavoratori del settore, l’art. 53 del CCNL prevede che in caso di particolari esigenze organizzative il riposo giornaliero di 11 ore possa essere fruito frazionatamente, prevedendo la possibilità di un riposo compensativo ove le 11 ore di riposo giornaliero non fossero assicurate.
Quanto alla disciplina contrattuale del lavoro straordinario, in coerenza con il comma 3 dell’articolo 5 del d.lgs. 66 del 2003, l’articolo 53 del nuovo CCNL ammette il ricorso al lavoro straordinario oltre il limite delle 250 ore in quelle che intende “particolari circostanze” (come eccezionali esigenze tecnico produttive, forza maggiore e in caso di pericolo grave ed immediato di danno all’attività lavorativa). Infine, il contratto applica l’articolo 5, ultimo comma del d.lgs. 66 del 2003, prevedendo che le parti possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario.
Nella sua parte normativa, inoltre, il CCNL inserisce due nuovi articoli: l’11 bis e l’11 ter, che disciplinano rispettivamente il lavoro intermittente e il lavoro agile.
L’articolo 11 bis del contratto introduce nel settore lavorativo cinematografico la stipula del contratto di lavoro intermittente, applicando la normativa di riferimento (artt. 13-15 del d.lgs. n. 81 del 2015) e ne indica le causali giustificatrici distinguendo tra quelle soggettive e quelle oggettive: la conclusione del contratto avverrà per prestazioni da svolgersi entro il compimento del 25° anno di età con lavoratori di età superiore a 55 anni o inferiore a 24 anni (causale soggettiva) mentre in caso di assenza improvvisa e non programmata di un’unità lavorativa o in presenza di un aumento di attività legato alla programmazione cinematografica si avrà la stipula di un contratto di lavoro intermittente, indipendentemente dall’età del lavoratore (giustificazioni oggettive).
L’articolo 11 ter, invece, disciplina il lavoro agile, c.d. smart working, ponendosi nell’ottica di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti del settore e lo fa applicando gli articoli di riferimento della legge n. 81 del 2017 (artt. 18-24).
Infine, viene inserito l’articolo 61 bis che riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore il diritto di fruire di congedi di maternità e paternità, garantendo agli stessi nei giorni di assenza una indennità integrativa corrisposta dall’azienda in aggiunta al trattamento economico erogato dall’Istituto assicuratore, che garantisca loro di raggiungere il 100% della normale retribuzione.
Parte obbligatoria
Quanto alla parte obbligatoria del nuovo CCNL, risultano modifiche relativamente all’esercizio del diritto sindacale di assemblea, nonché all’apertura di un nuovo Ente Bilaterale di categoria. L’articolo 32 dell’accordo, nella parte relativa al diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea, introduce un’importante condizione alla quale è subordinato il pagamento delle ore passate dal lavoratore in assemblea: il dipendente deve dimostrare l’effettiva partecipazione all’assemblea. La disposizione precisa, inoltre, che il lavoratore ha diritto alla retribuzione delle ore passate in assemblea, fino ad un massimo di 10 ore l’anno. Infine, il contratto prevede all’articolo 43 l’apertura di un nuovo Ente Bilaterale di categoria entro il 31 dicembre 2025.
Rimane da segnalare l’articolo 36 dell’accordo, che prescrive che le parti, trascorsi 10 mesi dalla firma del nuovo CCNL si riuniscano per mezzo dell’Osservatorio Nazionale per monitorare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello.
Valutazione d’insieme
Gli elementi centrali del rinnovo risultano l’incremento economico, una rinnovata attenzione al welfare del dipendente, una nuova disciplina del contratto a termine e dell’orario di lavoro e l’introduzione del lavoro agile e del lavoro intermittente.
Il rinnovo 2023-2026 del CCNL Esercenti Cinematografici risulta equilibrato in riferimento alle conquiste di tutte le parti. I dipendenti del settore e le associazioni sindacali, grazie alle trattative, hanno ottenuto un aumento del Trattamento Economico Minimo del dipendente di euro 200 e, novità di non poco rilievo, l’attenzione dell’accordo al welfare del dipendente: una quota dei 200 euro è destinata alla polizza sanitaria e ai buoni spesa del personale. I lavoratori e le lavoratrici hanno inoltre ottenuto l’espresso riconoscimento di congedi di maternità e paternità, nonché la possibilità di lavorare in smart working conciliando al meglio i tempi di lavoro a quelli di vita. Anche per i datori di lavoro vi sono una serie di vantaggi: l’accordo permette ad ogni sala cinematografica di assumere lavoratori con contratto a termine fino al 40% del personale a tempo indeterminato, di prolungare il contratto a termine oltre i 24 mesi stipulando, alle condizioni prescritte, il c.d. contratto “in deroga” e quando le circostanze lo richiedono (per esempio in caso di eccezionali esigenze tecnico produttive) di contare sul lavoro straordinario dei propri dipendenti, anche oltre le 250 ore annuali.
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

Bollettino ADAPT 28 aprile 2025, n. 16
In data 9 Aprile 2025 come FeLSA CISL, insieme a Nidil e Uiltemp, abbiamo siglato un accordo nazionale con la piattaforma digitale Everli. L’intesa si colloca nel solco dell’accordo nazionale sottoscritto con l’Associazione Assogrocery nel febbraio 2024 per la disciplina del mondo e-grocery e la regolamentazione della figura dello shopper. La figura dello Shopper opera per il tramite della piattaforma digitale, occupandosi della preparazione del carrello di prodotti ordinati on line dal cliente, provvedendo a tutte le fasi dell’acquisto, raccolta, pagamento, distribuzione e recapito presso il domicilio del cliente. In Italia sono quasi 2.000 gli shopper e operano particolarmente in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna.
L’intesa aziendale sottoscritta con Everli (la principale piattaforma del settore in Italia) prevede un sistema di regolamentazione aziendale che valorizza l’affidabilità, l’esperienza e la qualità del servizio degli shopper. Oltre a riprendere gli elementi definiti nell’accordo nazionale quali compenso minimo per consegna, indennità per spesa pesante, indennità di disponibilità, diritto alla sospensione dell’account, tutela della malattia e dell’infortunio, permessi e altre tutele, l’accordo prevede una serie di diritti aggiuntivi e si prefigge l’obiettivo di implementare nuove prassi nella gestione dei rapporti lavorativi.
Tra i punti più significativi dell’intesa annoveriamo sicuramente i diritti sindacali, prevedendo l’introduzione e l’attivazione di permessi retribuiti e un’apposita bacheca online accessibile a tutti da tutti i territori. Su questo aspetto è importante evidenziare il ruolo che le rappresentanze sindacali aziendali hanno avuto, non solo nella gestione e conduzione della trattativa, ma soprattutto nel garantire una dinamica assolutamente partecipata di tutti i lavoratori all’andamento e valutazione del negoziato. Inoltre, è diventata ordinaria l’esperienza delle assemblee sindacali serali via Telegram. Pertanto, anche nell’ambito delle piattaforme digitali è possibile costruire una vera e viva rappresentanza sindacale.
La contrattazione inoltre interviene anche nella gestione dell’algoritmo, andando a definire una più equa gestione della distribuzione degli incarichi, visualizzazione delle proposte e prenotazione degli slot e orari lavorativi con l’obbiettivo di contrastare la discriminazione algoritmica, valorizzando e premiando al contempo gli shopper più meritevoli. Vengono identificate due platee differenti: gli shopper Senior, ovverosia coloro che vantano un’anzianità lavorativa importante e che svolgono questa attività in via prevalente e gli shopper junior, ossia tutti coloro che hanno appena effettuato iscrizione e accesso o svolgono questa attività come secondaria. È previsto anche un percorso per gli shopper che vogliano passare da junior a senior.
L’accordo interviene anche sul tema del bilanciamento vita lavoro: rispetto all’accordo di settore Assogrocery, sono implementate a 34 le giornate di sospensione dell’account per motivi di bilanciamento vita-lavoro. Si prevedono infine delle visite mediche a carico della piattaforma per tutti gli shopper e una formazione dedicata per lo svolgimento dell’attività.
L’accordo, il primo siglato tra OO.SS. e una piattaforma digitale, oltre a rappresentare un traguardo importante nell’ambito delle relazioni sindacali e nello sviluppo della contrattazione nei nuovi settori digitali, risulta fondamentale anche per la dinamica di partecipazione, attiva e propositiva, dei delegati Shopper che hanno potuto dare il loro concreto contributo al tavolo di trattativa.
Questa esperienza riconferma come la contrattazione sia lo strumento privilegiato per costruire tutele adeguate e pertinenti con il contesto di riferimento, in grado di coniugare gli elementi di autonomia di una tipologia contrattuale atipica, le esigenze di flessibilità delle imprese e le giuste rivendicazioni di tutela da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, anche al di fuori del classico schema del lavoro subordinato.
Daniel Zanda
Segretario Generale FeLSA CISL

Bollettino ADAPT 24 marzo 2025, n. 12
Il lavoro del futuro non è più un posto di lavoro ma un percorso caratterizzato da continue transizioni, lavorative, occupazionali e professionali. Quest’intuizione di Marco Biagi a distanza di vent’anni è quanto più attuale, in un contesto in cui le stesse trasformazioni digitali, ecologiche e demografiche impongono un ripensamento del lavoro che non è più una condizione statica, ma un processo che richiede un continuo adattamento. Questa prospettiva rappresenta un punto di partenza essenziale per l’apertura di questo convegno, dedicato quest’anno al tema giovani e lavoro, per i quali l’idea di un percorso personale e professionale in costruzione e continua evoluzione appare ancora più concreta.
Si tratta quindi di trovare e valorizzare strumenti e percorsi in grado di rendere possibili e facilitare queste transizioni, in grado, cioè, di affrontarne i rischi e coglierne le opportunità. Non si tratta di temi nuovi, né di strumenti inediti: molte delle soluzioni a cui farò di seguito riferimento avrebbero potuto essere adottate già in passato. Il loro valore risiede, quindi, nella consapevolezza che, oggi più che mai, debbano rappresentare il punto di partenza per orientare le politiche del lavoro e della formazione in una visione sistemica, in cui i diversi momenti formativi e professionali non siano considerati elementi separati, ma parte di un percorso interconnesso e continuo.
Parlando quindi di giovani e lavoro, è indubbio come la nostra riflessione debba partire dal tema del rapporto tra formazione e lavoro. Per anni si è infatti parlato della necessità di costruire un ponte tra formazione e mercato del lavoro. Oggi non si tratta più solo di creare connessioni, ma di promuovere una vera e propria integrazione, affinché i sistemi educativo e lavorativo non siano più concepiti come realtà separate, bensì come componenti dinamiche e interconnesse, capaci di accompagnare i soggetti lungo l’intero percorso professionale.
Strumenti come i percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento permettono agli studenti di affiancare lo studio a esperienze dirette nel mondo del lavoro, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e supportandoli nel loro percorso formativo, professionale e personale. Allo stesso modo, gli stage offrono un’opportunità concreta di acquisire esperienza in azienda, facilitando la comprensione delle dinamiche lavorative. Similmente l’apprendistato duale che rappresenta un modello formativo che integra studio e lavoro, garantendo una preparazione più pratica e aderente alle esigenze del mercato. E ancora, i percorsi universitari stessi, che non devono limitarsi alla formazione iniziale dei giovani, ma hanno il compito di contribuire alla formazione continua, creando veri e propri ecosistemi in cui istruzione, lavoro e ricerca si intrecciano. Infine, gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) che offrono percorsi di alta specializzazione tecnica in settori strategici, rispondendo alle esigenze delle imprese e dei territori, dunque rappresentando non un semplice modello formativo, ma un efficace strumento di integrazione tra istruzione e lavoro.
È anche evidente, alla luce di quanto detto, come la formazione non debba essere vista solo come uno strumento per l’inserimento professionale, ma come una leva strategica per lo sviluppo personale e l’aggiornamento continuo, garantendo che le competenze e le professionalità stesse non diventino obsolete. In questo quadro, i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua assumono un ruolo centrale, con le parti sociali che ne guidano la definizione e l’implementazione, così come risulta centrale garantire la trasparenza delle competenze mediante meccanismi di certificazione.
Gli attori delle relazioni industriali e del mercato del lavoro sono quindi chiamati a contribuire alla programmazione strategica delle politiche formative, oltre che di quelle del lavoro, assumendo un ruolo attivo nel comprendere e abilitare queste transizioni attraverso strumenti e percorsi dedicati.
Le parti sociali in parte hanno già colto questo invito come dimostrano alcuni rinnovi contrattuali dello scorso anno. Con riferimento all’apprendistato, nel CCNL Terziario Confcommercio, ad esempio, sono stati aggiornati i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, garantendo una maggiore aderenza tra formazione e competenze richieste dal mercato del lavoro; ancora il CCNL Distribuzione Moderna Organizzata che ha introdotto una disciplina strutturata in materia, con un focus invece sull’apprendistato duale, confermando dunque la necessità di un’integrazione tra formazione e lavoro; e similmente il CCNL Studi Professionali che lo ha esteso anche al praticantato, rafforzando così le tutele per i giovani professionisti. Con riferimento alla certificazione delle competenze, è opportuno richiamare invece il CCNL Elettrico che ha previsto l’istituzione di un libretto formativo digitale per documentare e attestare le conoscenze acquisite dai lavoratori. Un ruolo cruciale è inoltre affidato agli osservatori e comitati bilaterali, incaricati di analizzare i fabbisogni del settore, come previsto dal CCNL Industria Alimentare. Interessante, infine, come tutti i CCNL del settore alimentare venga promossa una possibile soluzione alla tensione tra formazione e lavoro con l’introduzione del patto formativo, che vincola il lavoratore a rimanere in azienda per un periodo di tempo determinato dopo aver usufruito di specifici percorsi di formazione.
In conclusione, nel dibattito attuale sul rapporto tra giovani e lavoro, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali hanno quindi la responsabilità di guidare la costruzione dei mercati del lavoro che è diventata costruzione sociale dei mestieri e delle competenze. In questo senso, la governance deve essere ripensata in chiave solidale, promuovendo un patto sociale sul tema tra governo e parti sociali, ma anche incentivando la collaborazione a livello europeo e a livello territoriale e aziendale. Da un lato, infatti, come già evidenziava il professor Biagi all’inizio degli anni 2000, limitarsi alla prospettiva nazionale non è più sufficiente di fronte alle sfide globali e dunque “l’impegno delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali su scala comunitaria potrebbe proprio essere quello di negoziare un’intesa che costituisca il presupposto per un intervento comunitario sui temi richiamati”, con riferimento alla costruzione di percorsi formativi di qualità, invito che fra l’altro sembra essere stato, almeno in parte, accolto dalla recente intesa europea tra Commissione e parti sociali cross-settoriali sul dialogo sociale. Dall’altro, è anche necessario rafforzare il principio di sussidiarietà, privilegiando accordi locali tra istituzioni, imprese, parti sociali, scuole e università, tali da integrare e favorire una transizione più fluida tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro.
Il quadro giuridico-istituzionale e le relazioni industriali sono chiamati a rispondere a questa sfida, integrando effettivamente il concetto di transizione nella definizione delle politiche normative e nella regolazione delle dinamiche delle relazioni industriali, per sviluppare una nuova visione strategica a lungo termine che metta al centro non più i posti di lavoro o semplicemente “il lavoratore”, ma la persona, a partire dai giovani.
PhD Candidate ADAPT – Università di Siena
*Intervento dell’autrice al Convegno in memoria di Marco Biagi “Giovani e Lavoro: l’attualità del pensiero di Marco Biagi”, CNEL, Roma, 18 marzo 2025