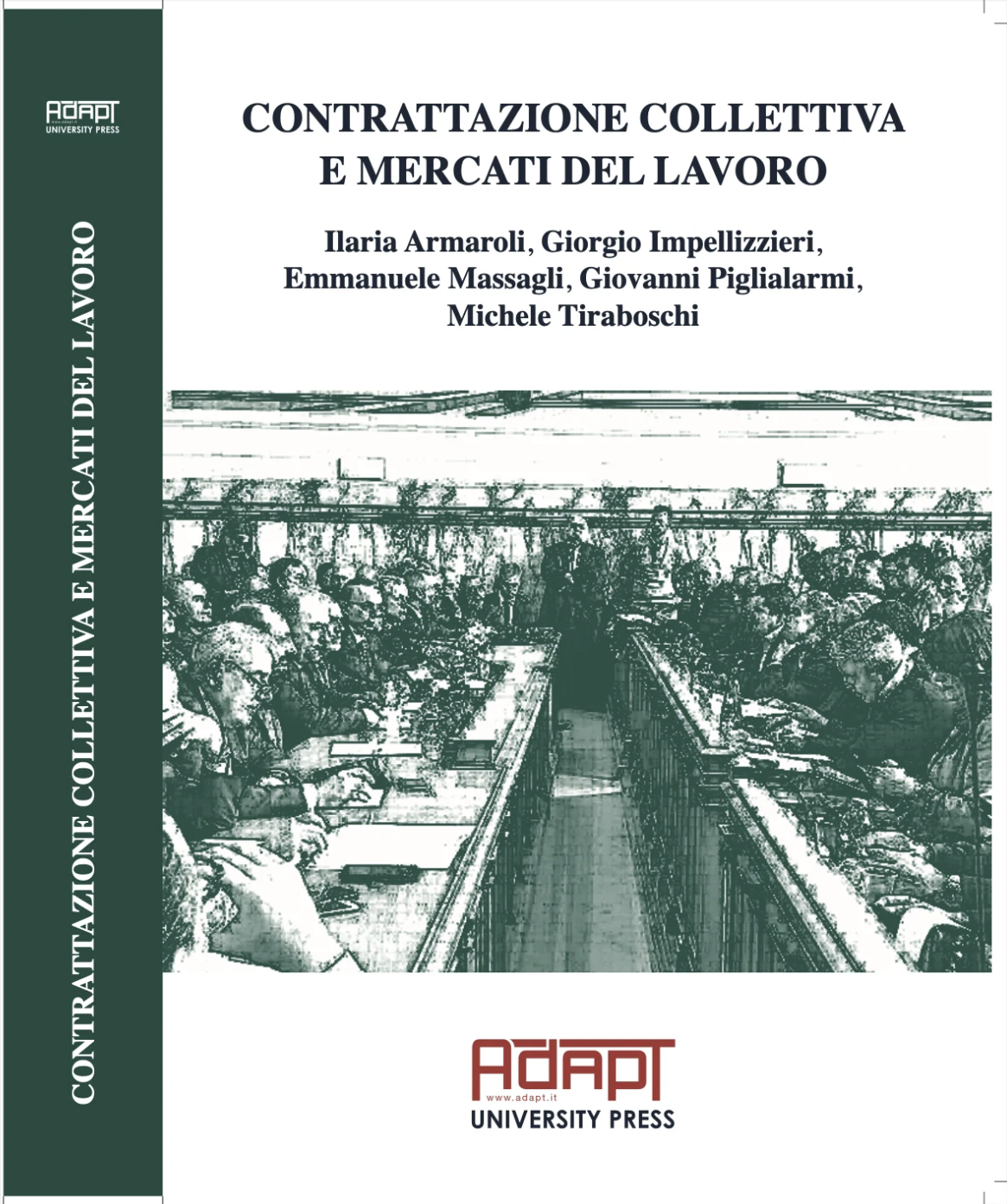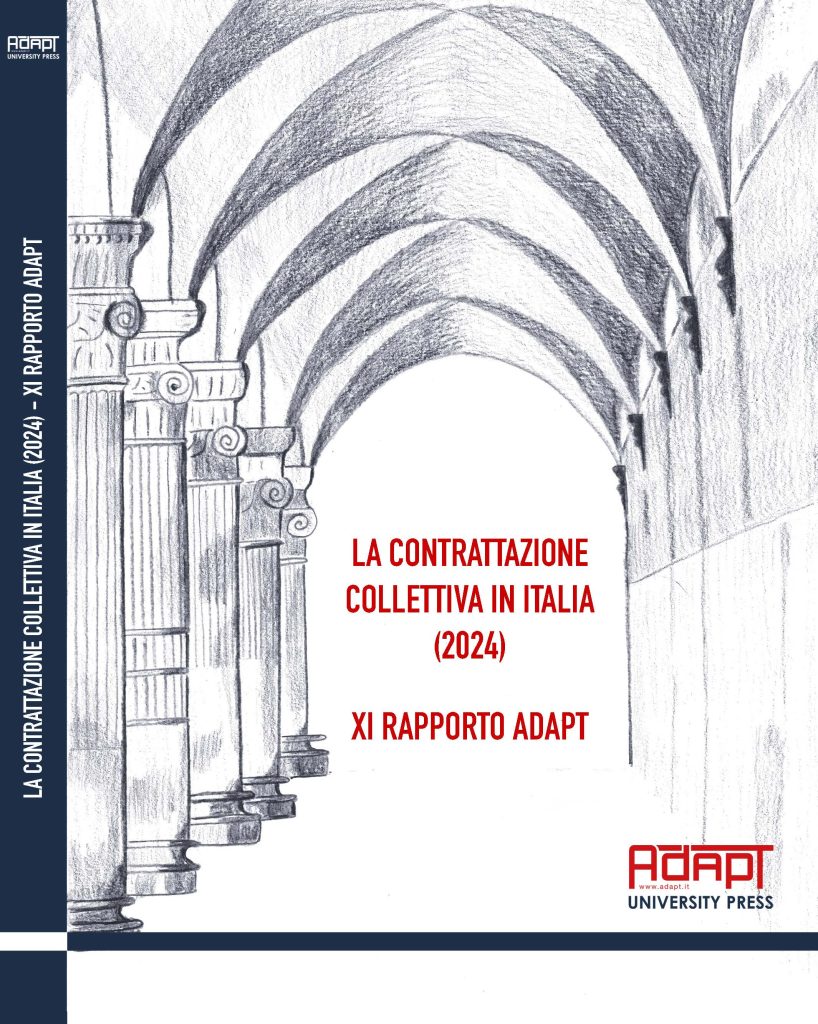Bollettino ADAPT 7 aprile 2025, n. 14
Benché la sua definizione per via contrattuale sia promossa attraverso i medesimi incentivi fiscali dei più noti premi di risultato, la partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa resta una pratica poco conosciuta. Per verificarne l’effettiva diffusione non giovano in effetti nemmeno i report ministeriali sui premi di produttività, che pur analizzando tutti i contratti depositati ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all’arti. 1, co. 182 della legge di bilancio per il 2016, non riportano dati in merito.
Eppure, la distribuzione ai lavoratori degli utili dell’impresa ha origini lontane nel nostro ordinamento. Già il Codice civile del 1942 contemplava, tra le diverse modalità con cui retribuire i lavoratori dipendenti, la partecipazione agli utili (“Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”, art. 2099, co. 3, c.c.), quale forma di retribuzione variabile legata all’andamento e ai risultati dell’impresa.
Oggi, come anticipato, la partecipazione agli utili è annoverata tra le quote di retribuzione che, laddove introdotte da accordi aziendali o territoriali stipulati ai sensi dell’art. 51, d. lgs. n. 81/2015 (organizzazioni dotate di maggiore rappresentatività a livello comparato), possono godere della fiscalità di vantaggio (con imposta sostitutiva dell’Irpef) al pari dei premi di risultato (l. n. 208/2015 e s.m.i.).
Si tratta, a ben vedere, di una modalità alternativa a detti premi, con cui però condivide (in cumulo) sia il medesimo limite annuo (3.000 euro lordi), sia il reddito annuo massimo pro-capite per quanto concerne la platea di lavoratori ammessi a tassazione agevolata (80.000 euro lordi).
L’art. 3, d. interm. 25 marzo 2016 (attuativo della l. n. 208/2015), si preoccupa di chiarire come ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, per partecipazione agli utili si intende l’erogazione di somme ai sensi dell’art. 2102 c.c., in base cioè agli utili netti dell’impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
Tale forma di retribuzione non è dunque da confondere con i più classici obiettivi di redditività aziendale, calcolati sulla base di indicatori di fatturato o anche utile, che concorrono invece alla determinazione dei tradizionali premi di risultato, e che, a differenza degli utili netti redistribuiti ai dipendenti, danno accesso agli sgravi fiscali solo a fronte del rispetto del requisito di incrementalità.
Nonostante le lacune nel monitoraggio ministeriale di queste forme di retribuzione, sporadiche casistiche emergono dagli ultimi rapporti sulla contrattazione decentrata della Fondazione Di Vittorio della Cgil (2024) e dell’Osservatorio OCSEL della Cisl (2021), nonché interrogando la banca dati sui contratti collettivi della Scuola di ADAPT. Tra gli esempi più virtuosi possiamo segnalare l’accordo Maglificio Miles (1° luglio 2022), dove viene definita la distribuzione di parte degli utili netti d’impresa, con soglie e costi massimi in base all’utile conseguito, introducendo poi un meccanismo di riparametrazione individuale dell’importo in base alla presenza.
Nel complesso, però, gli attuali incentivi sembrano non aver favorito la diffusione di questa modalità di retribuzione. Anche per questa ragione, probabilmente, il disegno di legge A.S. n. 1407 sulla partecipazione dei lavoratori, attualmente in discussione al Senato, frutto della proposta di legge Cisl presentata a fine novembre 2023 e delle modiche intervenute in sede di esame alla Camera dei Deputati, intende promuovere ulteriormente la misura, prevedendo che per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, il limite dell’importo soggetto all’imposta sostitutiva sia elevato a 5.000 euro lordi. Ma il fronte sindacale appare diviso. La Cgil, ad esempio, sostiene che la partecipazione agli utili “non rispetti la tradizionale distinzione tra proprietà e dipendenti” (Audizione informale della Cgil, VI Commissione Finanze e XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato Camera dei Deputati, 1° febbraio 2024) e rimanda piuttosto alla contrattazione dei premi di risultato.
Avremo tempo, nei prossimi mesi, di conoscere l’esito dell’iter parlamentare del disegno di legge e se sarà sufficiente a inaugurare un nuovo corso. Basterà per questo il (semplice) potenziamento degli attuali vantaggi fiscali? La cautela è d’obbligo, se pensiamo anche a vecchie misure di incentivazione della partecipazione finanziaria (ci riferiamo ad un particolare fondo introdotto con legge del 2013 e istituito con apposito decreto nel 2016) poco o nulla note e sulle quali non si ha notizia di monitoraggi o esperienze di valore.
Ricercatrice ADAPT Senior Fellow
 @ilaria_armaroli
@ilaria_armaroli
Ricercatore ADAPT Senior Fellow