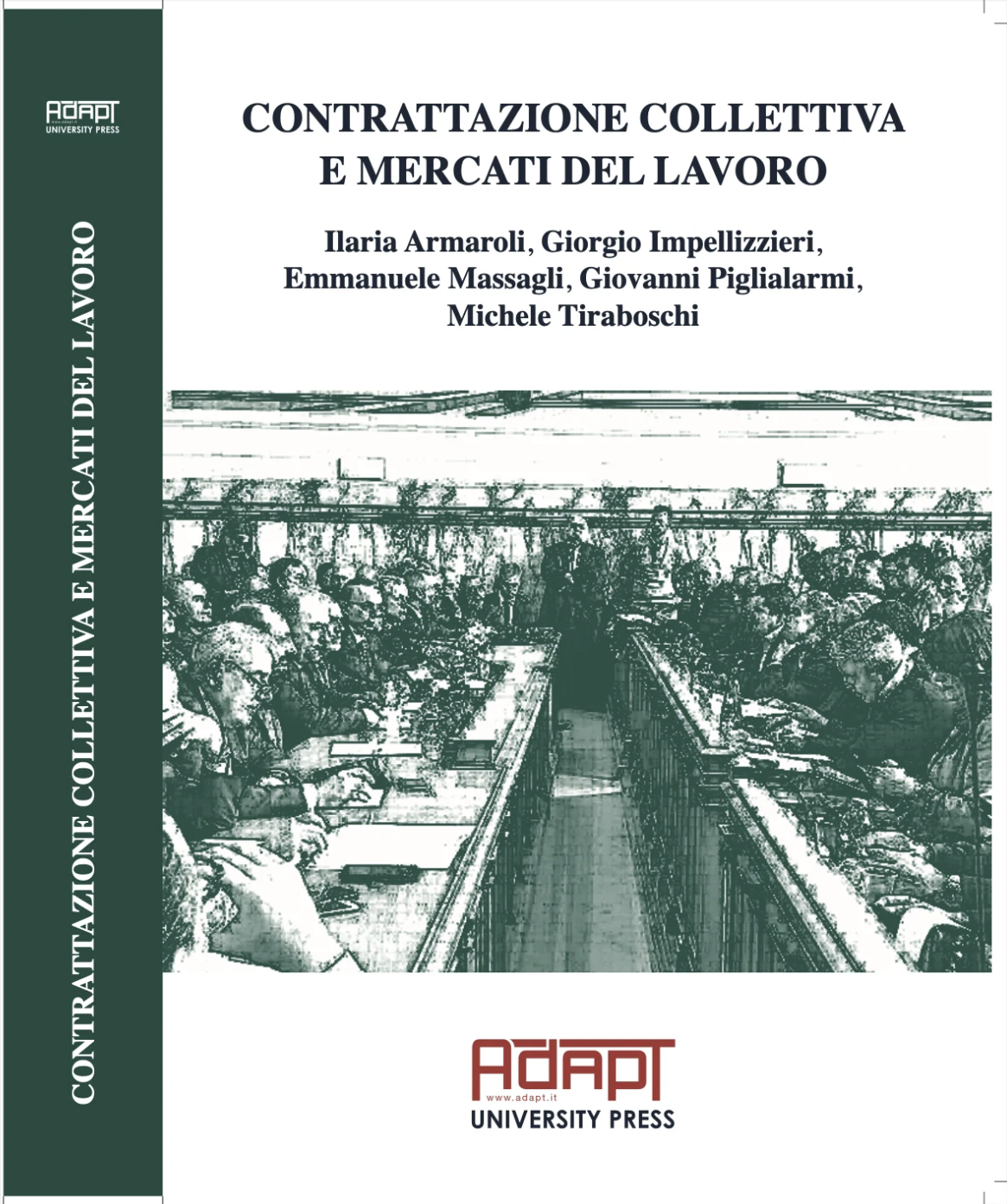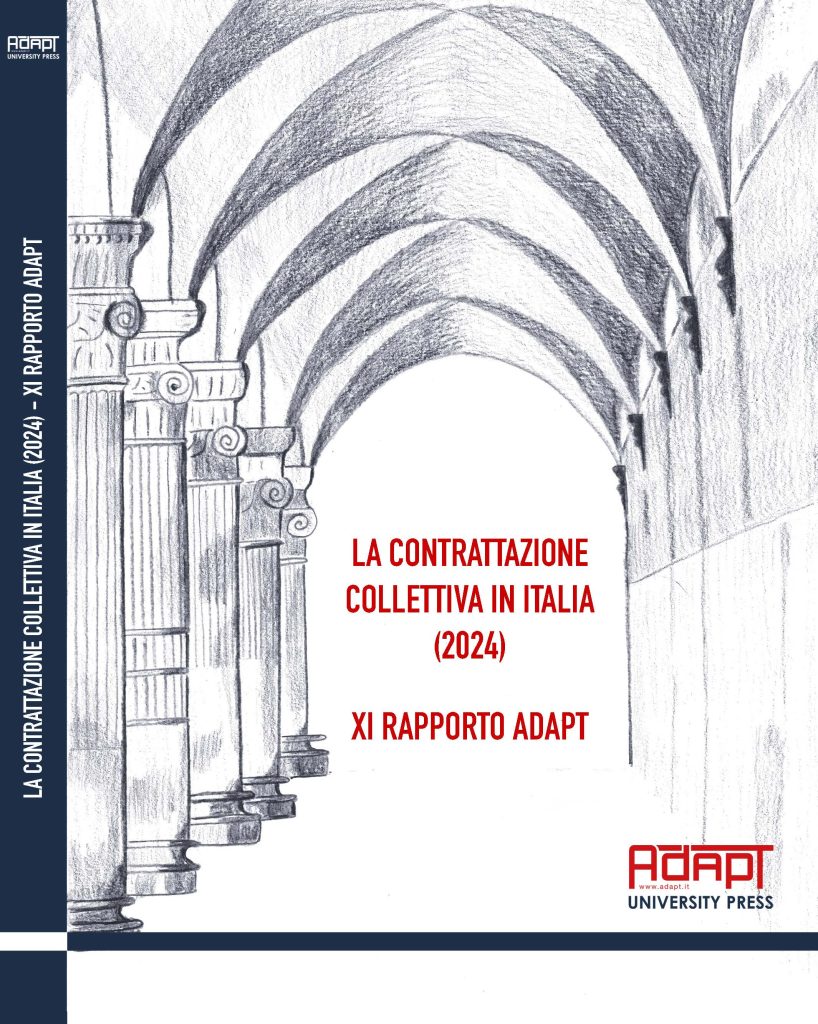|
La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del
Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.
Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –
potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it
|
Bollettino ADAPT 19 maggio 2025, n. 19
Contesto del rinnovo
Il 16 aprile 2025 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dell’Industria dell’Energia e del Petrolio, scaduto il 31 dicembre 2024. L’intesa è stata raggiunta tra Confindustria Energia, in rappresentanza della parte datoriale, e le organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, e sarà in vigore dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.
Il contratto coinvolge circa 40.000 lavoratori e 34 imprese operanti in un ampio spettro di attività strategiche per il sistema energetico nazionale: dall’esplorazione e produzione di idrocarburi alla raffinazione, dalla distribuzione e vendita di prodotti petroliferi al trasporto e rigassificazione del gas, fino alla cogenerazione, produzione di energia elettrica e attività di ricerca su fonti fossili e rinnovabili, nonché alla logistica integrata.
Il rinnovo si inserisce in un quadro contrattuale dinamico, distinguendosi per la rapidità con cui è stato raggiunto: a meno di due mesi dall’avvio ufficiale delle trattative, avvenuto il 26 febbraio 2025. Le Parti hanno affrontato il negoziato con senso di responsabilità e attenzione congiunta alla dimensione sociale e industriale, con la consapevolezza che il CCNL debba essere uno strumento stabile e aggiornato capace di rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese in un contesto economico caratterizzato da forti elementi di incertezza e trasformazione.
Parte economica
L’ipotesi di rinnovo per il triennio 2025–2027 introduce un incremento del TEM pari a 311 euro, articolato in più tranche.
In particolare, 134 euro sono destinati al recupero dello scostamento inflattivo registrato nel biennio 2022–2023 (in aggiunta a quanto già previsto dall’accordo del 31 luglio 2024), e verranno corrisposti entro il primo trimestre del 2025 con le seguenti modalità: 100 euro di aumento sui minimi, erogati a partire da gennaio 2025, e 34 euro a titolo di EDR IPCA (Elemento Distinto della Retribuzione) da marzo 2025.
Gli adeguamenti retributivi relativi al nuovo periodo di vigenza contrattuale, subordinatamente all’approvazione dell’ipotesi di accordo da parte delle assemblee dei lavoratori, seguiranno le seguenti decorrenze: 30 euro sui minimi da dicembre 2025; 20 euro sui minimi e 7 euro sull’EDR da gennaio 2026; 55 euro sui minimi da luglio 2026; 65 euro sui minimi da luglio 2027.
Infine, il rinnovo contrattuale prevede altresì un rafforzamento del sistema di assistenza sanitaria integrativa attraverso un incremento di 5 euro mensili del contributo al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa FASIE, con l’obiettivo di potenziare le tutele sanitarie a favore dei lavoratori del settore.
Parte normativa
Il rinnovo contrattuale per il triennio 2025–2027 introduce un pacchetto articolato di novità normative che rispondono alle trasformazioni del contesto produttivo, sociale e tecnologico, con l’obiettivo di rafforzare la tutela del lavoro, promuovere l’equità, valorizzare le competenze e migliorare le condizioni complessive del personale del settore.
Innanzitutto, viene modificata la disciplina relativa al contratto di lavoro a tempo determinato, stabilendo che la sua durata sia di 12 mesi, in conformità alla normativa vigente. Le parti, tuttavia, concordano sull’istituzione di una commissione bilaterale incaricata di definire, entro dicembre 2025, le condizioni previste dall’art. 19, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/2015. Fino a suddetta data, le parti condividono la possibilità di apporre un termine sino a 24 mesi ai contratti a tempo determinato per “aumentate esigenze temporanee connesse allo svolgimento di attività specifiche e determinate, anche connesse alla realizzazione di commesse/progetti/impianti”.
Un’altra delle innovazioni di maggiore rilievo è l’esclusione dal computo del periodo di comporto per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e degenerative. La misura, coerente con un approccio di maggiore attenzione al benessere e alla dignità delle persone, mira a garantire la continuità occupazionale per i lavoratori che affrontano situazioni sanitarie particolarmente complesse, garantendo così al lavoratore la conversazione del posto di lavoro oltre i limiti temporali previsti dal CCNL.
Il contratto interviene inoltre sulla disciplina delle ferie, anticipando il periodo di maturazione per l’accesso al successivo scaglione di ulteriori cinque giorni di ferie per gli addetti del settore. Il requisito di anzianità, precedentemente fissato a sette anni, viene ridotto a cinque anni a partire dalla vigenza del nuovo accordo, e sarà ulteriormente anticipato a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2028. In parallelo, viene regolamentato in modo più strutturato l’istituto della cessione a titolo gratuito delle ferie eccedenti le quattro settimane, promuovendo la solidarietà interna nei luoghi di lavoro e rafforzando le misure di sostegno ai lavoratori in condizioni di fragilità sociale o familiare. Infatti, il nuovo contratto stabilisce che i lavoratori possano cedere volontariamente le proprie ferie residue ad altri colleghi che si trovino in particolari situazioni di bisogno, quali: genitori di figli minori che necessitano di cure costanti, genitori di figli maggiorenni affetti da gravi patologie, donne vittime di violenza. Il CCNL specifica la procedura da seguire per l’attivazione di tale istituto, con la possibilità di definire ulteriori modalità regolative in sede aziendale.
Il rinnovo dedica una parte centrale alla formazione, riconosciuta come leva strategica per la competitività del settore e per l’occupabilità dei lavoratori. A tal fine, viene istituito il libretto formativo del lavoratore, uno strumento che certifica le competenze acquisite sia tramite percorsi formativi sia attraverso esperienze professionali maturate nel tempo. Questo strumento dovrà diventare uno strumento di certificazione della formazione eseguita dal singolo lavoratore e quindi esigibile ed utilizzabile anche per la valorizzazione dei processi di accrescimento professionale ed operativo utili alla determinazione delle schede di valutazione ai fini del CREA. Viene inoltre promossa la diffusione della formazione su temi di diversity, equity e inclusion, nonché la formazione congiunta di HSE manager, RSPP, ASPP, RLSA sui temi di salute e sicurezza, dunque favorendo il confronto e la condivisione di esperienze fra tutti i soggetti coinvolti sul tema.
Il nuovo contratto, inoltre, aumenta il monte ore annuo di permessi a disposizione dell’RLSA per svolgere le funzioni del ruolo, alzandolo da 72 a 80 ore e introduce l’RLSA di sito, definito anche RLSP, con l’obiettivo di rafforzare il presidio della salute e sicurezza nei contesti produttivi complessi. A tale figura viene riconosciuto un ampliamento delle ore annue a disposizione, che passano da 16 a 24, e un ruolo rafforzato nella partecipazione ai processi aziendali legati alla prevenzione, alla formazione e alla gestione del rischio. Come specificato dal rinnovo stesso, infatti il RLSP potrà intervenire nelle riunioni di coordinamento, confrontarsi con la funzione HSE del sito per l’approfondimento di tematiche specifiche, accedere ai luoghi di lavoro e ai documenti relativi alla valutazione dei rischi del sito, nonché collaborare con le altre figure della rappresentanza alla sicurezza e ricevere informazioni su eventuali ispezioni o verifiche da parte degli organi di vigilanza.
Parallelamente, viene introdotta la figura del Rappresentante per la Diversity, Equity & Inclusion, con il compito di promuovere politiche aziendali improntate all’inclusione, al rispetto delle pari opportunità e al superamento di eventuali discriminazioni, con un’attenzione specifica al monitoraggio e al contrasto del divario salariale di genere. Questa nuova figura si inserisce nel più ampio impegno contrattuale verso la costruzione di ambienti di lavoro equi, diversificati e inclusivi.
Nella direzione di garantire la giusta attenzione per i lavoratori, sono state migliorate le previsioni contrattuali in materia di orario di lavoro. Le parti, infatti, hanno concordato una riduzione dell’orario di lavoro per i turnisti, prevedendo una riduzione del numero annuo di giornate lavorative, che passa da 231,5 a 231 giornate annue. Inoltre, è stato prevista la trasformazione di due mezze giornate in due giornate intere di permesso per il 24 e 31 dicembre.
Ancora, il diritto allo studio viene ulteriormente potenziato ed esteso, riconoscendo a un numero maggiore di lavoratori la possibilità di richiedere permessi retribuiti. Viene inoltre promossa la genitorialità, incentivando la stipula di accordi aziendali che prevedano condizioni più favorevoli rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente. In materia di disabilità, si favorisce l’adozione di accomodamenti ragionevoli per garantire alle persone con disabilità una piena parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori.
Infine, viene istituita una commissione paritetica con il compito di valutare la coerenza e l’adeguatezza dell’attuale sistema classificatorio. L’obiettivo è definire un nuovo modello capace di riconoscere e valorizzare le competenze emergenti, le nuove professionalità e le trasformazioni organizzative in atto nel settore, rendendo il sistema di inquadramento più flessibile e orientato al futuro.
Parte obbligatoria
Nel rinnovo del CCNL Energia e Petrolio 2025–2027, la premessa è stata ampiamente rivista, assumendo un tono strategico e programmatico che riflette la complessità del contesto attuale. Le parti hanno sottolineato come il contratto venga rinnovato in una fase storica segnata da profonde trasformazioni: la crisi energetica internazionale ha messo in luce la fragilità del sistema europeo e nazionale, mentre la transizione verso un’economia decarbonizzata e la rivoluzione digitale stanno ridefinendo profondamente l’organizzazione del lavoro. In questo scenario, al centro del cambiamento viene posta la persona, riconosciuta non più come semplice esecutore ma come attore consapevole e partecipe delle trasformazioni.
Il contratto ha quindi rafforzato il ruolo della partecipazione dei lavoratori, riaffermandone l’importanza tanto sul piano organizzativo quanto su quello strategico. In coerenza con i principi del Patto per la Fabbrica del 2018, che ha ridefinito il modello contrattuale italiano valorizzando il secondo livello di contrattazione e il ruolo attivo delle parti sociali, il CCNL riconosce la necessità di consolidare strumenti e sedi di confronto che permettano ai lavoratori e alle loro rappresentanze di contribuire in modo consapevole alle scelte aziendali fondamentali. In un contesto segnato da profonde trasformazioni legate all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione e alla transizione ambientale, le parti hanno rilanciato con decisione il tema della bilateralità e del dialogo strutturato tra rappresentanze datoriali e sindacali, con l’obiettivo di costruire un sistema partecipativo.
Interessante, infine, come le parti, riconoscendo la complessità della questione e le recenti trasformazioni organizzative, abbiano deciso di istituire una commissione bilaterale con il compito di esaminare le specificità dei lavoratori con contratto estero, concentrandosi sulla tutela dei diritti sindacali, sulle forme di rappresentanza, nonché sulle modalità di comunicazione e accesso alle informazioni sindacali. L’obiettivo è identificare soluzioni condivise che garantiscano un’adeguata protezione e valorizzazione del loro ruolo nel contesto internazionale.
Valutazione d’insieme
Nel suo impianto normativo complessivo, il rinnovo del CCNL Energia e Petrolio adotta un approccio pragmatico e inclusivo, orientato a rafforzare il legame tra persone e imprese. Le Parti firmatarie hanno definito una serie di strumenti finalizzati a rendere l’organizzazione del lavoro sempre più attenta alle esigenze sociali, con particolare riguardo ai lavoratori fragili, ai giovani e al benessere complessivo dei dipendenti. In questa direzione si collocano misure significative, come l’esclusione del periodo di comporto per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, il potenziamento delle tutele in materia di orario di lavoro e l’anticipo, dal settimo al quinto anno di anzianità, dell’accesso al nuovo scaglione di ulteriori cinque giorni di ferie. A completare il quadro, l’incremento delle risorse destinate al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa FASIE, che testimonia l’impegno a rafforzare il welfare contrattuale, nella prospettiva di una maggiore sostenibilità sociale e coesione all’interno del settore.
Alice Cireddu
Apprendista di ricerca presso Edison S.p.A.


 @MicheTiraboschi
@MicheTiraboschi