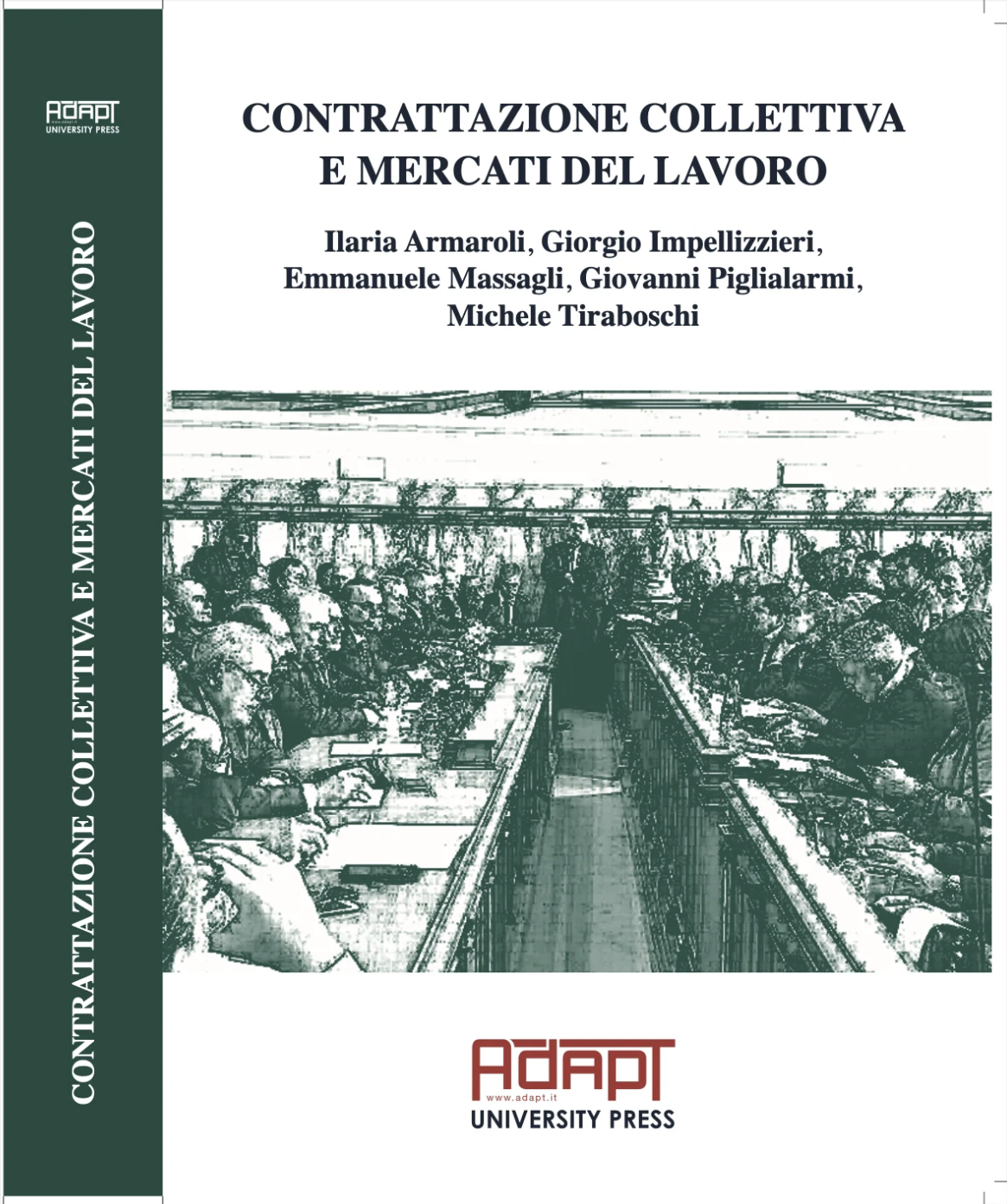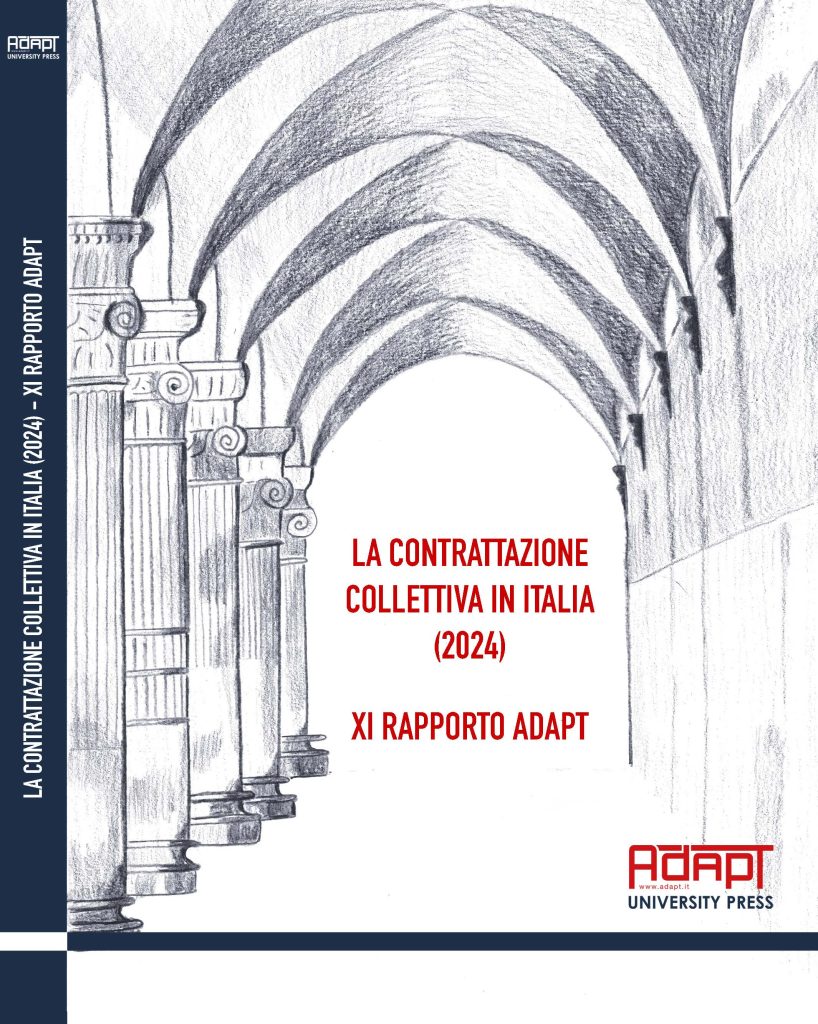Rischi psicosociali e benessere dei dipendenti: i risultati di un progetto sulla salute mentale nel settore metalmeccanico in Italia

Bollettino ADAPT 17 marzo 2025, n. 11
Nell’ambito di un progetto co-finanziato dall’Unione Europea, “IncreMe(n)tal – Increasing Metalworkers’ representatives’ Awareness and Skills on Mental Health Protection & Promotion in the Workplace” un gruppo di ricercatrici di Fondazione ADAPT e ADAPT sta indagando il tema della salute mentale dei lavoratori e delle lavoratrici nel settore metalmeccanico in Italia, insieme a un gruppo di esperti a cui è affidato l’approfondimento dello stesso tema in altri 6 paesi target (Belgio, Irlanda, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia).
Il progetto, coordinato dalla FIM-CISL, vede la partecipazione di diversi enti di ricerca, università e parti sociali e mira a fornire una formazione di qualità ai sindacalisti e ai rappresentanti dei lavoratori nell’industria metalmeccanica nei 7 paesi target e a livello transnazionale.
È già disponibile online un primo report che sintetizza i risultati delle attività di ricerca documentaria e sul campo condotte nel primo anno di progetto, con un focus proprio sul contesto italiano (Deliverable 2.1. “National Highlight – Italia”). In particolare, il report dà conto sia del contesto normativo e teorico di riferimento in materia di rischi psicosociali, organizzazione del lavoro e salute mentale dei dipendenti, sia di quanto emerso dalla somministrazione di un questionario a 35 lavoratori e lavoratrici e la conduzione di interviste a 5 rispondenti (due rappresentanti dei lavoratori a livello aziendale, uno a livello nazionale e due rappresentanti aziendali del dipartimento risorse umane) impiegati nel settore metalmeccanico. La ricerca sul campo, strutturata coerentemente al quadro di riferimento delineato a livello europeo dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) in materia di rischi psicosociali, ha consentito di verificare i risultati della ricerca desk effettuata.
Prima di dare conto di alcuni risultati, occorre anzitutto chiarire quali sono i fattori associati al lavoro che possono generare un peggioramento del benessere dei dipendenti. Riprendendo il framework teorico definito a livello europeo all’Eurofound, i fattori che hanno un effetto negativo sulla salute mentale e fisica dei dipendenti sono legati a quegli aspetti del lavoro che richiedono uno sforzo della persona che comporta con un costo fisico, psicologico e sociale (c.d.“Job stressors”[1]).
Attraverso il questionario, è stato chiesto ai rispondenti qual è il livello di importanza associato ai diversi job stressors che hanno potenzialmente un effetto negativo sulla salute mentale e sul benessere dei dipendenti.
Secondo circa un terzo dei rispondenti al questionario, tutti i fattori di rischio correlati al lavoro inclusi nell’indagine sono almeno moderatamente importanti nelle loro aziende/nel settore metalmeccanico.
Per oltre il 40% degli intervistati alcuni fattori di rischio sono molto importanti, come la scarsa comunicazione all’interno dell’azienda e la percezione di azioni discriminatorie alla luce di determinate caratteristiche personali che portano all’adozione di comportamenti sfavorevoli. Secondo quasi la metà degli intervistati (46%), le preoccupazioni finanziarie e l’interferenza tra lavoro e vita privata sono fattori di rischio psicosociale particolarmente importanti. Secondo l’85% degli intervistati, avere difficoltà a trattare certi argomenti con un i propri superiori e colleghi rappresenta un fattore importante che incide negativamente sul benessere dei lavoratori, così come incidono negativamente – secondo circa l’80% dei rispondenti – molestie, violenze, abusi, in generale, la presenza di atteggiamenti e azioni discriminatorie.
Il 35% dei rispondenti ha valutato il benessere mentale generale nella propria organizzazione come scarso, il 31% come buono e il 23% come accettabile. Quasi la metà dei rispondenti al questionario, inoltre, ritiene che l’ambiente di lavoro abbia un’influenza piuttosto forte sul benessere e sulla salute mentale (46%).
Per quanto riguarda le azioni per la prevenzione e la gestione dei rischi psicosociali, è stato chiesto ai partecipanti quali sono le iniziative concretamente intraprese nelle aziende o più in generale nel settore di appartenenza.
I risultati mostrano che i rischi psicosociali sono oggetto di specifiche politiche nel 42% dei casi. Tuttavia, una percentuale pressoché analoga (38%) si registra in direzione opposta. Le azioni più frequentemente affrontate nelle policy aziendali sono quelle contro i comportamenti sociali avversi (62%), le discriminazioni (42%). Gli effetti negativi generati da un’organizzazione del lavoro inefficiente, ad esempio carichi di lavoro eccessivi, orari di lavoro non socievoli e interferenze negative tra lavoro e vita personale/familiare, sono raramente presi in considerazione.
La presenza di fattori di stress lavoro-correlati nel contesto organizzativo può essere rintracciata attraverso la rilevazione di alcuni sintomi e/o segnali. Da questo punto di vista, l’indagine ha individuato tra i più comuni: stress (19%), burnout (14%), ansia e presentismo (13%) ed esaurimento (12%). Secondo il 65% dei partecipanti, questi sintomi sono sperimentati in particolare dai lavoratori appartenenti a gruppi di lavoratori più vulnerabili, in particolare coloro con condizioni contrattuali precarie (75%) e le donne (69%).
Nonostante l’incremento dell’attenzione al tema della salute mentale a seguito della pandemia di COVID-19, tuttavia, la mancanza di consapevolezza sul tema a livello aziendale è stata individuata come un ostacolo alla prevenzione e gestione dei rischi psicosociali dagli intervistati, sia sul versante aziendale che sindacale. Un ulteriore ostacolo è lo stigma, visto che molti lavoratori non parlano dei loro problemi per paura di essere giudicati o penalizzati nella loro carriera.
Per comprendere meglio quali azioni ed eventi rappresentano una minaccia per la salute mentale e l’integrità psicofisica dei lavoratori, è stata poi approfondita la percezione dei rispondenti con riferimento a fatti, atti e atteggiamenti discriminatori.
I dati raccolti mostrano che un terzo dei rispondenti ritiene che i lavoratori siano leggermente esposti a molestie (sessuali/verbali/di genere). Il 40% afferma che i lavoratori sono leggermente esposti a bullismo e quasi la metà (48%) ritiene che vi sia anche una leggera esposizione a minacce. Un’esposizione moderata è registrata in relazione all’abuso verbale (36%) mentre un quinto dei rispondenti afferma che è presente anche in relazione a molestie e bullismo. Tuttavia, quasi nessuno dei comportamenti considerati sarebbe estremamente diffuso, tanto che si registrano percentuali prossime allo zero per il livello massimo di esposizione.
Attraverso il questionario è stato poi chiesto se nelle aziende sono presenti dei fattori che invece supportano i dipendenti nel contrastare la presenza di fattori legati al lavoro che generano un impatto negativo sulla salute (c.d. “Job Resources”[2]). Sul punto, i dati mostrano la disponibilità delle risorse lavorative risulta inferiore al 50% per 13 delle 14 categorie analizzate. L’unica eccezione riguarda la retribuzione adeguata, che il 57% degli intervistati considera disponibile.
Più in generale, dalla ricerca condotta emerge che il tema della salute mentale è probabilmente ancora difficile da gestire a livello aziendale. Il 42% dei rispondenti ritiene che la cultura aziendale a supporto della salute mentale dei dipendenti sia scarsa e il 29% ritiene che sia molto scarsa.
Per migliorare la cultura aziendale in merito all’importanza della salute mentale e del benessere dei dipendenti, è necessario aumentare la consapevolezza relativamente ai rischi psicosociali, secondo ben l’83% degli intervistati.
Ciò è particolarmente importante soprattutto se si considera che i nuovi modelli organizzativi possono avere una significativa incidenza sulla salute mentale dei lavoratori. Ad esempio, le connessioni tra digitalizzazione e salute mentale risultano particolarmente evidenti: i rischi psicosociali più frequentemente menzionati da parte degli intervistati sono infatti la ridotta interazione sociale (in particolare legata al lavoro da remoto) e l’eccessiva porosità tra vita privata e lavorativa. Le interviste evidenziano anche la rilevanza di questioni come l’aumento dell’orario di lavoro, la difficoltà nel chiedere supporto ai colleghi, il crescente senso di inadeguatezza correlato alla necessità di un continuo aggiornamento delle competenze digitali e i ritmi di lavoro sempre più frenetici.
Nel report viene altresì approfondito il ruolo delle parti sociali nell’affrontare la tematica dei rischi psicosociali sul posto di lavoro. Dalla ricerca sul campo è emerso, da un lato, che attualmente la salute mentale sembra non ricoprire un ruolo centrale nelle agende dei sindacati. Invero, il benessere dei dipendenti e la salute mentale sono temi oggi menzionati solo in relazione a questioni quali l’equilibrio tra lavoro e vita privata o il diritto alla disconnessione. Dall’altro lato, invece, è emerso che la contrattazione collettiva è considerata uno strumento fondamentale per la tutela della salute mentale dei lavoratori.
In conclusione, i risultati descritti nel report consentono di evidenziare due questioni principali. La prima è la necessità di fare luce sul ruolo attuale e potenziale della contrattazione collettiva per sostenere il benessere dei dipendenti. Ciò ha portato a indagare sia sulle misure riconosciute a livello nazionale, ad esempio attraverso l’assistenza sanitaria integrativa, sia a livello aziendale, attraverso la rilevazione di buone pratiche aziendali provenienti dal settore metalmeccanico e che sviluppano diverse strategie proprio in tema di benessere e salute mentale dei dipendenti. La seconda questione afferisce invece alla necessità di promuovere la diffusione di una cultura maggiormente sensibile al tema della salute mentale, anche in ambito sindacale. Da questo punto di vista, la formazione che verrà sviluppata nell’ambito del progetto IncreMe(n)tal, sia a livello nazionale che transnazionale, può essere utile per fare un passo avanti in questa direzione.
PhD Candidate ADAPT – Università di Siena
[1] Sono considerati “job stressors” ovvero fattori di rischio i seguenti: a) Comportamenti sociali negativi (abuso verbale o minacce, bullismo, molestie o violenza); b) Scarsa comunicazione all’interno dell’organizzazione c) Scarsa cooperazione all’interno dell’organizzazione; c) Paura di perdere il lavoro; d) Richieste emotive (dover affrontare superiori, colleghi difficili, ecc.); e) Orari di lavoro antisociali (lavorare molte ore, di notte, con breve preavviso o nel proprio tempo libero); f) Carichi di lavoro eccessivi (volume di lavoro molto alto da gestire); g) Discriminazione (trattamento sfavorevole o ingiusto sul lavoro in base a determinate caratteristiche); h) Preoccupazioni finanziarie (capacità di sbarcare il lunario della propria famiglia); i) Interferenza lavoro-vita privata (preoccuparsi del lavoro quando non si lavora, sentirsi troppo stanchi dopo il lavoro per fare lavori domestici o avere difficoltà a concentrarsi sul lavoro a causa di responsabilità familiari). Cfr. L. Szekér et al., Psychosocial risks to workers’ wellbeing: lessons from the Covid-19 pandemic, Eurofound Research Report, 2023.
[2] Sono individuate come “job resources”: a) Opportunità di carriera; b) Retribuzione adeguata; c) Orari di lavoro flessibili; d) Supporto da parte del management; e) Partecipazione organizzativa; f) Riconoscimento; g) Utilizzo delle competenze, h) Supporto sociale; i) Autonomia nello svolgimento delle mansioni; l) Importanza delle mansioni; m) Opportunità di formazione; n) Fiducia; o) Voce; p) Conciliazione vita-lavoro. Cfr. L. Szekér et al., Psychosocial risks to workers’ wellbeing: lessons from the Covid-19 pandemic, Eurofound Research Report, 2023.



 @Virgil11Valeria
@Virgil11Valeria